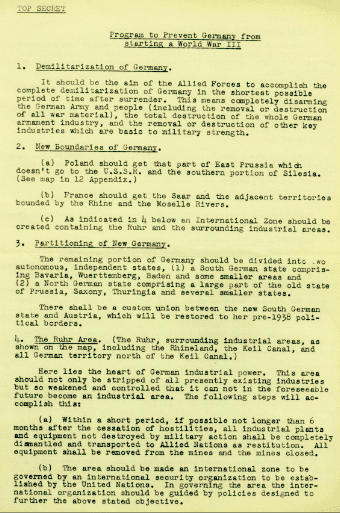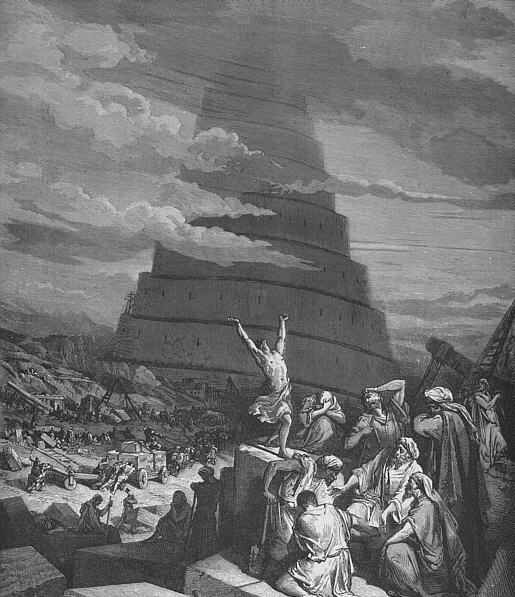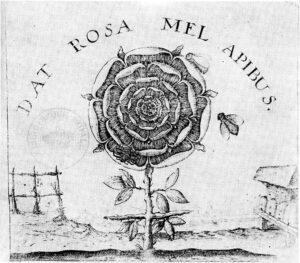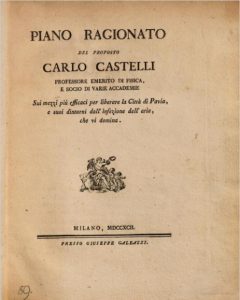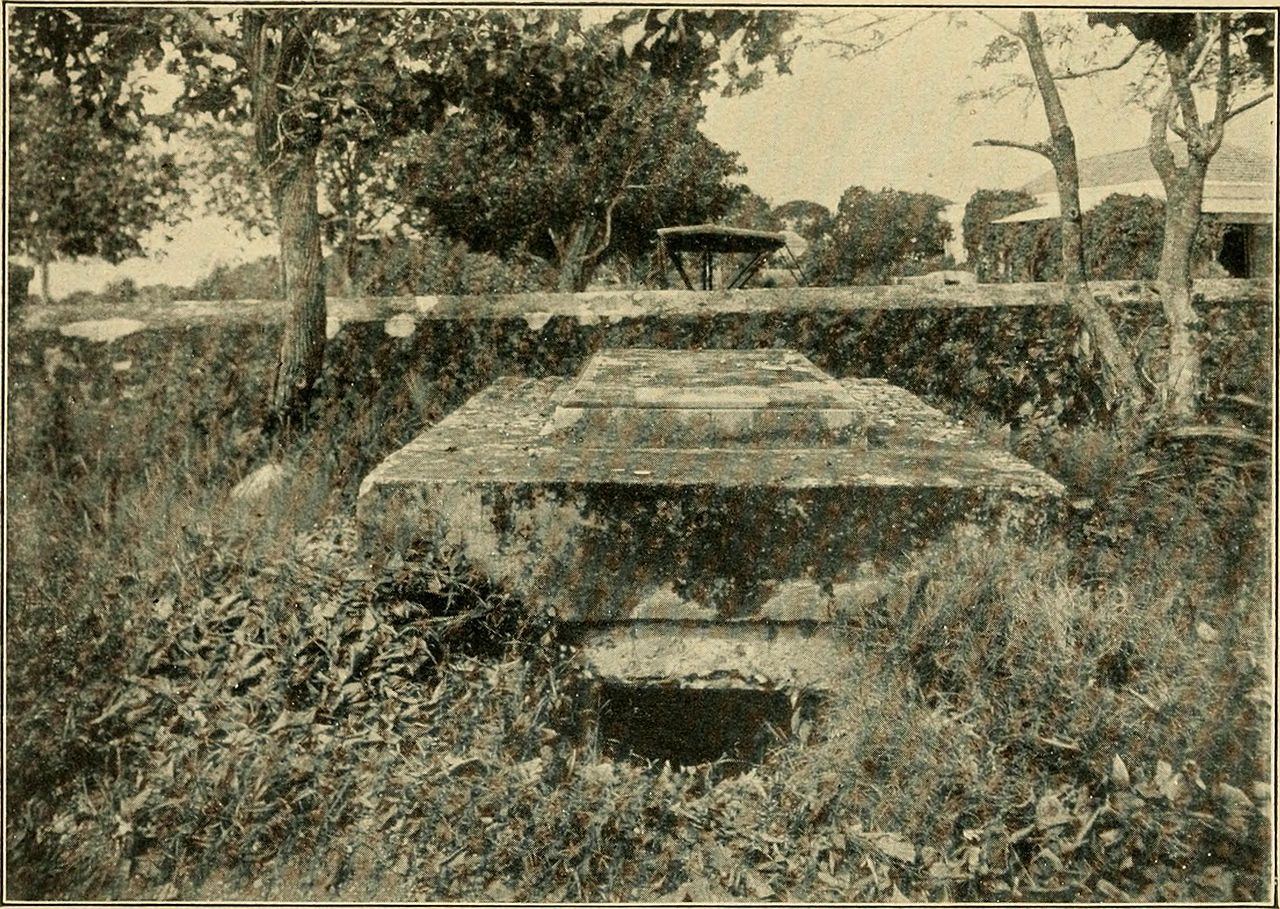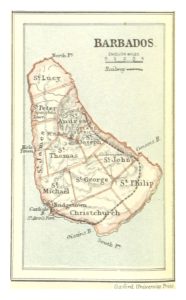1 – Il presidente Franklin D. Roosevelt (alla guida) con il segretario del tesoro Henry Morgenthau Jr. nel 1934.
Henry Morgenthau Junior è stato il Segretario al Tesoro del presidente Roosevelt, di cui era amico di lunga data, dal 1934 al 1945. Come il cognome suggerisce la sua famiglia era originaria della Germania, ma essendo di origine ebraica si può ben immaginare la sua avversione al regime nazista. In ogni caso Morgenthau come l’ampia maggioranza dei Deutschamerikaner, tra cui anche Eisenhower, era un americano in tutto e per tutto senza più alcun legame sentimentale con la patria d’origine. Stando alla sua versione nell’agosto del 1944, mentre era in volo sull’Atlantico diretto in Europa, lesse un memorandum del Dipartimento di Stato sul futuro della Germania con cui era profondamente in disaccordo. Il memorandum teorizzava di tenere sotto controllo il potenziale di guerra della Germania ma si opponeva a una larga privazione dell’industria pesante tedesca, puntando invece a integrarne l’economia in quella mondiale. Le ricerche storiche tendono a identificare il memorandum indicato da Morgenthau con il Report of the Executive Committee on Economic Foreign Policy approvato il 4 agosto del 1944. Morgenthau ne parlò con il generale Eisenhower il 7 agosto presso il suo quartier generale in Inghilterra. Stando ai testimoni una volta ascoltato il memorandum, Eisenhower rispose in maniera molto netta: «Non sono interessato all’economia della Germania, e personalmente non vorrei rafforzarla se questo la renderà più facile per i tedeschi. Le richieste di pace morbida arrivano da persone che pensano di rendere la Germania un bastione contro la Russia. Vero, la forza della Russia era fantastica. Ma la Russia ora ha avuto tutto ciò che poteva digerire, e i suoi problemi attuali la terranno occupata fino a molto tempo dopo che noi saremo morti. L’intera popolazione tedesca è un drogato e non c’è ragione di trattare un drogato gentilmente. La miglior cura è lasciare i tedeschi a stufare nel loro stesso sugo». Morgenthau pensò che Eisenhower fosse d’accordo con la sua visione e argomentò, avendo studiato anche agricoltura, «che le persone che vivevano vicino alla terra tendevano a essere tranquille e pacifiche per natura, a essere solidamente indipendenti e ostili alla tirannia esterna. Perché non fare della Germania una nazione prevalentemente di piccoli agricoltori? Perché non risolvere il problema del prurito al dito del grilletto rimuovendo il grilletto?».

2 – Trattori nel centro di Crenglingen, Baden-Württemberg, 1960 circa. Nelle aree rurali molte famiglie utilizzavano i trattori come mezzi di locomozione, in sostituzione cioè dell’automobile. Se il piano Morgenthau fosse stato applicato in toto, forse l’intera Germania avrebbe avuto questo aspetto.
Qualche giorno dopo Morgenthau ebbe modo di confrontarsi anche con il suo omologo britannico e con Churchill, cogliendo che anche i britannici avevano posizioni diverse; da una parte chi era favorevole a una forte Germania post guerra sia come potenziale mercato sia come parziale contrappeso alla Russia, dall’altra chi credeva che un approccio morbido avrebbe insospettito i russi e reso difficile la collaborazione postbellica tra le tre potenze (più una linea di pensiero intermedia tra le due). Churchill era più interessato a discutere della grave situazione economica britannica ma Morgenthau ebbe l’impressione che, pur con qualche piccola riserva, il primo ministro fosse d’accordo con lui.
Il 12 agosto Morgenthau incontrò alcuni funzionari americani, tra cui l’ambasciatore americano nel Regno Unito John Gilbert Winant sul “problema tedesco”, e aprì la discussione esprimendo il suo desiderio di rendere la Germania un paese di piccoli agricoltori. L’incontro proseguì sulle varie informazioni in possesso circa le intenzioni britanniche e sovietiche sulla Germania, i tempi stimati per la ricostruzione e si concluse con l’intervento dell’assistente di Morgenthau, Harry D. White, sull’obiettivo di evitare che la Germania potesse mai ritentare di condurre una guerra per la conquista del mondo: tutto il resto era secondario, comprese le riparazioni di guerra, e se si fosse reso necessario ridurre la Germania a potenza di quint’ordine allora andava fatto. Nei giorni successivi Morgenthau e White incontrarono Winant e il segretario per gli affari esteri britannico Anthony Eden; dagli incontri emerse che alla conferenza di Teheran[2] si era discusso di un piano, in accordo con l’URSS, di partizione della Germania in tre o cinque parti. Quella decisione però non era stata ancora comunicata ai livelli più bassi e comunque vi erano anche pareri contrari come quello di Sir William Strang, del Foreign Office britannico, preoccupato circa l’effettiva possibilità di controllare una Germania divisa in più parti e relativa capacità di onorare le riparazioni di guerra. Morgenthau concluse il giro d’incontri dicendo che avrebbe riportato al Presidente e al segretario di Stato Cordell Hull ciò che aveva appreso, sintetizzando: «Il Dipartimento di Stato parlava di ricostituzione della Germania in una famiglia di nazioni. Il Tesoro britannico era interessato alla Germania come mercato del dopoguerra. L’esercito voleva fare un buon lavoro. L’European Advisory Commision, ignorando blandamente le istruzioni di Teheran, stava pianificando in termini di Germania unita».

3 – Mietitura in Genfer Straße, Berlino 1946. Nei primi anni del dopoguerra il paese affrontava una grave crisi alimentare e l’agricoltura di sussistenza, inclusi gli orti di guerra, era essenziale per garantire la sopravvivenza della popolazione: anche senza il piano Morgenthau, la Germania assomigliò ugualmente ad una immensa fattoria.
Al ritorno negli Stati Uniti Morgenthau incontrò per primo Hull, il quale leggendo il rapportò sussultò dicendo che non sapeva nulla delle decisioni di Teheran e che non gli era stato permesso di leggere i verbali di quell’incontro; Morgenthau era incredulo e gli chiese che cose intendesse fare con la Germania ma Hull rispose che non poteva fare nulla e che le decisioni erano a un più alto livello e che erano di competenza del Dipartimento della Guerra. Il giorno dopo incontrando Roosevelt Morgenthau gli riferì che nessuno a Washington o a Londra stava lavorando sul “che fare della Germania” seguendo le linee guida emerse a Teheran. Roosevelt non sembrò turbato, pensava che in un colloquio di mezz’ora con Churchill avrebbe potuto correggere la situazione e aggiunse che occorreva essere duri con il popolo tedesco, non solo con i nazisti, perché loro erano stati duri con la nazione americana. Il 25 agosto le divisioni sul che fare emersero nuovamente a seguito della prima lettura da parte del presidente del manuale, consegnatogli da Morgenthau, redatto dallo SHAEF Military Government[3] sulla Germania e nel quale si indicava, tra le altre cose, di conservare l’altamente centralizzato sistema amministrativo tedesco, di utilizzare ufficiali tedeschi nell’amministrazione e di provvedere a fornire una dieta quotidiana da 2 000 calorie alla popolazione mediante le importazioni. Morgenthau commentò con il Presidente che c’erano due tipi di persone: «Chi, come Eden, che crede che si debba cooperare con la Russia, e che dobbiamo fidarci della Russa per la pace del mondo… e gli altri raffigurati dall’osservazione di Mr. Churchill che ha detto ‘Cosa avremo tra la neve bianca della Russia e le bianche scogliere di Dover?’». Roosevelt alzò lo sguardo e disse che apparteneva alla stessa scuola di Eden. Il presidente rilesse poi il manuale e rispose con un memorandum, indirizzato al segretario alla Guerra Henry Lewis Stimson e a Hull, in cui criticava il documento e sottolineava la massima importanza di far realizzare al popolo tedesco che la Germania è una nazione sconfitta individualmente e collettivamente. Il testo fu rivisto e le osservazioni di Roosevelt attestavano la sua vicinanza alla visione di Morgenthau, ma l’obiettivo principale per il presidente era di giungere alla conferenza del Quebec con una politica unificata di negoziazione sul futuro della Germania. Il presidente, in accordo con Stimson, nominò una commissione di gabinetto sul tema a cui avrebbero dovuto partecipare i dipartimenti guidati da Stimson, Hull e Morgenthau.

4 – Mappa della Germania con le suddivisioni proposte dal piano Morgenthau.
Il primo settembre il dipartimento del Tesoro presentò il suo piano, tramite Harry White, che si basava su tre punti principali: cessione di territori ad altre nazioni, suddivisione del territorio, de-industrializzazione. I territori da cedere erano la Slesia e la Prussia Orientale a Russia e Polonia, la zona della Saar alla Francia, e il territorio a nord del canale di Kiel alla Danimarca. Il resto sarebbe stato diviso in tre parti: una zona internazionale che andava da Kiel a nord fino al fiume Meno a sud e che includeva il bacino della Ruhr, uno stato della Germania del nord e uno del sud. Sarebbe poi stata creata un’unione doganale tra lo stato della Germania del Sud e l’Austria (da riportare ai confini pre-1938), mentre non sarebbe stato possibile il commercio tra la zona internazionale e il resto. Tutti e tre avrebbero dovuto contribuire con impianti industriali, equipaggiamento e forza lavoro al recupero di zone devastate dalla guerra altrove. Infine l’amministrazione civile e di polizia sarebbe stata primaria responsabilità delle nazioni confinanti, in modo da ritirare anticipatamente le truppe americane una volta cessati i combattimenti.
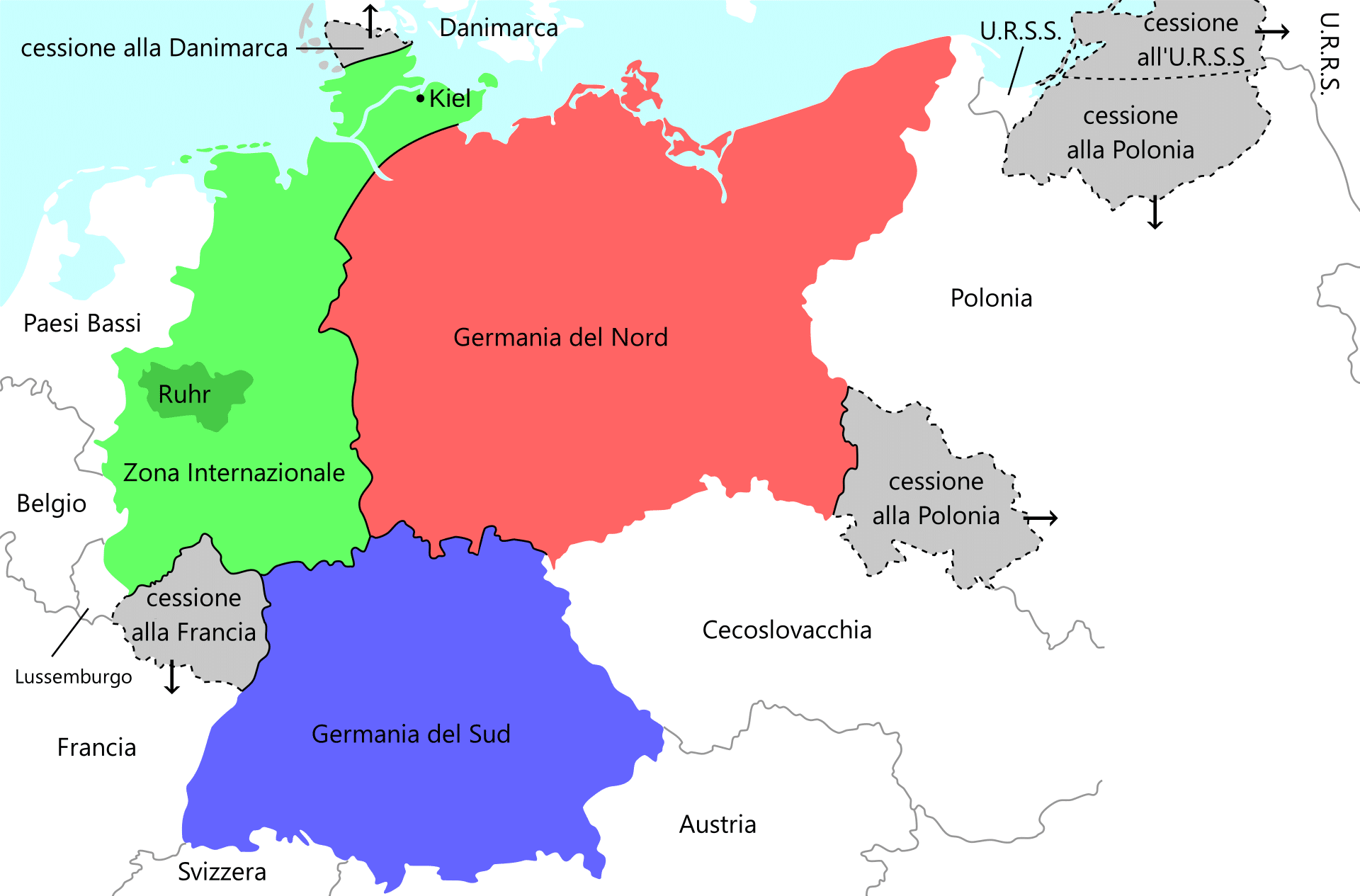
5 – Il “piano Morgenthau” prevedeva la creazione di una Germania del Nord ed una del Sud, una “zona internazionale” ad ovest (che avrebbe incluso la regione della Ruhr) e la cessione di alcune aree (in grigio) ai paesi confinanti: Danimarca, Francia, Polonia e Unione Sovietica.
Il piano del Dipartimento di Stato invece si opponeva a un trasferimento industriale di vasta portata che avrebbe portato milioni di tedeschi a patire la fame o a emigrare; sosteneva che il carbone e la bauxite tedeschi erano necessari al resto d’Europa così come tutti i beni industriali normalmente esportati dalla Germania; si opponeva alla forzata partizione della Germania puntando invece a una divisione della Prussia in piccoli stati e a supportare uno stato federale decentralizzato ma con i confini grossomodo pre-1938. La Germania doveva contribuire alla ricostruzione dell’Europa e al ripristino dell’economia internazionale e poteva anche essere riammessa senza discriminazione nei consessi internazionali. Il commento del dipartimento alla Guerra fu che il piano del Tesoro poneva delle difficoltà all’esercito nell’amministrare il tutto. Due giorni dopo il consigliere presidenziale, ed ex segretario del commercio, Harry Hopkins incontrò i membri del dipartimento di Stato in cui sembrò condividere le loro perplessità e critiche al piano del Tesoro; nel mentre Morgenthau cercava di rafforzare la sua posizione parlando del suo piano direttamente con Roosevelt presentandogli delle bozze in corso d’opera. Lo stesso Morgenthau però non ne fu soddisfatto e chiese ai suoi misure ancora più drastiche: rimozione di tutte le industrie della zona internazionale e spostamento di tutti gli operai e tecnici industriali e rispettive famiglie dall’area; le miniere dovevano essere distrutte; tutte le scuole e università dovevano essere chiuse fino alla riorganizzazione con appropriati testi rieducativi; la zona internazionale doveva essere governata dalle future Nazioni Unite.

6 – Berlino, luglio 1946: agricoltura nel Tiergarten distrutto dalla guerra. Sullo sfondo, da sinistra a destra: memoriale ai soldati sovietici caduti, il Reichstag, la Porta di Brandeburgo.
Seguirono revisioni dei testi e altri incontri con il presidente, in cui Roosevelt sottolineò che non era d’accordo con gli economisti sulla necessità di una forte industria tedesca e per quanto lo riguardava avrebbe voluto rimettere a posto la Germania come paese agricolo. Il comitato si riunì di nuovo il 9 settembre, giorno della partenza di Roosevelt per la Seconda Conferenza del Quebec, arrivando a concordare su gran parte del memorandum ma rimanevano tre punti principali e uno secondario su cui c’erano divergenze di vedute. Le tre principali erano la partizione della Germania, la rimozione o distruzione dell’industria civile, e metodo e misura del trasferimento di industrie e relativo equipaggiamento come riparazione di guerra. La questione secondaria era che fare dei gerarchi nazisti e dei criminali di guerra.

8 – Henry Morgenthau Jr. agricoltore presso la sua fattoria Fishkill Farms nello stato di New York.
Roosevelt partì per il Quebec e i membri del suo governo avevano dedotto che il punto di vista del presidente era: a favore della spartizione della Germania (in base a quanto discusso a Teheran), la sua determinazione a rendere i tedeschi pienamente consapevoli della sconfitta, la sua preoccupazione circa la competitività di una Germania ristabilita e la sua preferenza per una distruzione della forza economica tedesca. Queste idee confermavano la vicinanza di Roosevelt alle idee di Morgenthau e spiegano perché il Segretario del Tesoro redasse il suo piano come una proposta effettiva per il futuro della Germania sconfitta. Roosevelt chiese a Hull e Morgenthau di accompagnarlo in Quebec, ma Hull rifiutò adducendo di essere troppo stanco e di non stare troppo bene e che preferiva quindi lavorare per la conferenza di Dumbarton Oaks.[5]Morgenthau accompagnò per un tratto in treno Roosevelt, fermandosi poi alla propria fattoria nei pressi di Fishkill, ed è probabile che parlarono del piano che aveva infine redatto e che conteneva i seguenti punti principali:
- una larga definizione di demilitarizzazione che includeva dalle basi industriali alla forza militare;
- nuovi confini e un piano di spartizione della Germania;
- l’internazionalizzazione dell’area della Ruhr e lo spostamento di tutto l’equipaggiamento industriale ivi presente agli alleati;
- un piano per le riparazioni di guerra basato sul capitale industriale e umano e non sulla produzione corrente;
- chiusura di tutte le scuole e le università fino alla riorganizzazione dei programmi didattici, controllo di radio e giornali;
- la decentralizzazione statale (nei limiti della partizione);
- nessun mantenimento o rafforzamento dell’economia tedesca da parte del Governo Militare (eccezion fatta per ciò che era necessario per le operazioni militari);
- controllo internazionale sullo sviluppo dell’economia tedesca;
- programma agrario con suddivisione delle grandi proprietà in piccoli appezzamenti;
- trattamento dei criminali di guerra;
- proibizione di uniformi e parate militari per un appropriato periodo di tempo;
- confisca di tutti i velivoli militari e civili, alianti compresi;
- la vigilanza sulla Germania da parte dei vicini in modo da ritirare rapidamente i soldati americani;
Il 12 settembre Morgenthau fu convocato in Quebec dal presidente e arrivò nel pomeriggio del 13; la sera stessa a cena Roosevelt gli chiese di discutere le sue idee insieme a Churchill. Stando allo stesso Morgenthau Churchill borbottò durante la spiegazione, lanciandogli occhiate al vetriolo, e non appena concluse il discorso sbottò poiché quel piano «era come incatenarlo a un tedesco morto». Churchill continuò «Sono totalmente a favore del disarmo della Germania ma non dovremmo impedirle di vivere decentemente. Non si deve permettere che i tedeschi muoiano di fame. Non si può incriminare un’intera nazione». Morgenthau provò a replicare che, durante la loro ultima conversazione a Londra, Churchill temeva un Gran Bretagna indigente nel dopo guerra e che il suo piano avrebbe aiutato la riprese delle esportazioni britanniche ma Churchill ribatté che il suo popolo, una volta raffreddate le passioni, non avrebbe tollerato la repressione della Germania. Roosevelt intervenne per ricordare a Churchill che fu Stalin a Teheran a chiedere che l’industria tedesca fosse distrutta, e dal dibattito che seguì emerse come la preoccupazione di Churchill fosse che il piano Morgenthau comportasse la riduzione del lend-lease, e in generale degli aiuti americani per il dopo-guerra, poiché offrivano il mercato tedesco come compensazione per le merci britanniche. Roosevelt alla fine rinviò le discussioni al giorno dopo. Per la sfuriata di Churchill Morgenthau riferì di non aver chiuso occhio quella notte e annotò: «non ho mai ricevuto una tale fustigazione verbale in vita mia».

9 – Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill alla II Conferenza di Quebec, in Canada, il 12 settembre del 1944. La foto è stata scattata su un terrazzo della Citadelle, fortificazione militare del XIX secolo a Quebec City.
A mezzogiorno del 15 settembre Roosevelt firmò l’impegno degli Stati Uniti ad aumentare gli aiuti del lend-lease per la felicità di Churchill che aveva le lacrime agli occhi; a seguire Churchill volle leggere il memorandum compilato da Morgenthau e dal suo fidato amico il visconte Cherwell[6] per trovare una convergenza sul futuro della Germania. Non soddisfatto Churchill ne dettò uno nuovo più duro per l’incredulità, e l’ostilità, del suo ministro degli Esteri Eden che contestò che lui e il primo ministro si erano esposti pubblicamente su una posizione diversa. Infastidito Churchill tagliò corto rimbrottando al suo ministro che «il futuro del mio popolo è in gioco e quando dovrò scegliere tra il mio popolo e il popolo tedesco, sceglierò il mio popolo». Nella nuova bozza Churchill acconsentì, su richiesta di Roosevelt, che l’industria sarebbe stata repressa in tutta la Germania e non solo nella Ruhr. Fu quindi letto il nuovo documento di 226 parole in cui si stabiliva la conversione della Germania «in un paese principalmente agricolo e pastorale[7] nel suo carattere» che Roosevelt sottoscrisse scarabocchiando “O.K. F.D.R.”, mentre Churchill scrisse le sue iniziali e la data “W.S.C. 159”. Probabilmente Roosevelt e Churchill si erano accordati sul fatto che il documento doveva tranquillizzare i sovietici, sia mostrando accordo sulle richieste di Stalin a Teheran sia fugando i loro timori di una pace separata tra occidentali e nazisti alle loro spalle. La conferenza in Quebec era conclusa e Morgenthau annotò di essere tremendamente felice per aver ottenuto ciò che sperava dettato direttamente da Churchill.

10 – «Vogliamo il carbone, vogliamo il pane»: manifestazione a Krefeld nel marzo del 1947. Gli oppositori del Piano Morgenthau temevano che un’economia puramente agraria non sarebbe stata in grado di sfamare la numerosa popolazione tedesca e che gli occupanti alleati nei territori tedeschi avrebbero presto dovuto affrontare una rivolta e un’anarchia su larga scala.
Il 21 settembre il piano apparve sui quotidiani americani, su imbeccata di esponenti dell’amministrazione contrari alle idee di Morgenthau, e Goebbels lo usò come mezzo di propaganda per incitare il popolo tedesco a combattere strenuamente. Il 28 settembre, durante un pranzo al ministero del Tesoro, il generale George Marshall si lamentò con Morgenthau che la pubblicità del suo piano stava aumentando la resistenza tedesca e il ministro si difese dicendo che non era certo a opera sua la pubblicazione del piano, ma che in ogni caso da soldato il generale doveva riconoscere l’importanza di impedire ai tedeschi di scatenare un’altra guerra mondiale; Marshall rispose che i soldati americani non volevano che i tedeschi fossero trattati duramente. Nel mentre Roosevelt decise di sospendere la decisione sulla Germania concordata in Canada. Stando alla moglie Eleanor la pressione della stampa indusse il presidente ad accantonare momentaneamente il piano e a rimandare la decisione a tempo debito, mentre altre fonti sostengono che il ripensamento fu dovuto al fatto che non ne avesse ben compreso tutte le conseguenze. Il 3 ottobre durante un pranzo con il segretario di stato Henry Stimson, che esortava il presidente a trattare la Germania con «cristianesimo e gentilezza», Roosevelt sostenne che l’idea di rendere la Germania un paese agricolo era una sciocchezza e che lui non aveva mai approvato una cosa del genere; Stimson gli mostrò il documento da lui firmato e Roosevelt ne fu sconcertato ma non è dato sapere se fingesse o se fosse conseguenza della malattia.
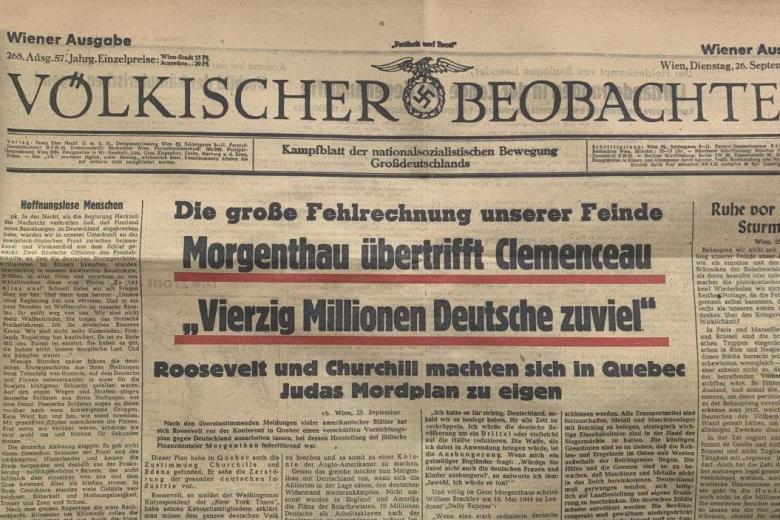
11 – «’Quaranta milioni di tedeschi sono troppi’ in Quebec, Roosevelt e Churchill fanno proprio il piano del genocidio ebraico»: titolo in prima pagina del giornale nazista Völkischer Beobachter (“Osservatore Popolare”) del 26 settembre 1944, dopo la fuga di notizie del Piano Morgenthau. L’organo di stampa del NSDAP lamentava pure pubblicamente che gli americani avessero copiato ai nazisti l’idea del genocidio: questi mascalzoni yankee.
Sempre a ottobre Churchill volò a Mosca per incontrare il grande assente della conferenza in Quebec. Stalin era per le condizioni dure da applicare alla Germania, poiché a suo dire altrimenti i tedeschi avrebbero iniziato una nuova guerra ogni venticinque – trenta anni. I due discussero di vari aspetti ed equilibri nel post guerra e il primo ministro inglese si meravigliò di quante poche divergenze avessero. Churchill scherzò con Stalin affermando che era un peccato che quando Dio creò il mondo loro due non fossero stati consultati; Stalin apprezzò la battuta e rispose «è stato il primo errore di Dio». Il ministro degli Esteri Molotov chiese a Churchill cosa pensasse del piano Morgenthau e il premier inglese riferì che Roosevelt non era molto contento di come era stato accolto. Nel mentre Morgenthau soffriva per il gran baccano sulla stampa, nell’opinione pubblica e all’interno dell’amministrazione che la pubblicazione del suo piano aveva generato, sentendosi trattato ingiustamente e vittima di attacchi antisemiti. Non aveva tutti i torti considerando che anche Roosevelt temeva i sentimenti filo-nazisti, minoritari ma comunque presenti, della società americana: tra questi vi era padre Charles Coughlin, un prete cattolico diventato popolare alla radio che si era scagliato contro gli ebrei (e contro Morgenthau) per tutti gli anni ’30 finché non fu messo a tacere dalla stessa Chiesa Cattolica statunitense. Mentre il dibattito infuriava arrivò anche il momento della campagna elettorale per via delle elezioni presidenziali del 7 novembre 1944 con cui Roosevelt si aggiudicò un quarto mandato.
Nel febbraio del 1945 si tenne la conferenza di Yalta a cui seguirono nuove bozze interne all’amministrazione presidenziale sul futuro della Germania. Il 23 marzo Roosevelt approvò un nuova bozza che ricalcava quello che diventerà noto come documento JCS 1067 (reso pubblico nell’ottobre del 1945), il quale prevedeva dure condizioni tanto che Morgenthau ne era soddisfatto. A fine marzo i sovietici erano a poco più di 50 kilometri da Berlino. Il 2 aprile il generale Marshall segnalò a Roosevelt che l’intelligence dell’esercito stimava imminente la sconfitta tedesca e che Hitler avrebbe posto fine alla sua vita “coraggiosamente e drammaticamente”, con il rischio che restasse una forza psicologica con cui combattere per decenni. Quello che l’intelligence americana ignorava era che Hitler aveva anche segretamente approvato e firmato il suo piano che non aveva nulla da invidiare al piano Morgenthau: le miniere dovevano essere allagate, gli impianti elettrici e telefonici dovevano essere distrutti, non dovevano rimanere grandi impianti industriali utilizzabili.
Qualche giorno dopo, l’11 aprile Morgenthau andò a trovare Roosevelt a Warm Springs, in Georgia, con l’intenzione di convincere il presidente a concedere l’autorizzazione a pubblicare un libro sul futuro della Germania. Morgenthau rimase scioccato dalle condizioni di salute di Roosevelt. I due cenarono assieme e Morgenthau descrisse il progetto del libro che voleva pubblicare dopo la vittoria della guerra, specificando che uno dei capitoli che voleva scrivere sarebbe stato su come sessanta milioni di tedeschi potessero nutrirsi. Roosevelt diede il suo beneplacito e Morgenthau non poteva sapere che quella era stata l’ultima cena di Roosevelt.
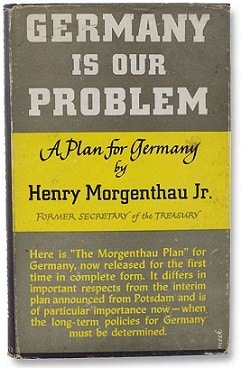
12 – Copertina della prima edizione di Germany is our problem del 1945.
Nei mesi che seguirono l’esercito americano applicò la direttiva JCS 1067 in una Germania devastata. Nel 1947 il difficile contesto postbellico convinse il presidente Truman e l’amministrazione americana a cambiare approccio: il 5 giugno il nuovo Segretario di Stato generale George Marshall presentò all’Università di Harvard lo European Recovery Program (piano Marshall) e a luglio la direttiva JCS 1067 fu sostituita dalla JCS 1779. La Storia della Germania occidentale e dell’Europa al di qua della “Cortina di Ferro” prese quindi la strada che conosciamo. ∎
Note
- [1]Il nome in codice “Guardia al Reno” era volutamente ingannevole per coprire la pianificata offensiva nelle Ardenne.↩
- [2]La conferenza a cui Roosevelt partecipò viaggiando sulla corazzata USS Iowa, con qualche piccolo intoppo come raccontato qui. ↩
- [3]SHAEF: Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force.↩
- [4]Hull proponeva di mantenere la popolazione al livello di sussistenza.↩
- [5]La conferenza di Dumbarton Oaks, nei dintorni di Washington, si tenne dal 21 agosto al 7 ottobre 1944, e in essa si posero le basi per la nascita dell’organizzazione delle Nazioni Unite.↩
- [6]Cherwell in precedenza lo aveva invitato a riflettere sul piano Morgenthau perché si trattava di scegliere su chi tra britannici e tedeschi doveva soffrire nel dopo guerra.↩
- [7]Per alcuni dello staff del Dipartimento del Tesoro l’aggiunta del termine pastorale era per screditare l’intero piano, ma va detto che nell’inglese britannico pastoral non aveva nessuna accezione riprovevole.↩
Bibliografia
- Rampini, Federico I cantieri della storia. Ripartire, ricostruire, rinascere. Mondadori, 2020. ISBN: 978-8804732280
Gareau, Frederick H. “Morgenthau’s Plan for Industrial Disarmament in Germany” in The Western Political Quarterly, vol. 14, no. 2, 1961, pp. 517–34. JSTOR
Chase, John L. “The Development of the Morgenthau Plan Through the Quebec Conference” in The Journal of Politics, vol. 16, no. 2, 1954, pp. 324–59. JSTOR
- Morgenthau, Henry Jr. Germany is Our Problem. New York: Harper & Brothers, 1945.
- Beschloss, Michael R. The Conquerors: Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler’s Germany, 1941-1945. New York: Simon & Schuster, 2002. ISBN 978-0743244541
“Directive to Commander in Chief of United States Forces of Occupation Regarding the Military Government of Germany” 26 aprile 1945. In Office of the Historian – Foreign Service Institute, United States Department of State. Web.
Immagini
- 9 febbraio 1934 [PD] U.S. National Archives and Records Administration / Franklin D. Roosevelt Library
- Crenglingen, circa 1960, foto di Willem Van de Poll – [↕PD] Dutch National Archives / Commons
- Berlino, 1946 – [CC BY-SA 3.0] Deutsche Fotothek / Commons
- dal libro di Morgenthau Germany is our problem (op. cit.) – [PD] Commons
- Silvio Dell’Acqua [CC BY-SA 4.0] basato su mappa di Erinthecute/Commons
- Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum – [PD] Commons
- .Quebec City, 12 settembre 1944. Foto di Arthur Rothstein – [PD] U.S. National Archives and Records Administration / Commons
- [fair use] da The Higlands Current
- Berlino, luglio 1946. Bundesarchiv, Bild 183-M1015-314 / Donath, Otto [CC BY-SA 3.0] Commons
- Krefeld, 31 marzo 1947. Bundesarchiv, Bild 183-B0527-0001-753 [CC BY-SA 3.0] Commons
- Prima pagina del Völkischer Beobachter del 26 settembre 1944 – [fair use] da “Was hinter dem Morgenthau-Plan wirklich steckte“, Welt 6-11-2021
- copertina della prima edizione (1945) di Germany is our problem di Henry Morgenthau Jr. (op. cit.) – [PD] Commons
Che queste siano le pietre guida ad una età della ragioneNon sempre un monumento è eretto a ricordo di un personaggio storico o a un avvenimento del passato, come l’etimologia della parola stessa (dal latino monere, “ricordare”) suggerirebbe: ne esistono infatti che celebrano una nazione, un’idea, un concetto (come il progresso o la libertà, ad esempio), ma anche il futuro o il destino dell’uomo. In cima ad una collina nella contea di Elbert, nella Georgia rurale ben lontana dai centri del potere mondiale, ve n’era uno particolarmente enigmatico: alto 5,87 metri e realizzato interamente in granito – oltre mille tonnellate – era costituito da quattro grandi lastre verticali disposte a “X” e da un pilastro centrale, il tutto sovrastato da una tavola orizzontale. Ed aveva anche qualche rudimentale funzione di osservatorio astronomico e meridiana solare.
A renderlo celebre non furono però le sue caratteristiche, le dimensioni imponenti — e nemmeno la bellezza se vogliamo, quanto invece i suoi misteri e la sua folle storia. Esistono certamente monumenti così antichi che si è persa la memoria di chi li abbia costruiti e perché, ma non era certamente questo il caso: le Georgia Guidestones risalivano appena al 1980, la costruzione è ben documentata e l’inaugurazione fu ripresa da una televisione locale. Nonostante ciò, l’identità di chi abbia voluto e soprattutto finanziato quest’opera rimane oscura e l’unico uomo a conoscerla ha giurato di non rivelarla mai. E poi c’era quello strano “decalogo”, inciso in otto lingue — una per ognuna delle facce delle quattro grandi lastre — che recitava:
MANTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000
IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE
Mantieni l’Umanità sotto 500,000,000
in perenne equilibrio con la natura.
GUIDE REPRODUCTION WISELY
IMPROVING FITNESS AND DIVERSITY
Guida saggiamente la riproduzione
migliorando salute e diversità
UNITE HUMANITY WITH A LIVING NEW LANGUAGE
Unisci l’Umanità con una nuova lingua viva
RULE PASSION — FAITH — TRADITION —
AND ALL THINGS
WITH TEMPERED REASON
Domina passione, fede, tradizione
e tutte le cose
con sobria ragione
PROTECT PEOPLE AND NATIONS
WITH FAIR LAWS AND JUST COURTS
Proteggi popoli e nazioni
con giuste leggi e tribunali imparziali
LET ALL NATIONS RULE INTERNALLY
RESOLVING EXTERNAL DISPUTES
IN A WORLD COURT
Lascia che tutte le nazioni si governino internamente
risolvendo le dispute esterne
in un tribunale mondiale
AVOID PETTY LAWS AND USELESS OFFICIALS
Evita leggi poco importanti e funzionari inutili
BALANCE PERSONAL RIGHT WITH SOCIAL DUTIES
Bilancia i diritti personali con i doveri sociali
PRIZE TRUTH — BEAUTY — LOVE
SEEKING HARMONY WITH THE INFINITE
Apprezza verità, bellezza e amore
ricercando l’armonia con l’infinito.
BE NOT A CANCER ON THE EARTH —
LEAVE ROOM FOR NATURE —
LEAVE ROOM FOR NATURE
Non essere un cancro sulla terra —
lascia spazio alla natura —
lascia spazio alla natura
Un epitaffio decisamente sui generis che ha dato adito ad ogni tipo di speculazione, in particolare per quel passaggio inquietante che suggeriva di mantenere l’umanità sotto i 500 milioni di abitanti e di guidare «saggiamente la riproduzione»: parole che molti videro come un invito allo sterminio di massa (nel 1980 si era già 4,3 miliardi…) ed alla selezione eugenetica. In un quadro del genere, anche i riferimenti alla natura da innocuo misticismo hippie sembrerebbero assumere le tinte lugubri del culto nazista dell’Heimat.[1] I cardini fondanti della teoria del cosiddetto novus ordo mundi furono scolpiti nella roccia a caratteri cubitali: era davvero la dimostrazione dell’esistenza di un governo ombra mondiale, come ritengono i complottisti? Chi altri può aver voluto un monumento che invocasse la drastica riduzione della popolazione del pianeta? Partiamo dal princípio. Tutto iniziò con un uomo elegante e una sonnolenta cittadina di provincia, come qualsiasi storia da folklore cospirazionista americano.
Voglio comprare un monumento

2 – Sede della Elberton Finishing Co. a Elberton, anni ’80.
Era un caldo venerdì pomeriggio di giugno del 1979 ad Elberton, quando un uomo di mezza età elegantemente vestito entrò in una casetta di legno in Tate Street. Era l’ufficio della Elberton Granite Finishing Corporation, una delle 85 aziende di lavorazione del granito presenti nella cittadina, nota anche come “la capitale del granito” per le trenta cave presenti nei dintorni e l’importanza che il minerale igneo riveste nell’economia della città: qui, persino lo stadio è fatto di 100 mila tonnellate di granito blu.
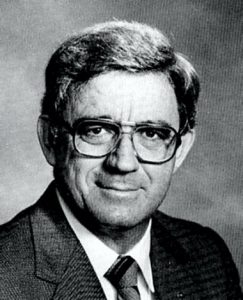
3 – Joe H. Fendley Senior; presidente della Elberton Granite Finishing Co. (1981).
«Questo è un matto»[2] — pensò Fendley, mentre cercava un modo per liberarsene velocemente. Cosa evidentemente che non gli riuscì, visto che rimase ad ascoltarlo una ventina di minuti durante i quali, però, la sua attenzione era stata catturata dall’oratoria intelligente e persuasiva dello sconosciuto. Questi si presentò come Robert C. Christian e disse di rappresentare «un piccolo gruppo di onesti americani che credono in Dio e nella patria»; aggiungendo che i committenti vivevano fuori dalla Georgia e volevano semplicemente «lasciare un messaggio per le future generazioni».
L’uomo fornì a Fendley una descrizione sommaria del monumento ed anche qualche misura, esprimendosi stranamente in unità metriche. Abituato invece (da buon americano) ai piedi e pollici del sistema consuetudinario, il marmista ricorse alle tavole di conversione per avere conferma di ciò che sospettava: nessuna lastra di quelle dimensioni era mai stata realizzata ad Elberton. Armato di calcolatrice, stilò un preventivo di massima ottenendo la cifra stratosferica di 40 mila dollari,[3] che sperava avrebbe scoraggiato lo straniero. Invece, l’uomo chiese dove trovare un banca affidabile e allora Fendley gli diede un nome ed un indirizzo.

4 – Edificio della Granite City Bank in Heard Street a Elberton, anni ’80 (ora sede della Regions Bank).
Poco dopo a Elberton, in Heard Street, presso la sede della Granite City Bank — la banca del granito della città del granito — il telefono squillò nell’ufficio di granito del direttore, Wyatt C. Martin. Dall’altra parte del cavo c’era l’amico Fendley, che gli preannunciava la visita di «uno svitato che vuole comprare qualche strano monumento». Trenta minuti dopo, il forestiero era seduto di fronte a lui. Nonostante l’iniziale perplessità cui la telefonata di Fendley aveva certo contribuito, il direttore fu colpito dall’abito costoso e dall’eloquio colto ed educato del visitatore (evidentemente non comuni in zona), e decise quindi di dargli una chance. R. C. Christian espose nuovamente il progetto, chiedendo che l’istituto fecesse da mediatore finanziario per l’operazione. Dovendo chiudere, il direttore lo invitò a fare due passi giù per Heard Street fino ad Elberton Plaza, dove gli mostrò orgogliosamente l’imponente fontana — inutile dirlo, in granito — realizzata tre anni prima per il bicentenario dell’indipendenza degli Stati Uniti.
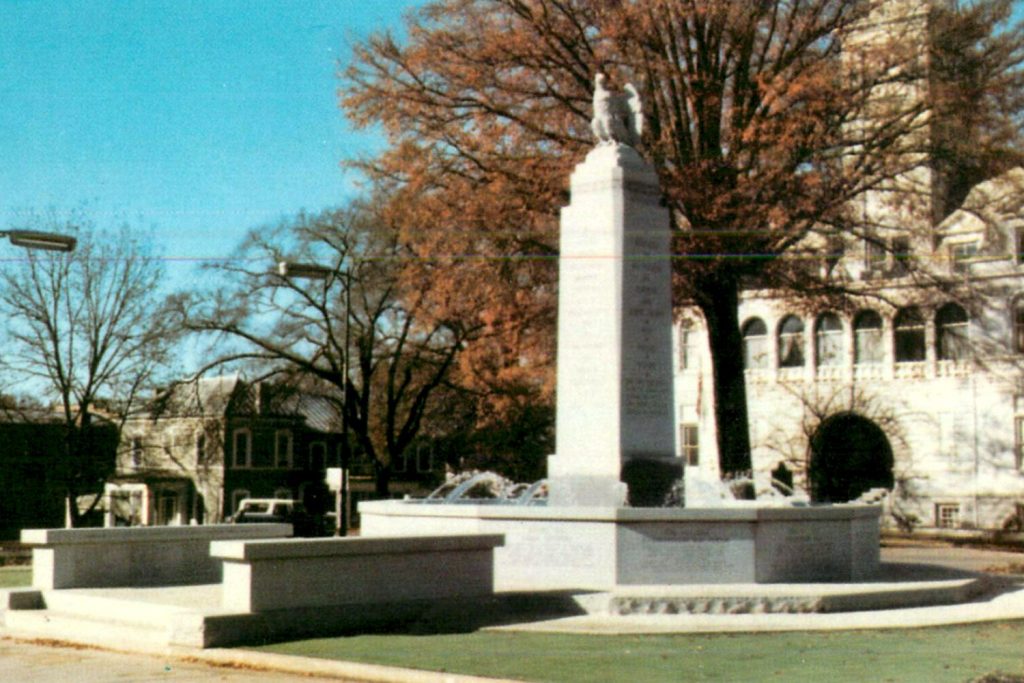
5 – La fontana in granito del Bicentenario ad Elberton, primi anni ’80.
Congedandosi, l’uomo chiese appuntamento per dopo il weekend sostenendo che avrebbe passato i due giorni successivi a esplorare la zona dall’alto con un aereo a noleggio. Il lunedì successivo, puntuale, si presentò in banca per formalizzare l’accordo ma per passare dalle parole ai fatti c’era un busillis da superare: come lui stesso aveva ammesso, Robert C. Christian non era il suo vero nome ma uno pseudonimo, scelto in riferimento alla sua «fede cristiana». I finanziatori volevano infatti che la loro identità rimanesse segreta per sempre, perché avrebbe potuto distogliere l’attenzione dal manufatto e dal suo significato: «il messaggio inscritto nella pietra non sarà fazioso, né nazionalistico, né in alcun modo politico. Sarà per tutta l’umanità» — disse. Uno pseudonimo ed una promessa di soldi non sono però credenziali accettate da una banca, pertanto Martin avrebbe dovuto procedere ad una verifica dell’identità e della situazione finanziaria dell’intermediario. Ciò avrebbe ovviamente compromesso l’anonimato, su cui però i misteriosi committenti non sembravano disposti a transigere.
I due giunsero così ad un compromesso: Martin avrebbe firmato un accordo di riservatezza impegnandosi a non rivelare mai a nessuno la vera identità di Christian; sarebbe stato il suo unico interlocutore e depositario legale; infine avrebbe distrutto tutti i documenti relativi all’operazione una volta terminata. A queste condizioni, Christian avrebbe fornito a Martin le sue generalità e le informazioni necessarie perché potesse indagare sulla propria situazione personale e finanziaria. Martin fu così la sola altra persona, oltre a Fendley, ad aver consapevolmente conosciuto il misterioso Robert C. Christian (in realtà ce ne sarà una terza in seguito) e — dei due — l’unico a conoscerne la vera identità, un segreto che non avrebbe mai tradito.
Christian lasciò Elberton, promettendo che sarebbe tornato in pochi giorni. Fendley e Martin discussero tra loro del misterioso visitatore e di quanto accaduto quel surreale weekend ma, dopo diversi giorni senza notizie, Fendley iniziò a convincersi di essere stato vittima di una delle elaborate burle dei confratelli dello Shrine, un service club massonico filantropico (quelli con il fez granata) di cui era un membro attivo.
Non mi ha mai scritto due volte dallo stesso posto.Wyatt Martin, direttore della Granite City Bank
Invece Christian tornò davvero, portando con sé un modello in legno del monumento accompagnato da un fascicolo di una decina di pagine di specifiche tecniche dettagliate, così precise che Fendley vi riconobbe una certa competenza tecnica. L’aspetto era quello di un moderno dolmen megalitico e, come Christian aveva preannunciato alla sua prima visita, avrebbe dovuto avere anche funzioni astronomiche in qualche modo simili a quelle attribuite anche al cromlech[4] di Stonhenge (vere o presunte, ma sicuramente in gran parte mitizzate).
Dalle parole ai fatti
Il venerdì successivo alla seconda visita di R. C. Christian, il direttore della banca telefonò a Fendley informandolo che aveva appena ricevuto un deposito di diecimila dollari: era il segnale che i lavori potevano inziare. Oltre che della Elberton Granite Finishing, Fendley era presidente anche della cava Pyramid Quarries da cui si estraeva il granito grigio-blu scelto per l’opera. Furono necessarie settimane di lavoro e uno sforzo incredibile di uomini e macchinari per cavare a 114 piedi di profondità (35 m) gli enormi blocchi di granito “Pyramid blue” e sollevarli fino al livello del terreno. Ma una volta in superficie, l’impresa era tutt’altro che conclusa poiché sarebbe stato necessario lavorare le pietre secondo le precise specifiche richieste dalla committenza. La direzione dei lavori fu affidata al soprintendente Joe Davis, tagliapietre da una vita, e i migliori artigiani disponibili furono reclutati per formare una squadra apposita, una task force dedicata esclusivamente a questo progetto. E nessuno di loro aveva mai visto niente di simile ad Elberton.

6 – Sotto la supervisione di Joe Davis, gli operai sbozzano le lastre.
In un vicino capannone in disuso della Oglesby Granite fu allestita l’officina per i lavori di finitura dove le pietre furono sbozzate, tagliate e portate alle dimensioni richieste dal progetto, quindi furono sabbiate le facce delle tavole mentre i bordi delle stesse e il pilastro centrale furono lasciati volutamente “a spacco”, perché rispecchiassero il più possibile l’aspetto del granito appena cavato come richiesto da R. C. Christian. Infine furono realizzate le forature per la stella polare, gli equinozi e la meridiana solare, per le quali fu richiesta la consulenza di un astronomo dell’università della Georgia. Mentre macchine ed utensili a mano davano forma al granito, un’altra “squadra” era impegnata nel tradurre i testi dall’inglese alle 11 lingue richieste:[5] i consulenti furono reclutati tra i docenti del locale college e della University of Georgia per la scritta sull’architrave «che queste siano le pietre guida ad una età della ragione» nelle 4 lingue “antiche” (sanscrito, babilonese cuneiforme, greco classico e geroglifici egiziani), un giovane immigrato madrelingua residente ad Elberton per il cinese e le restanti traduzioni arrivarono addirittura dalla sede delle Nazioni Unite di New York, grazie ad un concittadino di origine pakistana con conoscenze diplomatiche.[6]
Ottenuti i testi (nonostante qualche errore di ortografia[7]) fu necessario realizzare e posizionare le maschere stencil per ognuno dei circa 4 mila caratteri, quindi incidere e sabbiare nuovamente le iscrizioni: un lavoro che richiese mesi per essere terminato. Questo compito fu affidato all’esperto sabbiatore Charlie Clamp, il quale avrebbe udito una «strana musica e voci incoerenti» mentre incideva nel granito le parole «to an age of reason». Secondo Fendley fu «solo un altro dei misteri che circondavano le pietre-guida e il loro scopo», secondo altri fu invece il bourbon della Georgia. In realtà, ciò che Clamp raccontò di aver udito erano solo le imprecazioni degli altri operai: il resto è leggenda.[8]
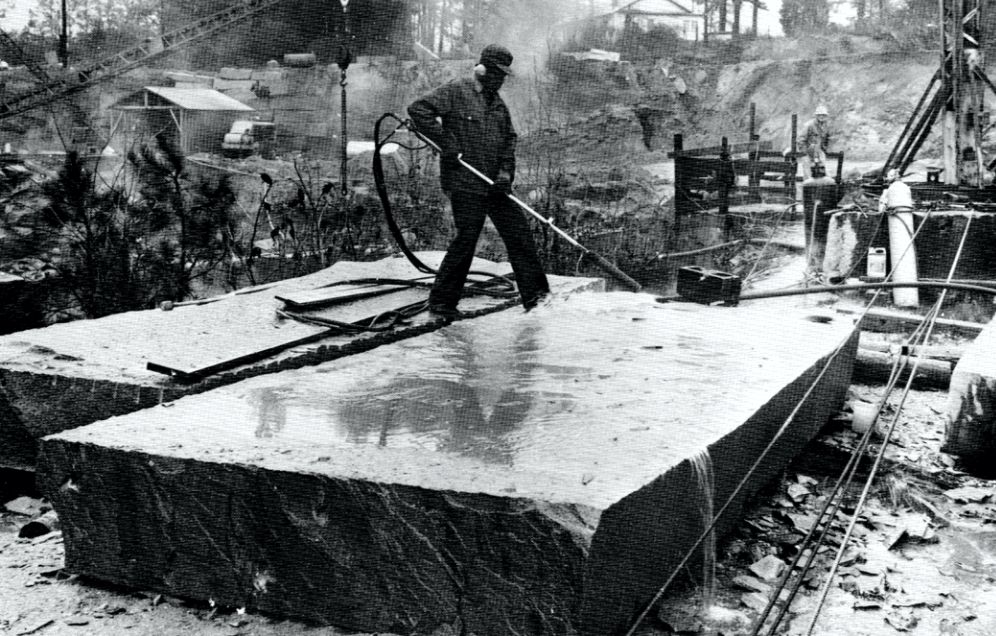
7 – Fiammatura delle lastre di granito.
Il luogo
Restava però ancora da scegliere il luogo. Innanzitutto, perché proprio la Georgia? I misterofili ipotizzano che stesse cercando la vicinanza con il 33º parallelo, cui sono attribuite fantasiose connessioni con massonerie, alieni ed esoterismo. In realtà R. C. Christian disse a Wyatt Martin di voler erigere il monumento in un luogo remoto, lontano dai turisti, e di aver scelto la Georgia per la disponibilità di granito e per il clima mite che avrebbe favorito la conservazione del monumento. E poi la sua bisnonna era originaria di questo stato. Successivamente avrebbe ristretto la zona intorno alla Contea di Hancock, nella Georgia centrale a ovest della città di Augusta. Ma gli imprenditori di Elberton volevano che l’opera restasse nella loro contea per promuovere la cittadina e l’industria locale: in particolare Frank Coggins, imprenditore del granito titolare delle Coggins Industries, eminente cittadino di Elberton e amico di Fendley cui quest’ultimo si era rivolto per consulenza. Coggins convinse Martin e Fendley a “pilotare” la scelta del sito in modo che restasse nei paraggi, così Martin a sua volta persuase R. C. Christian a erigere il monumento nella contea di Elbert facendo leva su due fattori: innanzitutto perché la vicinanza con le cave avrebbe ridotto drasticamente i costi; in secondo luogo si giocò la carta del valore simbolico poiché quest’area era considerata dai Cherokee “il centro del mondo”.[9] Christian trovò la proposta ragionevole e, dopo aver visitato almeno otto siti, il luogo ideale fu individuato in quello proposto da Wayne Mullenix, un costruttore edile confratello di Fendley nella locale loggia massonica, che era già stato incaricato da quest’ultimo della realizzazione delle fondazioni.

8 – Il costruttore Wayne Mullenix (in ginocchio), il supervisore Joe Davis (sinistra) e Joe Fendly (destra) effettuano un sopralluogo sul sito di costruzione.
Some assembly required
«Non mi vedrai mai più» gli disse, prima di uscire dalla porta e scomparire per sempre.
Dopo l’acquisto del terreno, la missione di Mr. Christian ad Elberton era conclusa. Prima di andarsene passò a salutare e ringraziare Fendley nell’ufficio della Elberton Granite Finishing Co., la casetta di legno in Tate Street dove si erano incontrati la prima volta: «non mi vedrai mai più» gli disse, prima di uscire dalla porta e scomparire per sempre. Da quel momento, R. C. Christian avrebbe comunicato solo con Wyatt Martin, il direttore della Granite City Bank, sempre scrivendo ogni volta da una città diversa per non essere rintracciabile.

9 – Realizzazione delle fondazioni. Si intuisce la pianta ad “X” con il pilastro centrale.
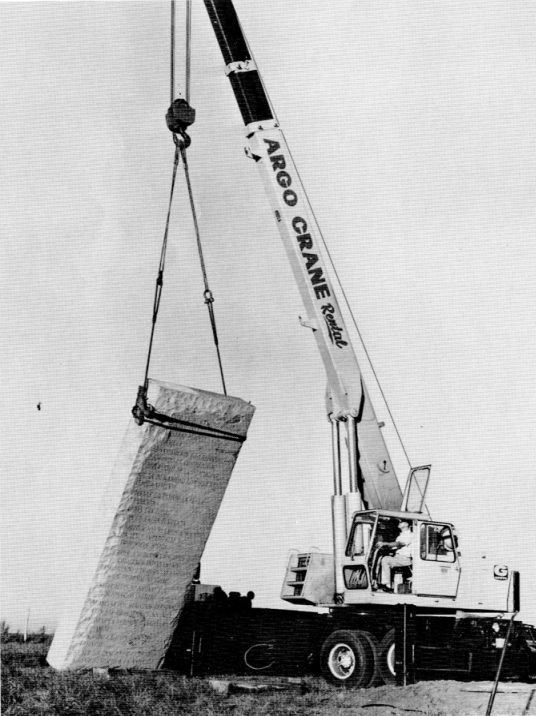
10 -La gru gommata della Argo Crane Rental solleva e posiziona la prima lastra.
Stonehenge americana
La somiglianza con Stonehenge non era del tutto casuale: lo stesso R. C. Christian, che aveva viaggiato molto visitando l’Europa ma anche altri paesi come il Bangladesh e l’India, disse di esserne rimasto molto colpito poiché quelle pietre avevano sconfitto il tempo, la natura e anche tutti i tentativi di comprenderne il significato. Citò anche lo scrittore Henry James (1843 – 1916), il quale scrisse di Stonehenge nel suo libro di viaggio English Hours (1905):
You may put a hundred questions to these rough hewn giants as they bend in grim contemplation of their fallen companions, but your curiosity falls dead in the vast sunny stillness that enshrouds them…Puoi porre un centinaio di domande a questi giganti rozzamente abbozzati mentre si piegano in cupa contemplazione dei loro compagni caduti, ma la tua curiosità si spegne nell’immensa quiete soleggiata che li avvolge…

11 – Il cromlech di Stonehenge (quello vero) nello Wiltshire, Inghilterra.
A differenza però di Stonehenge, il cui significato restava celato dietro l’inscalfibile silenzio dei suoi megaliti, il monumento di Mr. Christian (o chiunque ci fosse dietro di lui) avrebbe invece dovuto lasciare un messaggio diretto ed intelligibile alle future generazioni: «vogliamo erigere un monumento — spiegheranno gli ignoti committenti in una lettera inviata dopo la realizzazione — che mostrerà silenziosamente le nostre idee quando ce ne saremo andati. Ci auguriamo che meritino una crescente accettazione e che, con la loro silenziosa tenacia, accelerino in minima parte l’avvento dell’età della ragione».[13]
Il “messaggio” fu scolpito nel granito in otto lingue — inglese, spagnolo, swahili, hindi, ebraico, arabo, cinese mandarino e russo — scelte dai committenti perché rappresentano gli idiomi più diffusi: già all’epoca si stimava che il 92% della popolazione mondiale avrebbe potuto comprenderne almeno una. Qualora poi l’umanità, a seguito di una catastrofe, avesse perso memoria del proprio passato (un tema ricorrente nella narrativa sci-fi) vi avrebbe trovato una “stele di Rosetta” post-apocalittica con la quale imparare a decifrare le lingue perdute confrontando tra loro i testi. Decisamente più oscura invece la scelta delle quattro lingue antiche per la scritta sui quattro bordi della tavola sommitale, che a metà tra didascalia e vaticinio recita: «che queste siano le pietre guida ad una età della ragione», da cui il nome di “Georgia Guidestones”. Non essendo però il babilonese una lingua propriamente diffusa — in Georgia, poi — è lecito supporre che l’intenzione fosse più che altro di rafforzare l’aura sfingea del manufatto.
Infine, i sopravvissuti avrebbero potuto tornare alle Pietre per ristabilire un orientamento ed un calendario grazie alle prerogative astronomiche del dolmen. Su queste ultime, si può dire che fossero indubbiamente suggestive, ma piuttosto rudimentali e nemmeno tanto precise come si legge ovunque. Nel pilastro centrale c’era una fessura orizzontale, soprannominata la “buca delle lettere”, allineata con il sorgere del sole agli equinozi solari, ma per ottenere ciò era sufficiente che la fessura fosse rivolta ad est. Poi c’era un foro che puntava invece, piuttosto grossolanamente,[14] alla stella polare. Ma anche questo “osservatorio” fu abbastanza semplice da realizzare: è sufficiente fare un buco in direzione nord con l’angolo di azimuth corretto, che alla latitudine di Elberton è 34° (un calcolo abbastanza semplice anche per un astrofilo dilettante), e attraverso di esso si vedrà sempre la stella polare, sic et simpliciter. La funzione di “bussola” citata da Christian si riduceva quindi al fatto che si potesse ricavare la direzione del polo nord celeste e quindi grossomodo il nord geografico, cosa peraltro fattibilissima anche senza particolari strumenti. Sebbene non dichiarato sulla lapide esplicativa, le quattro grandi lastre verticali avrebbero avuto anch’esse un allineamento: stando al libro Georgia Guidestones del 1987, una sorta di opuscolo promozionale pubblicato dalla stessa Elberton Granite Finishing che aveva costruito il monumento, sarebbero state orientate verso «i limiti della migrazione della Luna durante l’anno[15]», espressione non chiarissima ma che sembrerebbe riferirsi ai punti di levata e tramonto della luna ai “lunistizi”.[16] Una feature sicuramente molto evocativa, ma totalmente inutile per una futura generazione di sopravvissuti: il ciclo di retrogradazione non ha alcuna applicazione pratica rilevante, nemmeno dal punto di vista agricolo. A che serve sapere dove sorge la luna ogni 18,6 anni? Se si escludono eventuali significati simbolici o rituali non pervenuti, forse semplicemente pareva brutto che le lastre verticali non fossero allineate con qualcosa pure loro.

12 – La meridiana solare: a mezzogiorno la luce colpisce il pilastro centrale attraverso il “foro gnomonico” nell’architrave.
La caratteristica più complessa e forse di qualche utilità pratica sarebbe stata invece la meridiana calendariale “al negativo”,[17] che fornirebbe le funzioni di “calendario” e “orologio” menzionati da R. C. Christian. Un foro gnomonico[17] nella tavola sommitale lasciava infatti penetrare un fascio di raggi solari, che a mezzogiorno colpisva il pilastro centrale (noto come gnomen stone) e, in funzione della differente altezza del sole durante l’anno, avrebbe dovuto indicare anche la data. La meridiana in effetti esiste, ma né la linea del mezzogiorno né un diagramma delle date furono mai stati realizzati, per cui sarebbe rimasta incompleta e di fatto inutilizzabile come calendario.[18] Come a Stonehenge, molti si dilettarono a cercare riferimenti astronomici e numerologici nelle proporzioni, misure ed orientamenti delle Pietre; ma astronomicamente non c’è altro da aggiungere.

13 – Georgia Guidestones: è visibile la “buca delle lettere” nel pilastro centrale.
No money no party
Il monumento rimase parzialmente incompleto rispetto al progetto originale. Oltre al già citato quadrante della meridiana, era prevista anche una piramide sopra la tavola sommitale ma l’idea fu abbandonata per contenere i costi e anche il quadrante della meridiana non fu realizzato. Sulla lapide esplicativa c’era anche indicata la presenza di una “capsula del tempo” sepolta sotto il monumento, in realtà apparentemente mai posata: ma quello della capsula del tempo è un mistero su cui torneremo più avanti. Infine, negli auspici degli sponsor[19] le attuali guidestones dovevano essere solo l’inizio di un complesso monumentale più ampio. Grazie al supporto di altri “gruppi” con le medesime inclinazioni escatologiche, sarebbero stato erette altre dodici lastre dette moonstones (pietre della Luna), disposte in circolo intorno come un cromlech, sulle quali avrebbero trovato posto altre 24 lingue tra le quali l’italiano, il francese e il tedesco.
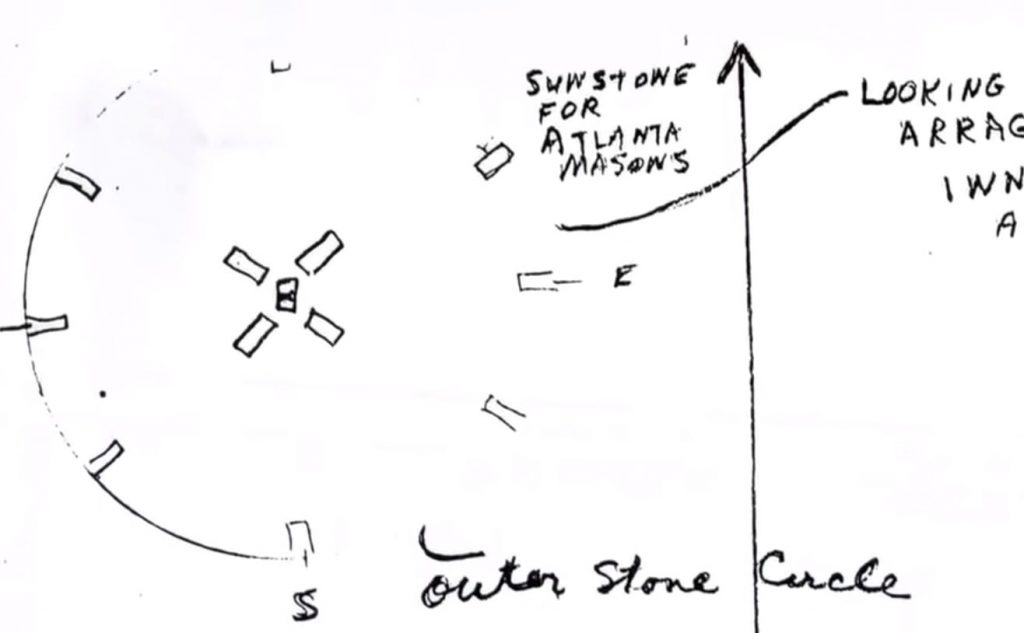
14 – Uno dei disegni originali di R. C. Christian, conservato negli archivi Coggins Industries, mostra il circolo di pietre esterne (le moonstones). È indicata anche una misteriosa sunstone «per i massoni di Atlanta» in direzione N/E, proprio come la sunstone o “pietra del tallone” di Stonehenge.
Dopo un ultimo lavaggio con getti di vapore ed acido per far risplendere il granito in tutta la sua bellezza, il monumento era finito e pronto per l’inaugurazione. Da quella prima visita di Christian a Elberton la sua realizzazione aveva richiesto poco più di nove mesi.
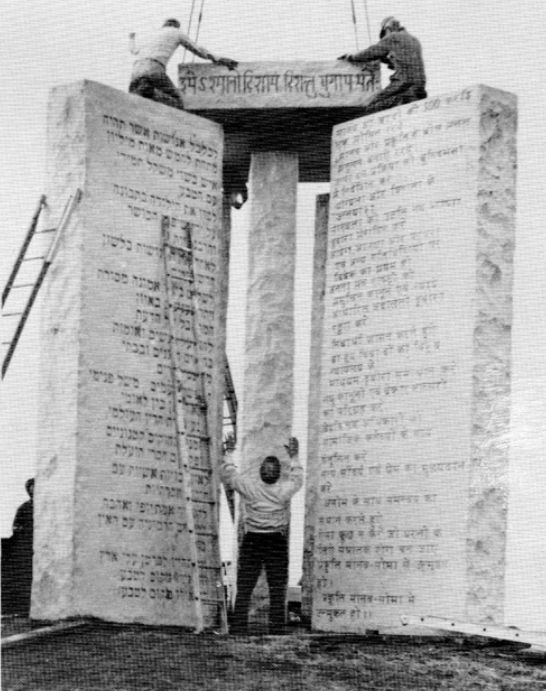
15 – Posa della pietra sommitale il 12 marzo 1980.
La “X” indica sempre il punto dove atterrare
Alla cerimonia di presentazione parteciparono naturalmente il banchiere Martin, il costruttore Fendley e le altre persone coinvolte nella realizzazione, ma anche il sindaco di Elberton, Jack Wheeler, e il presidente della contea, Billy Ray Brown; il presidente e vicepresidente dell’associazione nordamericana dei costruttori di monumenti (rispettivamente William Hutton e John Dianis), inviati della stampa locale e una troupe televisiva di Atlanta. L’onore di svelare il monumento, tagliando simbolicamente la corda che tratteneva i teli di plastica nera in cui era stato avvolto, spettò però all’avvocato Doug Barnard Jr, deputato del partito democratico al congresso degli Stati Uniti e originario della vicina Augusta. All’evento assistette una piccola folla tra le cento[21] e le quattrocento[22] persone, ma il grande assente fu proprio R. C. Christian che non presenziò alla nascita della sua “creatura” e — per quanto ne sappiamo — non verrà mai più ad Elberton.

16 – Georgia Guidestones, le lastre in inglese e russo (vista da nord). Furono paragonate ai «dieci comandamenti dell’Anticristo».
A non mancare invece fin da subito furono le polemiche, soprattutto in ambiente cristiano fondamentalista. A cominciare da un ardente predicatore locale, tale James Travenstead, che già il giorno dell’inaugurazione sollevò dubbi sull’autoproclamata cristianità degli “sponsor” dichiarando che le pietre-guida «sono per gli adoratori del sole, per la venerazione di un culto, per gli adoratori del diavolo»;[21] che un giorno addirittura vi si sarebbero tenuti dei sacrifici (poi non dite che non ve l’avevo detto) e che il foro della meridiana sarebbe servito a far defluire il sangue. Il “messaggio” in forma di decalogo, per di più inciso sulla pietra, fu visto da alcuni come una parodia sacrilega delle tavole della legge della tradizione biblica, tanto che si parlò di “dieci comandamenti dell’Anticristo”. Lo stesso Wyatt Martin, che era evangelico, fu stigmatizzato dai correligionari per aver avuto un ruolo chiave nella realizzazione dell’«opera del diavolo».[23]
Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile.Genesi: 11,69
L’affiliazione alla loggia locale di Fendley, di Mullinex, di Clamp e di molti di coloro che lavorarono al monumento (come però della maggior parte delle persone che lavoravano nell’industria del granito a Elberton) fece anche pensare ad un coinvoglimento della massoneria. Wyatt Martin però non ne faceva parte e smentì categoricamente questa possibilità. Molti, più pragmaticamente, ipotizzarono che il tutto fosse una trovata pubblicitaria architettata da Coggins, Martin e Fendley per promuovere il turismo e le imprese locali di una cittadina fino ad allora nota solo per due cose: il Granite Bowl, lo stadio in granito da 20 mila posti sede della locale squadra di football “Blue Devils”; e la sepoltura di tale Daniel Tucker, un pastore metodista, agricoltore, traghettatore[24] e patriota[25] vissuto tra il ‘700 e l’800, noto per essere (forse) l’Old Dan Tucker della omonima canzone popolare americana cantata anche da Bruce Springsteen:
Get out the way, Old Dan Tucker
You’re too late to get your supperOld Dan Tucker (canzone popolare americana)
Ciò che fecero sicuramente — come del resto ammisero senza problemi — fu solo adoperarsi perché il monumento restasse ad Elberton. Per placare le maldicenze e allontanare ogni sospetto, Martin e Fendley si sottoposero ad un test con il poligrafo di fronte ai giornalisti del quotidiano locale Elberton Star, superandolo senza problemi. Il che però non fece altro che rafforzare i sospetti sulla natura diabolica del monumento.
Certo è che l’apparentemente impenetrabile anonimato degli sponsor favorì le intrepretazioni più fantasiose. I millenaristi accolsero la misteriosa realizzazione delle Pietre Guida come un segno dell’approssimarsi della tanto attesa fine del mondo, ma il monumento fu non solo méta di curiosi e predicatori. Anche hippie e wiccan, vedendovi un nuovo Stonehenge e più a buon mercato di un volo intercontinentale per raggiungere quello vero, vi si recavano a celebrere i propri riti pagani. Destò persino l’interesse degli appassionati di UFO i quali, con una logica un po’ naïf, sostenevano essere un sito di atterraggio per astronavi extraterrestri: avendo infatti il monumento dall’alto la forma di una “X”, appariva loro ovvio che dovesse indicare il punto dove atterrare.[23]
Il governo mondiale
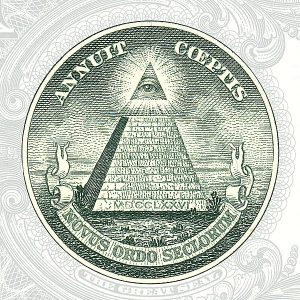
18 – Sigillo con il motto Novus Ordo Seclorum sul retro della banconota da 1 Dollaro americano.
Il principale collegamento con questa teoria starebbe nel fatto che nella lista delle cose da fare del presunto shadow cabinet ci sarebbe un piano segreto per la riduzione della popolazione del pianeta e, guarda caso, la prima regola delle Pietre Guida invita proprio a mantenere l’umanità sotto i 500 milioni di unità. Essendo appunto un segreto, avrebbero quindi pensato bene di scolpirlo discretamente nel granito a lettere cubitali. Fosse vero, comunque, non ci sarebbe molto di che preoccuparsi, visto che da allora la popolazione mondiale è quasi raddoppiata e tutto quello che il nuovo ordine mondiale sarebbe riuscito a fare in proposito è un dolmen in Georgia.
I Rosacroce
Iniziali di Christian a parte, però, quella dei rosacroce è una teoria che sembrerebbe vantare ben altri indizi in suo favore. Nel febbraio del 1997, ad esempio, un altro personaggio che volle restare anonimo si presentò in un ufficio di Elberton: stavolta era quello di Carolyn Cann, editrice dell’Elberton Star. Si presentò solo come “L’amico del Maestro delle Rose”[28] — e già qui ci si potrebbe fare un’idea — dicendo di rappresentare un gruppo di cristiani (di nuovo) che vorrebbero abbellire il monumento, e donò una cifra sufficiente a finanziare la piantumazione di cespugli di rose intorno al sito, «per la rosa blu che deve arrivare». Lasciò anche un articolo delirante intitolato “The Georgia Guidestones Guides the Stone”,[28] zeppo di simbolismi tra la proto-newage dell’esoterista britannica Alice Bailey[29] e il rosacrucianesimo pop di Lewis (con tutti quei riferimenti alle rose ed alla «solida roccia»[30]) e se ne andò promettendo altri articoli e denaro per le panchine, ma nessuno avrà mai più notizie di lui. C’è però dell’altro.
Il mistero della capsula del tempo
Come abbiamo visto, stando alla lapide esplicativa ci sarebbe anche una “capsula del tempo” sepolta sei piedi più sotto (circa 1,8 metri), ossia un contenitore sigillato destinato ad essere riaperto in un’epoca futura. L’indicazione «to be opened on …» fu però lasciata in bianco e non esiste alcuna indicazione su quando dovesse essere disseppellita, né documentazione su cosa potrebbe contenere. Qualcuno, sui forum misterofili, arrivò ad ipotizzare che la capsula dovesse contenere un virus che, alla riapertura della stessa, avrebbe avverato la “profezia”riducendo la popolazione mondiale a mezzo milione di abitanti. In realtà nemmeno lo spazio per la data di posa fu compilato, quindi è probabile che semplicemente non sia mai esistita come confermò anche Martin, la persona più a stretto contatto con R. C. Christian,[31][8] mentre Fendley disse di non saperne nulla. Forse si trattò di un’idea abbandonata per mancanza di fondi, come fu per la piramide, il quadrante della meridiana e le moonstones.
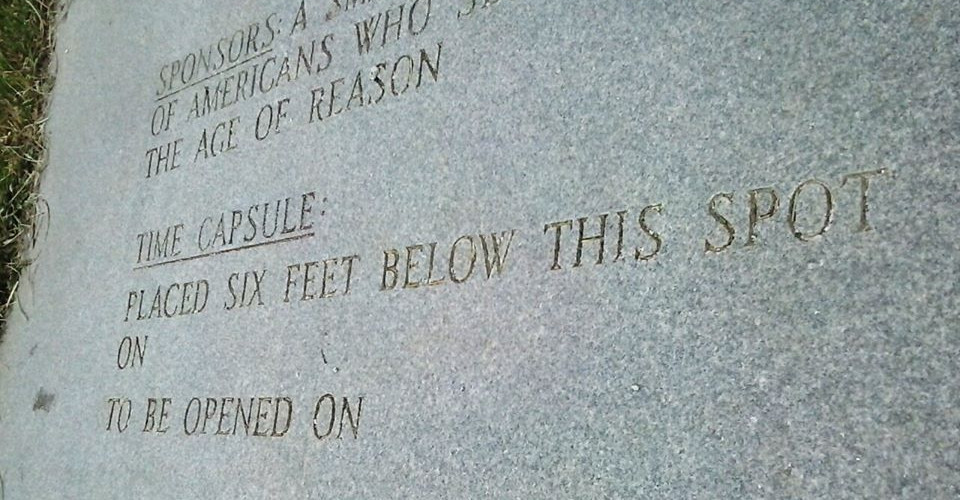
20 – Istruzioni per la riapertura della capsula del tempo: la data è stata lasciata in bianco.
Più enigmatico fu invece Mullenix, che quando fu intervistato nel 2010[8] disse di non esserne a conoscenza per poi aggiungere però che «quando la lapide sarà rimossa lo scoprirete […] non so quando accadrà, per essere onesti». Il mistero poi si infittisce perché, su richiesta dello stesso R. C. Christian, copie di alcuni disegni e documenti relativi alla realizzazione materiale del monumento furono trasmessi anche a Fendley e Coggins: il primo li distrusse[8] mentre il secondo li conservò e si trovano ancora negli archivi delle Coggins Industries. Tra questi, spicca uno strano ciclostilato[8] scritto a macchina nel quale si legge:
TO WHOMEVER COMES ACROSS THIS PRESENTING:
CONTAINED HEREIN ARE KEYS THAT HAVE BEEN AWAITED TO BE PLACED HERE IN PROPER SEQUENCING AND IN PROPER ORDER TO ANNOUNCE THE RETURN AND THE ACTIVATION OF THOSE EVENTS OF PROPHECY THAT SIGNAL THESE EVENTS.
Si riferisce forse a qualche tipo di “chiavi”, che avrebbero dovuto essere contenute nella capsula del tempo? Se così fosse questi «eventi della profezia» dovrebbero verificarsi a partire dal ritrovamento delle “chiavi”, quindi in un futuro imprecisato. Ma quali sarebbero questi “eventi”? Il testo continua asserendo che «coloro che hanno custodito questo grande mistero e l’evoluzione della specie umana stessa stanno tornando» e che qualcosa sarebbe «iniziato». Di seguito vengono espressamente citati il monumento e la persona di R. C. Christian, insieme ad un nome che abbiamo già incontrato:
THIS MONUMENT KNOWN AS THE GEORGIA GUIDE STONES [sic[32]] SHALL FIND THREADS UNTO THE REVELATION OF THE MYSTERY IN THE NAME R. C. CHRISTIAN OTHERWISE KNOWN UNTO THAT CONTINGENCY THAT IS RESPONSIBLE FOR THE ERECTION OF THIS MONUMENT AS CHRISTIAN ROSENKRETZ [sic] (1378-1484).
Al netto del refuso (Rosenkreutz) è proprio lui, il presunto fondatore dell’ordine dei Rosacroce. C’era forse del vero, allora, nel legame tra R. C. Christian e la più misteriosa organizzazione della storia? Seguono delle strane istruzioni:
THIS PRESENTATION OF KEYS UPON THE FINDING OF IT IS TO BE DELIVERED TO THE ELBERTON STAR. THE ELBERTON STAR IS TO DELIVER IT TO THE ATLANTA ROSICRUCIAN SOCIETY.
Chiunque avesse ritrovato la capsula del tempo, quindi avrebbe dovuto consegnarne il contenuto all’Elberton Star? Il quotidiano sostiene di non sapere nulla di tutto ciò e di non aver mai ricevuto alcuna “chiave” né indicazioni in merito. Una Società Rosacruciana di Atlanta, indicata come destinataria finale delle chiavi, effettivamente esiste: si tratta di una sede locale della Grande Loggia americana dell’Antico Mistico Ordine della Rosa Croce (AMORC), una delle organizzazioni che rivendicano una discendenza dai leggendari Rosenkreutzer ma fondata in realtà a New York nel 1915 dall’americano Harvey Spencer Lewis. La Loggia di Atlanta, però, non rilasciò mai alcuna dichiarazione ufficiale in merito.[8] Il monumento aveva forse qualcosa a che fare con la Società Rosacruciana? Erano loro i “massoni di Atlanta”[33] cui — secondo i disegni di Christian — avrebbe dovuto essere dedicata la “pietra del sole”? Forse R. C. Christian tentò semplicemente di coinvolgerli per ottenere finanziamenti per il suo progetto.
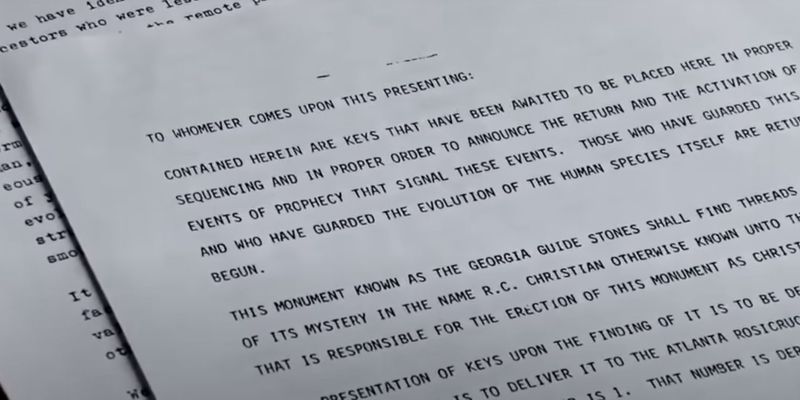
21 – «TO WHOMEVER COMES ACROSS THIS PRESENTING»: il ciclostilato ritrovato nell’archivio delle Coggins Industries. Di quali chiavi parla, e dove sarebbero contenute?
Il testo prosegue citando un «mistero sincronicistico[34]», una misteriosa sequenza numerica e asserendo che «solo coloro in grado di comprendere la rosa e il suo ritorno [ancora la rosa…] saranno in grado di decifrare i codici e le chiavi qui contenute». Uno scritto criptico e misticheggiante, troppo — ed anche un po’ sgrammaticato: molto lontano dallo stile pratico, lineare e se vogliamo piuttosto “laico” di R. C. Christian, il quale tra l’altro non era così fissato con le rose od altre metafore rosacrociane. Forse è opera di qualcun altro del suo “gruppo” o un membro della loggia di Atlanta? Ma non si può nemmeno escludere che si tratti di un falso finito chissà come nell’archivio della Coggins, la trollata di un burlone o un documento apocrifo prodotto da qualche altro stralunato di quelli che la contea di Elbert sembrava inevitabilmente attirare.
Come quello che, nel 2009, asportò un cubo di 6 pollici di lato dallo spigolo in alto della “tavola” in inglese. Quattro anni più tardi, nel 2013, l’uomo fu arrestato dalla polizia mentre cercava di rimetterlo a posto nel cuore della notte: confessò di averlo rubato per «ragioni esoteriche e numerologiche personali» e di averlo voluto restituire al monumento perché «non voleva più avere quel peso»[35] (circa 10 kg, ma non credo si riferisse alla massa). Nell’estate 2014, però, un altro cubo comparve a riempire la “tacca” lasciata da quello originale. Quando fu rimosso, sulle sei facce apparve quello che sembrava un codice: MM, JAM, 16, 8, 20, 14. Dopo che i misterofili si erano scervellati per decifrare la sequenza, si scoprì che semplicemente era stato messo da una coppia che voleva così ricordare le proprie nozze all’ombra del monumento: MM e JAM erano le iniziali; 16, 8 e 2014 la data della cerimonia.[35]
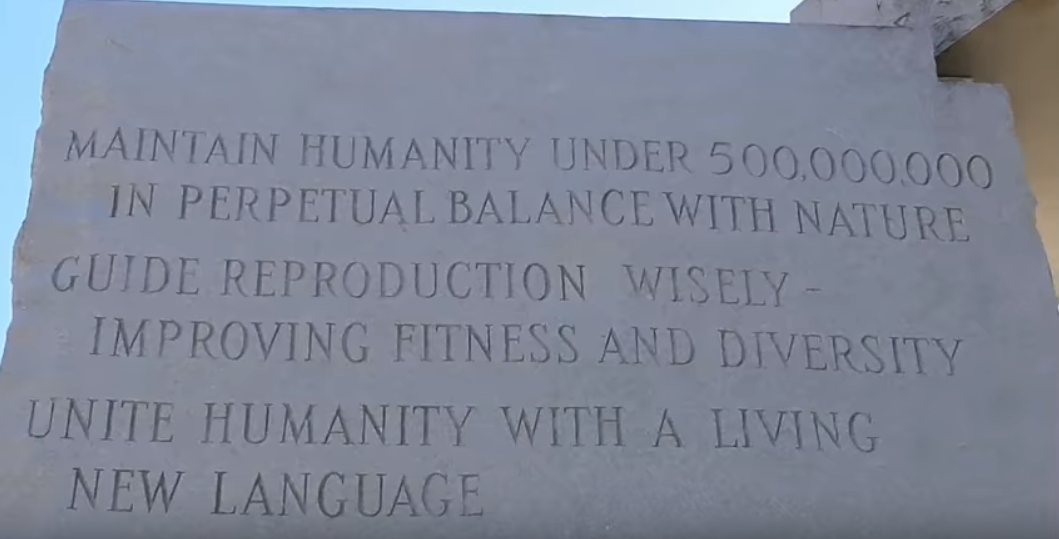
22 – «Mantieni l’umanità sotto i 500 000», senz’altro la frase più controversa del decalogo delle Guidestones. In alto a destra si nota il “cubo” asportato nel 2009.
Mantieni l’Umanità sotto 500,000,000
Al di là delle speculazioni dietrologiche, per capirci di più sullo scopo del monumento dovremmo partire proprio dalle pietre e dal messaggio in esse contenuto. Dalle parole di Mr. Christian, sappiamo che era destinato a lasciare ai sopravvissuti di un evento catastrofico le indicazioni su come ricostruire una civiltà e ad aiutarli con le proprie funzioni astronomiche (in realtà, per lo più simboliche come abbiamo visto). Ma quale catastrofe avrebbe riportato l’umanità ad un livello quasi preistorico, tale da necessitare un simile manufatto? Nella già citata lettera[13] degli ignoti committenti, questi confermano una preoccupazione allora molto attuale, quella per una guerra nucleare:
Our thought reflect our analysis of the problems confronting humanity in this dawing of the atomic age.[36]Il nostro pensiero riflette la nostra analisi dei problemi che l’umanità deve affrontare in questo periodo di oscurità dell’era atomica.
Le Pietre Guida furono infatti costruite nell’epoca della guerra fredda, un lungo periodo in cui l’America conviveva con quella che Kennedy avrebbe definito «una lunga lotta al crepuscolo»,[37] ossia la costante minaccia di un attacco sovietico con armi strategiche. La fine del mondo e il post-apocalittico divennero temi ricorrenti nella narrativa: solo per citare alcune opere, il romanzo Io sono leggenda di Richard Matheson (1954), On the beach di Nevil Shute (1957) da cui l’omonimo film (1959), il romanzo Allarme Rosso di Peter George (1958) da cui il celebre Dr Strangelove di Stanley Kubrik (1964), The Time Machine, film del 1960 bastato su un racconto di H.G. Wells, Il mondo sommerso di J.G. Ballard (1962), il Pianeta delle Scimmie di Schnaffer (1968) e L’incredibile marea di Alexander Key del 1970 (da cui l’anime Conan il ragazzo del futuro di Myazaki), L’ombra dello scorpione di Stephen King (1978), i film L’ultima odissea (1977), Mad Max (1979), The Day After (1983), non ultimo il celebre videogioco Fallout del 1997 (sebbene postumo alla guerra fredda). Se è vero quanto disse R. C. Christian,[38] ossia che lavorava a questo progetto da vent’anni, l’idea del monumento risalirebbe proprio alla fine degli anni’50, quando l’opinione pubblica percepiva un aumento della tensione tra le due superpotenze.[39] In questo contesto, appare chiaro come l’intero “messaggio” — compresi i passaggi più controversi — sia permeato da un’ansia quasi millenaristica per la guerra nucleare e ciò che verrà dopo. Il millenarismo è infatti la credenza, che diventa talvolta spasmodica attesa, nell’arrivo di un cambiamento radicale della società dopo il quale nulla sarà più come prima, che in ambito cristiano viene fatto coincidere con l’apocalisse.

23 – La war room americana nel film Dr. Strangelove di Stanley Kubrick (1964).
Io non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma posso dirvi che cosa useranno nella quarta: pietre![40]Albert Einstein
L’indicazione di mantenere la popolazione del pianeta sotto i 500 milioni di abitanti non sarebbe quindi un’invito allo sterminio di massa (con buona pace dei complottisti) ma si rivolgerebbe ad una futura umanità già al di sotto di quella soglia, a causa di una inevitabile catastrofe globale. E che, nella sciagurata eventualità che ciò accada, dovrebbe attuare un controllo delle nascite per prevenire una nuova sovrappopolazione garantendo una migliore qualità di vita. L’idea non era nuova, già nel 1798 il celebre economista Thomas Malthus aveva pubblicato un Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società nel quale sostenne che l’aumento demografico avrebbe portato ad un impoverimento delle risorse. Proprio nel 1979, quando le Guidestones venivano costruite, la Cina metteva in atto la “politica del figlio unico”, una legge che vietava alle donne di avere più di un figlio per contrastare il fortissimo incremento demografico.
Un nuova lingua viva
Nella lettera, gli sponsor precisarono che non intendevano cancellare i linguaggi esistenti, che anzi dovrebbero essere tutelati in quanto correlati all’identità e alle tradizioni di ogni gruppo umano e culla di letteratura ed arti. Essendo però le lingue locali divisive e spesso pretesto per rivendicazioni di ogni tipo, era necessario un nuovo linguaggio mondiale, che aiutasse a superare le divisioni ed incomprensioni tra popoli. Nessuna lingua esistente sarebbe stata adatta a questo scopo, nemmeno l’inglese (lingua de facto già quasi universale), in quanto limitate dall’essere adatte alle esigenze ed alla cultura dei parlanti madrelingua, né lo sarebbero state le lingue artificiali come l’esperanto o l’interlingua poiché basate su idiomi esistenti dei quali conservano i difetti. Gli sponsor auspicavano invece una lingua pianificata costruita collettivamente su basi completamente nuove, «adatta ai pattern impressi nel nostro sistema nervoso», la cui glossopoiesi avrebbe impegnato diverse generazioni ma che alla fine sarebbe stata talmente universale da permetterci di dialogare direttamente non solo con ogni abitante del pianeta, ma anche con ogni tipo di macchina, senza alcuna intermediazione: un’idea molto lungimirante che, più che all’episodio biblico di Babele, sembra ispirarsi alla fantascienza asimoviana.[41]
L’età della ragione
La mia nazione è il mondo… e la mia religione è fare il bene Thomas Paine
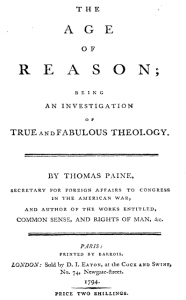
24 – Frontespizio di To an Age of Reason di Thomas Paine (1794).
Il tribunale mondiale e le «giuste leggi»
Le successive righe descrivono conseguenze pratiche di quanto sopra: un mondo regolato dalla ragione dovrebbe proteggere «popoli e nazioni, con giuste leggi e tribunali imparziali». Già dall’Ottocento si faceva strada l’idea di una soluzione arbitrale che evitasse i conflitti armati qualora le vie diplomatiche avessero fallito, ma fu l’esperienza delle guerre mondiali che portò ad istituzionalizzare tale pratica con la creazione delle organizzazioni internazionali. Il mondo dei sopravvissuti avrebbe dovuto proseguire su questa strada, lasciando però «che tutte le nazioni si governino internamente». Quest’ultima enunciazione presuppone però che esista ancora una qualche forma di governo. Un disastro di portata tale da ridurre la popolazione mondiale al di sotto dei 500 milioni di abitanti vedrebbe il collasso delle strutture sociali e della stessa civiltà per come la conosciamo. In una parola sarebbe l’anarchia, che è infatti il tema ricorrente di ogni visione post-apocalittica. Ma l’anarchia non è libertà perché consente la sopraffazione del più forte sul più debole.
L’impulso del solo appetito è schiavitù, e l’obbedienza alla legge che noi stessi ci siamo dati è libertà.[43]Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social, 1762)
Gli individui, lasciati a sé stessi, dovranno quindi riorganizzarsi costituendo un nuovo ordine e l’auspicio è che lo si faccia finalmente con «giuste leggi» in grado di bilanciare «i diritti personali con i doveri sociali», secondo la concezione illuminista di “libertà civile”. E naturalmente evitando «leggi poco importanti e funzionari inutili», obbiettivo auspicabile magari anche senza bisogno di una guerra atomica, ma forse il più difficile da conseguire (come ben sanno gli italiani alle prese con la burocrazia). Nel romanzo Utopia (1516 circa), l’inglese Thomas More immaginava un’isola-stato abitata da una società rinascimentale ideale ispirata alla Repubblica di Platone, dominata dalla razionalità e dalla cultura. L’opera criticava aspramente la proprietà privata ma anche le leggi degli “altri” paesi, troppo numerose, inutili e complesse. L’insula Utopia, progenitrice di tutte le utopie, sembra avere diversi punti di contatto con il futuro edeumonistico immaginato da R. C. Christian: l’uguaglianza dei cittadini, la lingua unica, il culto universale della natura (che in More è identificata con Mitra). Il mondo post-apocalittico descritto dalle Pietre è a tutti gli effetti una utopia, parola coniata proprio dal titolo dell’opera di More.
Armonia con l’infinito
Chiuse infine le questioni più pratiche relative all’organizzazione del nuovo mondo, il messaggio sembra prendere una direzione più spirituale attingendo forse alla parafilosofia new age che proprio in quegli anni si andava diffondendo con il suo variegato paradigma di credenze mistiche, pseudoscienza e gnosticismo neopagano; il tutto votato all’obbiettivo salvifico della scoperta di sé e di una “armonia con il cosmo”. Ciò che accomuna i newager è l’attesa millenaristica dell’arrivo di “nuova era” astrologica: l’Era dell’Acquario, nella quale l’umanità raggiungerà un nuovo livello di consapevolezza. Una nuova era, quella della Ragione, è anche il tema centrale del monumento e del suo messaggio. Volendo potrebbero rientrare nel contesto newagiano anche i riferimenti alla natura, la somiglianza con Stonehenge e le velleità astronomiche del monumento. Una componente new age non sarebbe nemmeno del tutto incompatibile con il dichiararsi “cristiani”, non solo perché è una dottrina sincretica per definizione e spiccatamente inclusivista, ma anche perché in America, fin dall’inizio, la new age trovò consensi proprio tra i gruppi di cristiani fondamentalisti.[44]
Lascia spazio alla natura
Il remoto futuro delle Pietre-Guida è un mondo dove la natura, alleggerita dalla pressione antropica, si riprende i propri spazi. Una visione che oggi definiremmo forse ecopunk. Il disastro di Černobyl’ del 1986 ha dimostrato quanto non si tratti solo di un cliché della narrativa post-apocalittica, ma di uno degli scenari possibili: evacuati gli abitanti, la città di Pripjat’ e la cosiddetta “zona di alienazione” sono diventati un’oasi di tranquillità per la flora e la fauna che hanno iniziato a proliferare indisturbati nonostante la radioattività. Se il disastro fosse su scala mondiale, l’umanità tornerebbe probabilmente ad un livello tecnologico pre-industriale e almeno per un certo tempo non sarebbe in grado di minacciare di nuovo l’ambiente. Ma l’uomo è destinato al progresso ed a un certo punto dovrà scegliere se essere di nuovo un «cancro sulla Terra», sovrasfruttandone le risorse come ha sempre fatto e portare un’altra volta il pianeta al collasso, o «lasciare spazio alla natura» e vivere finalmente «perenne equilibrio» con essa. Le Georgia Guidestones erano insomma un monumento alla speranza che l’umanità, se fosse sopravvissuta alla propria autodistruzione, potesse finalmente costruire una civiltà migliore.
La demolizione
Purtroppo, se mai si verificasse lo scenario ipotizzato dai suoi realizzatori, le future generazioni di sopravvissuti dovranno fare a meno delle Georgia Guidestones per ricostruire una civiltà migliore, perché sono state demolite nel 2022. Negli anni precedenti il monumento fu oggetto di numerosi atti vandalici con vernici e bombolette spray, tanto da spingere le autorità ad installare delle telecamere di sorveglianza. Il 1º maggio di quell’anno Kandiss Taylor, candidata repubblicana per il ruolo di governatore della Georgia, terrapiattista e sostenitrice di varie teorie del complotto, tentò di risollevare le proprie misere sorti elettorali (fu eliminata alle primarie con appena il 3% dei voti) pubblicando un video intitolato “ordine esecutivo #10” in cui attribuiva la costruzione del monumento ad un «regime globale luciferino» (sic), collegando la scritta «mantieni l’umanità sotto 500,000,000» ai vaccini per il covid-19. Promise anche che il suo primo impegno di governo sarebbe stato demolire il «monumento satanico». Alle quattro del mattino del 6 luglio 2022 un’esplosione scosse la casa del costruttore Wayne Mullenix, a circa mezzo miglio di distanza. Una potente bomba, piazzata da un ignoto vandalo, aveva distrutto una delle lastre verticali spargendo pezzi di granito nel campo circostante. Il monumento non crollò, ma le autorità decisero di demolirlo perché ormai pericoloso, e le macerie furono rimosse per prevenire lo sciacallaggio. Le indagini dello Sceriffo di Elberton e della polizia dello stato della Georgia non portarono a nulla, né è dimostrato un collegamento con il video della Taylor che dette la colpa ad un fulmine (mentre i video delle telecamere di sorveglianza mostrano chiaramente una persona non identificata piazzare qualcosa ed allontanarsi in auto prima dell’esplosione) sostenendo che «un atto di Dio ha abbattuto quelle maledette Guidestones».[45] Alla fine di luglio il sindaco di Elberton Daniel Graves annunciò un piano per la ricostruzione della “Stonehenge americana”, ma già l’8 agosto il consiglio comunale votò per restituire il terreno al precedente proprietario,[46] ovvero proprio Mullenix. Il quale si è detto molto dispiaciuto per le pietre guida: «Sono rimasto deluso al pensiero che qualcuno si sia spinto all’estremo per distruggere qualcosa che non ha fatto del male a nessuno, in un modo o nell’altro, per 42 anni. […] Penso davvero che sia un fanatico religioso[45]». Le Guidestones non ci sono più, ma lasciano ancora tante domande senza risposta. Prima fra tutte: chi può aver pensato, voluto e realizzato un simile monumento? Chi si celava dietro il misterioso R. C. Christian?
Tutte le strade portano all’Iowa
Nel 2012 l’ottantunenne Wyatt Martin, ex direttore della Granite City Bank nel frattempo trasferitosi a Greensboro (Georgia), andò con alcuni amici su un vecchio ponte dismesso sul Lago Oconee. Qui bruciarono in un bidone tutta la corrispondenza relativa alle Georgia Guidestones: dopo oltre 30 anni, aveva onorato il suo impegno a distruggere tutti i documenti, che fino ad allora aveva conservato gelosamente in una cassa nella propria autorimessa nella speranza di scriverci un libro. Lo fece per proteggere il segreto che si era impegnato a non rivelare.
I promotori del monumento si definivano «onesti americani che credono in Dio e nella patria», ma la descrizione è piuttosto vaga, perché fede, patriottismo e baseball sono tratti comuni della stragrande maggioranza degli americani. Le tesi che vedono dietro gli “sponsor” l’ombra di potenti organizzazioni segrete come i Rosenkreuzer intente a veicolare chissà quale messaggio o profezia, sembrano smentite dal fatto che il monumento non è stato completato per mancanza di ulteriori fondi e i promessi finanziamenti per i previsti ampliamenti non arrivarono mai. Qualunque tentativo di dare un’identità agli sponsor deve necessariamente passare dal loro emissario R. C. Christian; sempre che questo fantomatico gruppo sia mai esistito e che il promotore e unico finanziatore non fosse egli stesso. Il che però aprirebbe scenari non meno inquietanti, come vedremo tra poco.
Per quanto si sappia, R. C. Christian non tornò più ad Elberton ma mantenne i contatti con Martin, con cui ebbe una fitta corrispondenza amicale, e negli anni successivi i due si incontrarono occasionalmente anche di persona. Christian chiamava da un telefono pubblico all’aeroporto di Atlanta e si davano appuntamento per pranzare insieme ad Athens, che era circa a metà strada. In una lettera del 1998, R. C. Christian aveva rivelato a Martin di avere 78 anni,[8] quindi era nato nel 1920 ed aveva 59 anni ai tempi di Elberton. Il rapporto epistolare con Martin continuò fino al 2001, poi l’ex direttore non ricevette più alcuna lettera e pensò che Christian, che avrebbe dovuto avere 81 anni, fosse deceduto.
Ma la storia non finiva lì, perché a quanto pare Christian non solo non era un semplice intermediario, ma era anche troppo egocentrico per restare nell’ombra. Nel 1986 fu infatti pubblicato un libello dal titolo Commons Sense Renewed, il cui autore è proprio tale Robert Christian che dichiara di essere l’autore delle Georgia Guidstones:
I am the originator of the Georgia Guidestones and the sole author of its inscriptions. I have had the assistance of a number of other American citizens in bringing the monument into being. We have no mysterious purpose or ulterior motives. We seek common sense pathways to a peaceful world, without bias for particular creeds or philosophies.[47]Io sono il creatore delle Georgia Guidestones e l’unico autore delle sue iscrizioni. Ho avuto l’assistenza di un certo numero di cittadini americani nella realizzazione del monumento. Non abbiamo scopi misteriosi o secondi fini. Cerchiamo percorsi di buon senso per un mondo pacifico, senza pregiudizi per particolari credi o filosofie.
Quindi, contrariamente a quanto inizialmente dichiarato, non sarebbe un semplice portavoce quanto invece l’ideatore e fulcro del gruppo promotore, se non addirittura il solo membro. Il titolo del libro, Commons Sense Renewed, fa chiaramente riferimento ad un’altra opera di Thomas Paine, Commons Sense (1776), e l’autore conferma il collegamento tra il monumento e il pensiero dell’autore di To an Age of Reason:
Over two hundred year ago a perceptive Englishman, Tom Paine, arrived in America in the early stages of our struggle for independence. […] He appealed to reason as the proper tool for resolving our problem peacefully.[48]Più di duecento anni fa un perspicace inglese, Tom Paine, arrivò in America nelle prime fasi della nostra lotta per l’indipendenza. […] Ha fatto appello alla ragione come strumento adeguato per risolvere pacificamente il nostro problema.
Il libro è un personale manifesto delle idee di questo Robert Christian, dal quale emerge una visione liberal-conservatrice in chiave newagiana, anticomunista ma anche critica su alcuni aspetti del capitalismo del quale auspicherebbe un perfezionamento.[49] Egli ribadisce anche la preoccupazione per una possibile guerra nucleare, si dichiara sostenitore di un governo mondiale, ma soprattutto spende molte parole su problema della sovrappopolazione che ritiene prioritario, causa di «degrado e povertà», «un male che non deve essere tollerato». Sostiene quindi la impellente necessità di un controllo delle nascite, oltre ad altre «proposte per migliorare la società». Il libro fu stampato inizialmente 100 copie numerate, inviate a membri del Congresso degli Stati Uniti ed altre persone politicamente influenti,[50] e vi si ritrovano molte espressioni utilizzate anche nella citata “lettera degli sponsor” pubblicata nel 1981.[51] Ciò non basta ad avere la certezza assoluta che il Robert Christian di Elberton sia lo stesso del libro, perché in fondo quest’ultimo è stato pubblicato sei anni dopo, quando il monumento era ben noto e tutte le informazioni contenute erano già disponibili: potrebbe essere un falso, creato per ravvivarne la popolarità (infatti c’è anche un errore: Fendley, il costruttore, è citato come sindaco di Elberton ma in realtà il sindaco era tale Jack Wheeler. Ma potrebbe anche essere uno “scherzo della memoria”). C’è però un particolare nel frontespizio, il luogo di stampa: Lake Mill, nell’Iowa (ricordatevi questo dettaglio). E R. C. Christian aveva un accento del Mid-West, come ricorda Hudson Cohn.[8]
Quest’ultimo fu la terza persona ad incontrare il misterioso R. C. Christian, oltre a Martin e Fendley. Editore dell’Elberton Star e all’epoca attivamente coinvolto nella promozione del monumento, anni dopo la costruzione fu chiamato dall’amico Joe Fendley,[52] il quale gli chiedeva se volesse incontrare Mr. Christian. Naturalmente Cohn accettò e i due si incontrarono in un ristorante. L’uomo gli parlò nuovamente di sovrappopolazione, di ambiente e del fatto che fosse in cerca di fondi per completare il suo progetto. Molti anni dopo, intorno al 2003, il telefono squillò anche casa di Joe Fendley Junior, figlio del Joe Fendley che aveva realizzato il monumento e che nel frattempo era mancato. Disse di essere R. C. Christian, e di essere pronto a rivelare la sua identità. Joe Junior, però, declinò l’offerta adducendo che dopo tanti anni senza conoscerla, poteva anche continuare così.[8]
Ma c’è dell’altro. Nel 2010 (prima di bruciare tutto), Martin mostrò la famosa cassa con le lettere di R. C. Christian agli autori del documentario investigativo Dark Clouds over Elberton (2010) J.M. Bennet e C.J. Pinto, e questi (se vogliamo, tradendo la sua fiducia) notarono alcuni dettagli sfuggiti alla zelante censura dell’ex direttore. Una busta inviata dallo Smithsonian Magazine[53] a Mr. Robert Christian recava come indirizzo una casella postale di Greensboro, in Georgia, intestata a tale Mr. Merryman. Chi era costui?
Un’altra busta indirizzata invece a Martin riportava come indirizzo del mittente Fort Dodge, una cittadina nell’Iowa. Wyatt aveva dichiarato che la corrispondenza di R. C. Christian arrivava «ogni volta da una città diversa»,[23] quindi poteva non significare nulla. Ma Fort Dodge si trovava a meno di due ore di auto da Lake Mills, dove aveva sede la tipografia che stampò l’edizione originale del Common Sense Renewed di Robert Christian. La tipografia confermò che il libro era stato fatto stampare da uno dei proprietari, tale Robert Merryman — il cognome corrispondeva a quello della casella postale utilizzata da R. C. Christian — che era anche editore del Messenger, il quotidiano locale di Fort Dodge, la città da cui R. C. Christian aveva scritto a Martin.

25 – Fort Dodge, Iowa: 1350 km da Elberton.

26 – Il dottor Herbert Hinie Kersten.
Controllare la popolazione è il problema più importante con cui si deve confrontare l’umanità.Dr. Herbert H. Kersten, Messenger 1/07/1990

24 – William Shockley nel 1975.
Kersten aveva anche scritto una lettera ad un quotidiano della Florida, il Sun Sentinel, nella quale elogiava pubblicamente tale David Ernest Duke, un politico di estrema destra della Lousiana, ex membro del Partito Nazista Americano ed ex Gran Maestro del Ku Kux Klan. Nientemeno. Dietro la facciata new age delle Georgia Guidestones si nasconde quindi un monumento al suprematismo bianco? Del resto, il milieu è quello; anche il misticismo ambientalista che sembra emergere dal decalogo (leave room for nature) è sempre stato una tematica condivisa dalle ultra-destre: dal Blut und Boden nazista, che collegava la purezza dell’ambiente a quella della “razza”, ai nuovi ecofascismi.[55]
…anche la più basilare conoscenza dell’ideologia suprematista porta alla conclusione che sia improbabile che le pietre guida siano opera di un razzista.[50]M. East, scrittore
Ma anche questa ipotesi non sembra funzionare, per diversi motivi. Innanzitutto mal si concilierebbe con alcuni temi espressi nel decalogo delle Pietre Guida, che invita a migliorare la diversità, ad unire i popoli e a cooperare tra nazioni per un futuro migliore: non esattamente il tipo di idee che aveva Hitler quando invase la Polonia. Inoltre appare quanto meno insolito che un monumento di matrice neonazista riporti idiomi come lo swahili, l’arabo e soprattutto l’ebraico, ma stranamente non il tedesco, lingua del Reich. Infine, il monumento non fu mai stato percepito come “proprio” dalla comunità alt-right (che altrimenti avrebbe mal tollerato i pellegrinaggi hippie), nelle cui fila si trovano anzi i maggiori detrattori delle Pietre Guida, come complottari del nuovo ordine mondiale e fondamentalisti cristiani.
Dottor Kersten e Mister Hyde
Eppure, tutti gli indizi sembrano suggerire che Kersten fosse sia R. C. Christian, sia l’unico “sponsor” dietro il progetto, al massimo con l’appoggio di qualche compagno di merende dei “nazisti dell’Iowa” come Merryman e (forse) Shockley. Tutt’al più cercando il supporto economico della massoneria di Atlanta in cambio di una pietra a loro dedicata, ma senza gli esiti sperati. Altro che Rosenkreuzer. Se così fosse, sia le Pietre Guida che il libro Common Sense Renewed sarebbero frutto non tanto di un ideale suprematista quanto di una personale visione di R. C. Christian, decisamente eclettica e contraddittoria, che forse nemmeno le persone a lui vicine conoscevano del tutto: se in pubblico era un cattolico praticante,[8] che sosteneva la necessità di un controllo delle nascite e la superiorità della presunta “razza bianca”, in privato (o entro una ristretta cerchia di amici) sognava anche un’umanità unita e senza più conflitti. Come se avesse una doppia vita, il dottor Kersten e mister Hyde.

27 – Foto di gruppo delle persone “chiave” dietro la costruzione delle Georgia Guidestones: da sinistra Joe B. Davis (supervisore); W.A. Edwards (esperto del montaggio); Tom Oglesby (presidente della Elberton Granite Association); i coniugi Mary e Joe Fendley (presidente delle Elberton Granite Finishing Co.); Wyatt C. Martin (direttore della Granite Bank e intermendiario); Billy Ray Brown (presidente della Contea di Elbert); Martha Hunt; Wayne Mullenix (costruttore) con la figlia Celina e la moglie Mildred. Naturalmente manca R. C. Christian.
Chiunque fosse davvero, sicuramente R. C. Christian vedeva nella seppure tragica eventualità di un’apocalisse atomica l’opportunità di realizzare il suo sogno, un pianeta finalmente depopolato e di nuovo in armonia con la natura. Con le Pietre Guida volle forse realizzare un cenotafio che lo rendesse in qualche modo immortale — se non lui in quanto anonimo, almeno la propria idea — ed allo stesso tempo trovare un senso escatologico all’inevitabile autodistruzione dell’umanità nell’utopia di mondo nuovo e migliore, ispirata probabilmente dalle tesi illuministe di Paine, dal malthusianesimo e dal proto-comunismo di More, ma anche dalla narrativa post-apocalittica e fantascientifica. ∎
Opera protetta dal plagio su Patamu con numero di deposito 161187
Note
Questo articolo è stato inizialmente pubblicato il 20/07/2012 e successivamente aggiornato.
- [1]Heimat: letteralmente “patria”, “casa natia”; questo termine fu però utilizzato dalla propaganda nazista con una connotazione mistica di culto della ruralità, del ritorno al passato e della prossimità alla natura. L’Heimat in tal senso era una espressione della dottrina del Blut und Boden, “sangue e suolo”, l’esaltazione del rapporto tra il popolo tedesco e la propria terra che costituiva uno dei cardini dell’ideologia nazionalsocialista (cfr: Biehl e Staudenmaier (op. cit.) pag 20-21; Vannuccini e Predazzi Piccolo viaggio nell’anima tedesca, pag. 74-75).↩
- [2]«I was thinking, ‘I got a nut in here now. How am I going get him out?’» raccontò in una intervista ad una televisione di Atlanta poco dopo la costruzione (Cfr. Wired, op. cit.)↩
- [3]Equivalenti a circa 148 mila dollari nel 2021 (cfr.)↩
- [4]Chromlec: “circolo di pietra” in bretone.↩
- [5]7 lingue (oltre all’inglese) per le 8 “tavole” e 4 lingue antiche per l’iscrizione sui bordi dell’architrave.↩
- [6]Il primo libro pubblicato dalla EGFC nel 1981 (pag. 13) riporta che «even individuals at the United Nations in New York assisted in the translations and transliterations». Si trattò della collaborazione di persone che lavoravano alla sede ONU, e non di un coinvolgimento dell’organizzazione come riportato ovunque. Nel documentario Dark Clouds over Elberton (op. cit.) Wyatt Martin racconta fu l’ambasciatore pakistano alle Nazioni Unite, conosciuto tramite un connazionale residente ad Elberton, a reclutare i traduttori presso l’ONU.↩
- [7]Nel testo in lingua swahili, la parola BINAADAM che corrisponde a “umanità” (prima riga) secondo i dizionari si scriverebbe BINADAMU. Siccome binaadam è più “fonetica”, probabilmente il traduttore (forse un immigrato naturalizzato o di seconda generazione) aveva poca dimestichezza con la grafia swahili (Cfr. Harty, Thomas
“Bad Swahili Translation on the Georgia Guidestones” in Derpetology, 25 ottobre 2015. Web).↩
- [8]Pinto, C. Dark Clouds over Elberton (op. cit.)↩
- [9]Il centro del mondo dei Cherokee, detto Ah-Yeh-Li A-Lo Hee, era il luogo dove tenevano i concili tribali e incontravano i mercanti: si trova in realtà nella contea di Hart, circa 12 km a N/N-O dalle Guidestone. Vicino, dai.↩
- [10]fonte: catasto della contea di Elbert ↩
- [11]la soletta di fondazione misura 7,3 metri per 6, per uno spessore totale di circa due piedi (≅ 60 cm).↩
- [12]La lastra esplicativa riporta come giorno di posa del pilastro centale il 22 marzo 1980. In realtà quello fu il giorno dell’inaugurazione: quando “cappello” fu posato il 12 (cfr: Georgia Guidestones, 1981, op. cit. pag. 29), il pilastro era ovviamente già lì.↩
- [13]La lettera è pubblicata per intero nel libro Georgia Guidestones del 1981 (op. cit.)↩
- [14]«this sighting hole is misaligned and poorly executed» (Van’s Hardware Journal, op. cit.).↩
- [15]Georgia Guidestones, 1987 (op. cit.) pag. 6↩
- [16]La prima edizione del 1981 (pag. 37, op. cit.) riportava che le lastre verticali «le posizioni estreme di levata e di tramonto del sole nel suo ciclo di 18,6 anni». Tuttavia il sole sorge e tramonta ai suoi punti estremi ai solstizi due volte all’anno, mentre 18,6 anni è la durata del ciclo di retrogradazione dei nodi lunari o “periodo draconico” e ha a che vedere con la Luna, non con il Sole. È infatti il tempo (≅18,6 anni) che impiegano i nodi lunari — i due punti in cui l’orbita della Luna interseca l’eclittica — a percorrere tutta l’ellitica e corrisponde al ciclo lunare di levata e tramonto (cfr.: L’astronomia n. 210 (giugno 2000) pp. 36-45). Insomma c’è un po’ di confusione e molte fonti consultate copiano acriticamente l’una o l’altra descrizione, o la faccenda dei 18,6 anni, ma senza scendere nei dettagli. Evidentemente nessuno degli autori ha voluto prendersi la briga di approfondire questo aspetto.↩
- [17]Meridiana e orologi solari “al negativo” sono quelli in cui un fascio di luce passa attraverso un foro (detto foro gnomonico), al contrario di quelli convenzionali dove è l’omba di un’asta (gnomone) a fornire l’indicazione dell’ora.↩
- [18]«Reportedly, the day of the year can be ascertained by the location of the light spot, but we could not discern any markings on the Gnomen stone to aid in this function», (Van’s Hardware Journal, op. cit.).↩
- [19]Pag. 48 (op. cit.)↩
- [20]Nota anche come “pietra del tallone”, è esterna al circolo e indica la direzione del sole all’alba del solstizio d’estate.↩
- [21]Moran e Sceurman (op. cit.)↩
- [23]Wired (op. cit.) Wired (op. cit.)↩
- [23]Discover Magazine (op. cit.)↩
- [24]Traghettava persone sul fiume Savannah tra le Georgia e il South Carolina.↩
- [25]Fu capitano nelle forze continentali duranate la Rivoluzione Americana contro il Regno Unito (1765-1783).↩
- [26]Già nel 1868 l’autore antisemita Hermann Goedsche pubblicò il libro Biarritz, nel quale immaginava un’assemblea segreta di rabbini che ogni 100 anni si riuniva nel cimitero di Praga per cospirare. Ciò ispirò il falso documento noto come i “Protocolli dei Savi di Sion”, uno dei capisaldi della teoria, creato nei primi del ‘900 dalla polizia segreta zarista con l’intento di diffondere l’antisemitismo nell’Impero russo.↩
- [27]Seremia, Natale “L’avvento dei Rosacroce” in Reccom Magazine, 1 gennaio 2021.↩
- [28]“The Georgia Guidestones Guides the Stone”, cit. in Wiley, R. e K. T. Prime The Georgia Guidstones America’s Most Mysterious Monument. Pag. 89-96.↩
- [29]Cristo viene citato come “Master Jesus”↩
- [30]Che per i rosacrociani rappresenterebbe la “conoscenza esatta”.↩
- [31]cfr. Van’s Hardware Journal, op. cit.↩
- [32]Il nome del monumento è scritto Guide Stones (staccato) mentre Robert scrisse sempre Guidestones.↩
- [33]In realtà, massoneria e rosacroce non sono la stessa cosa.↩
- [34]La sincronicità è un concetto introdotto dallo psicoanalista Carl Gustav Jung nel 1950, definito come «un principio di nessi acausali» ossia in un legame tra due eventi che avvengono in contemporanea, senza nesso di causalità ovvero influenza diretta ma piuttosto appartenenti ad un medesimo contesto o contenuto significativo. Ad esempio, due orologi che procedono in sincrono lo fanno non perché siano collegati tra loro ma perché in precedenza sono stati sincronizzati sulla stessa ora. Anche la filosofia neo-rosacrociana dell’AMORC contempla il concetto di sincronicità.↩
- [35]Leckert, O. Who Stole a Fragment of Georgia’s Esoteric Tables?” in Atlas Obscura, 19 Nov. 2014. Web.↩
- [36]Pag. 19 (op. cit.)↩
- [37]
Oakes, Guy “The Cold War Conception of Nuclear Reality: Mobilizing the American Imagination for Nuclear War in the 1950’s” in International Journal of Politics, Culture, and Society (Springs) Vol. 6, No. 3 (Spring, 1993), pp. 339-363.↩
- [38]Pag. 6 (op. cit.)↩
- [39]
“The Doomsday Clock. A timeline of conflict, culture and change.” In Bulletin of the Atomic Scientists. Web.↩
- [40]Alice Calaprice e Trevor Lipscombe, Albert Einstein: a biography, Greenwood Publishing Group, 2005, p. 124, ISBN 0-313-33080-8.↩
- [41]Il primo racconto del ciclo dei robot è del 1940, pertanto non è escluso che le opere dello scrittore fossero state tra le fonti di ispirazione.↩
- [42]cfr. Soundcloud. Web.↩
- [43]«L’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté». Du contrat social, éd. Marc-Michel Rey, 1762, parte I, cap. VIII (“De l’état civil”), p. 43↩
- [44]Santi (op. cit.)↩
- [45]Lake, Thomas in CNN (op. cit.)↩
- [46]Ford, Wayne “Elbert County won’t rebuild bombed Georgia Guidestones, will donate monument’s remains” in Athens Banner-Herald, 10/08/2022. Web.↩
- [47]pag. 7 (op. cit.)↩
- [48]pag. 1 (op. cit.)↩
- [49]pag. 115 (op. cit.)↩
- [50]East, M. (op. cit.)↩
- [51]Georgia Guidestones, 1981, op. cit.↩
- [52]Quindi non era vero che Christian non ebbe più contatti con Fendley?↩
- [53]Rivista ufficiale dello Smithsonian Insititution, importante istituto di istruzione e ricerca con sede a Washington amministrato e finanziato dal governo degli Stati Uniti, che gestisce 19 musei.↩
- [54]In realtà Robert Christian in Common Sense Renewed dichiarava di non avere una formazione accademica (cfr.).↩
- [55]Biehl e Staudenmaier (op. cit.)↩
Bibliografia e fonti
Georgia Guidestones guidebook Elberton: Elberton Granite Finishing Co. Inc. , 1981. In Internet Archive.
Georgia Guidestones Elberton: Elberton Granite Finishing Co. Inc. , 1987. In Elberton Granite Association website. <egaonline.com>
Robert C. Christian, Common sense renewed. Lake Mills (IA): Graphic Publishing Company, Inc. 1986. <docplayer.net>
Moran, Mark e Mark Sceurman Weird U.S.: your travel guide to America’s local legends and best kept secrets . New York: Barnes & Noble Books, 2004. Pag. 193.
Bennet, J., & Pinto, C. (Producers), & Pinto, C. (Director). (2010). Dark Clouds over Elberton – The True Story of The Georgia Guidestones . USA: Adullam Film Production.
Sullivan, Randall “American Stonehenge: Monumental Instructions for the Post-Apocalypse” in Wired. 20/4/2009. Web.
Smith, Van “Decoding the Georgia Guidestones“, Van’s Hardware Journal. 28/12/2009.
Neimark, Jill “Georgia’s Own Doomsday Stonehenge Monument” in Discover Magazine. 9/10/2013. Web.
Mihai Andrei “Georgia Guidestones — mysterious instructions for the post-apocalypse” in ZME Science 1/2/2021. Web.
Goad, Jim “Georgia Guidestones: a Complete guide” in Creepy Catalog. Web.
“THE UNKNOWN: Georgia Guidestones” in Supernatural with Ashley Flowers (podcast). 22/07/2020. Web.
East, Michael “The Truth About: The Georgia Guidestones” in The Mistery Box (medium.com). 28/10/2020. Web.
- Santi, Claudia “Recensione a G. Filoramo Millenarismo e New Age (Bari: Dedalo, 1999)” in Studi e Materiali di storia delle religioni. Vol. 67, nºXXV, 1. Pagg. 189-193 (PDF su Academia.edu)
- Biehl e Staudenmaier, Ecofascismo: lezioni dall’esperienza tedesca, 1995. pag 20-21
Lake, Thomas “Two mysteries surrounded the Georgia Guidestones. One may have finally been solved” in CNN, 16/02/2024. Web.
Immagini
- Dina Eric, 2014 [CC BY] Flickr / Commons
- da Georgia Guidestones, 1987 (op. cit.)
- ibidem
- cartolina postale, primi anni ’80.
- cartolina postale, primi anni ’80.
- da Georgia Guidestones, 1981 (op. cit.)
- ibidem
- ibidem
- ibidem
- ibidem
- foto: K. Mitch Hodge / Unsplash
- R. C. Christian, 1979.
- da Georgia Guidestones, 1981 (op. cit.)
- Dina Eric, 2014 [CC BY] Flickr / Commons
- Gustave Dorè, 1865-1868 circa.
- banconota da 1 Dollaro USA (dettaglio) [PD] Commons
- incisione dal Summum Bonum di Robert Fludd (1629)
- A. York, 2014 [CC BY-SA 3.0] Commons
- documento dall’archivio Coggins Industries, autore sconosciuto
- 2017 [CC BY-SA 4.0] Commons
- foto: J. McCranie, 2020 [CC BY-SA 3.0] Commons
- Tyler Merlber, 2018 [CC BY] Flickr
- dal film Dr. Strangelove, Stanley Kubrick (1964) [PD] Commons
- frontespizio di To An Age of Reason, T. Paine (1794)
- B. Whittaker, 2009 [CC BY-SA 3.0] Commons
- dal Messenger, Fort Doge 1/7/ 1990
- Stanford University, 1975 [PD] Commons
- da Georgia Guidestones, 1981 (op. cit.)

I – Grand Union flag (1776 – 1777).
Oltre che sulle navi la Grand Union sventolò anche su Prospect Hill a Sommerville (Massachusetts) nelle vicinanze del quartier generale di George Washington, comandante in capo dell’esercito continentale, in modo che fosse visibile a miglia di distanza. Il tentativo di dialogo con Londra non riuscì, per cui le colonie decisero di recidere i legami con la corona votando per l’indipendenza il 2 luglio 1776. Perché allora l’Independence Day è il 4? La mozione a favore dell’indipendenza fu approvata il 2 luglio ma le divergenze di opinioni, sul riferimento alla schiavitù,[4] prolungarono di due giorni l’approvazione della dichiarazione scritta da Thomas Jefferson. Con buona pace del padre fondatore John Adams convinto, in una lettera scritta alla moglie, che il 2 luglio sarebbe stato festeggiato grandemente dalle generazioni successive da un capo all’altro d’America: sui festeggiamenti aveva ragione, non sulla data che è diventata invece quella della dichiarazione. Il 4 Luglio sarà nel destino di John Adams come di Thomas Jefferson morti entrambi, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, il 4 luglio 1826 nel cinquantenario della dichiarazione. Con il Trattato di Parigi del 3 Settembre 1783 la Gran Bretagna riconobbe l’indipendenza delle tredici colonie. La Red Ensign però non abbandonò del tutto il Nord America, restando la bandiera ufficiale del Canada fino al 1965.[5]
La prima Stars and Stripes
Undici mesi dopo la dichiarazione d’indipendenza, per la precisione il 14 giugno 1777, il Congresso approvò la nuova bandiera nazionale stabilendo: «e che la bandiera dei tredici Stati Uniti sia tredici strisce, rosse e bianche alternate; che l’unione sia tredici stelle, bianche in campo blu, a rappresentare una nuova costellazione». Una bella retorica se non fosse che non chiariva forma e disposizione delle stelle, e taceva del tutto sulle proporzioni. In ogni caso la prima bandiera a stelle e strisce, per gli americani la prima stars and stripes, era nata ma di chi sia l’idea resta non del tutto chiarito. I libri di storia delle scuole elementari americane però non hanno dubbi, e nemmeno il sito dell’ambasciata USA nel Regno Unito:[6] il merito viene dato a una sarta di Philadelphia di nome Elizabeth Phoebe Griscom Ross ( 1752 – 1836) meglio nota come “Betsy” Ross.

1 – Sewing the American Flag, illustrazione dal Tacoma Times del 14 giugno 1904.
Nata nel 1752 a Gloucester City, New Jersey,[7] in una famiglia quacchera sposò il protestante John Ross, il cui zio George Ross comparirà tra i firmatari della dichiarazione d’indipendenza. Il suo matrimonio le costò l’espulsione dalla comunità quacchera[8] ma in compenso frequentò con il marito la Christ Church di Philadelphia, insieme a George Washington e altri esponenti del Congresso Continentale. La rivoluzione la rese vedova una prima volta nel 1776, si risposò con Joseph Ashburn nel 1777 ma anche lui diede la vita per la causa morendo prigioniero di guerra in Inghilterra nel 1782. L’anno dopo sposò infine John Claypoole compagno di prigionia del secondo marito; ebbe sette figli, fornì bandiere per la marina della Pennsylvania e morì nel 1836 all’età di 84 anni. Stando all’aneddoto fu lei a essere incaricata, nel giugno del 1776, di produrre la nuova bandiera e a suggerire a George Washington di adottare le stelle a cinque punte, anziché sei come da progetto, in quanto più facili da disegnare e cucire.
La storia di Betsy Ross fu resa nota dal nipote William J. Canby nel 1870, ovvero 94 anni dopo i fatti e soprattutto poco dopo la guerra civile. Con un sentimento nazionale da ricostruire, con la bandiera diventata oggetto di culto popolare, con le celebrazioni in vista per il primo centenario dell’unione, la storia di Betsy suona dubbia per il tempismo con cui è emersa e altre incongruenze.[9] In quel contesto di fervore verso la bandiera l’aneddoto di Canby fece presa sull’opinione pubblica e nel 1892 grazie a Charles H. Weisgerber e al suo dipinto Birth of Our Nation’s Flag, che raffigura Betsy presentare la nuova bandiera a George Washington, entrò definitivamente nell’immaginario collettivo statunitense. Il dipinto esposto alla Fiera mondiale Colombiana di Chicago del 1893, organizzata per celebrare l’anniversario dei quattrocento anni dalla scoperta dell’America, ebbe tanto successo che le persone facevano la fila pur di vederlo. Il mito di Betsy Ross resiste tuttora e la sua casa a Philadelphia, anche se pure in questo caso prove storiche che fosse davvero quella in cui abitava non ce ne sono, è una delle attrazioni turistiche più note della città.[10]

2 – The birth of our nation’s flag di Charles H. Weisgerber: Betsy Ross mostra la prima bandiera degli Stati Uniti (la Betsy Flag) al generale George Washington, seduto sulla destra con Robert Morris, dietro di loro in piedi George Ross.

II – La “Betsy flag”, considerata la prima bandiera degli Stati Uniti.

III – La variante del 3º Maryland, nota anche come “Cowpens flag”.[11]
Va precisato tuttavia che non vi sono prove certe che questa versione della bandiera abbia realmente partecipato a Cowpens; uno storico vessillo di questo reggimento è conservato presso gli archivi della State House del Maryland ma dalle analisi risale all’Ottocento.[12] Il noto amore popolare per la Betsy Flag ha spinto gli autori del film a preferirla a quella del 3º Maryland, anche se quest’ultima da un punto di vista storico è leggermente più vicina ai fatti.[13] La bandiera del 3º Maryland può in compenso rifarsi comparendo nel quadro The Spirit of 1776 di A.Willard del 1875 (fig. 3), ma anche qui il fine patriottico ha avuto la meglio sulla verità storica: nel 1776 la bandiera era ancora la Grand Union con l’Union Jack nel cantone. Stesso discorso per il dipinto Washington crossing the Delaware di E. Leutze del 1851 (fig. 4), ispirato all’evento del 25-26 dicembre 1776[14], e per il quadro General George Washington at Trenton di J. Trumbull del 1792 (riferito all’evento del gennaio 1777).

3 – The Spirit of 1776, dipinto di Archibald Willard, una delle più famose immagini della guerra d’indipendenza americana.

4 – Washington Crossing the Delaware (“Washington che attraversa il fiume Delaware”[14]), dipinto di Emanuel Gottlieb Leutze (1851).

5 – The East India Company’s ship Bridgewater successfully defending her cargo from an attack by the American privateer Hampden on her way from St. Helena to England on 8th March 1779, Francis Holman (1179). Il dipinto mostra la nave britannica Bridgewater (a destra) di ritorno da S. Elena difendersi da un attacco della nave corsara americana Hampden (a sinistra) che espone la bandiera a stelle e strisce.[17]

5.1 – Dettaglio della bandiera americana a poppa della nave Hampden: è la bandiera di Hopkinson nella versione navale (fig. VI).
Un po’ di confusione? Sì è inevitabile. Se può consolare in confusione andarono persino Benjamin Franklin e John Adams. Nel descrivere nel 1778 la bandiera all’ambasciatore americano presso il Regno di Napoli, in modo che all’occorrenza le navi fossero riconosciute e non trattate come pirati, i due padri fondatori scrissero: «È con piacere che comunichiamo a vostra eccellenza che la bandiera degli Stati Uniti consiste di tredici strisce, alternativamente rosse, bianche e blu. Un piccolo rettangolo all’angolo superiore, accanto all’asta, consiste in un campo blu con tredici stelle bianche, a rappresentare una nuova costellazione». Questa forma della bandiera è nota come Serapis Flag (fig. IV), perché nel 1779 il capitano americano John Paul Jones catturò la nave britannica Serapis perdendo la sua, la Bonhomme Richard, nello scontro. Dovendo attraccare in Olanda per le riparazioni, e dovendo fornire una bandiera riconosciuta per non essere arrestato con l’accusa di pirateria come chiesto dagli inglesi, il capitano Jones fornì una descrizione della bandiera con le strisce rosse, bianche e blu. In memoria di quell’evento nello stemma del cacciatorpediniere USS John Paul Jones è rappresentata la Serapis Flag (fig. 6).

IV – La “Serapis Flag”, aka “John Paul Jones flag”.

6 – stemma della cacciatrpediniere lanciamissili USS John Paul Jones (DDG-53): la bandiera americana sulla sinistra è la “serapis flag”.
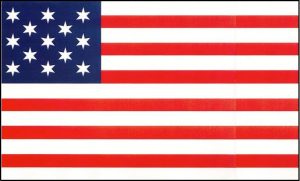
V – La bandiera a 13 stelle di Francis Hopkinson: presenta 13 striscie bianche e rosse di cui la prima e l’ultima bianche, le stelle sono a 6 punte.
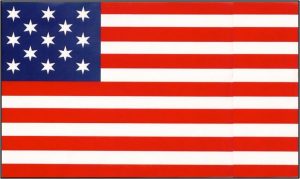
VI – La bandiera a 13 stelle di Francis Hopkinson nella versione per la marina militare: ha i colori delle strisce invertiti rispetto a quella nazionale (la prima e l’ultima rosse).
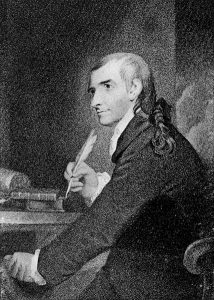
7 – Francis Hopkinson (1737 – 1791).
L’iter andò avanti e il Consiglio del Tesoro spiegò al Congresso che Hopkinson non fu l’unico consultato per il disegno della bandiera, pertanto non poteva reclamare l’intero importo (nel frattempo su richiesta del Tesoro Hopkinson riformulò la richiesta con fattura dettagliata) e inoltre per costoro un uomo dalle facoltà economiche come Hopkinson poteva anche farlo gratuitamente in nome della Repubblica. Dal punto di vista storico è quindi Hopkinson l’autore, insieme ad altri, della prima bandiera nazionale ma non ci si può meravigliare che, nel cuore degli americani, la storia di Betsy Ross abbia molto più fascino e presa. Resta ancora una domanda: ma perché proprio le stelle nel cantone? Anche in questo caso nessuno lo sa. Le teorie vanno dalla bandiera di comando di George Washington, tredici stelle su campo blu, all’astronomo John Winthrop che avrebbe contribuito al disegno della bandiera, al concetto di “firmamento di nazioni sovrane” espresso dal segretario del Congresso Charles Thomson.
La bandiera adorna di stelle

VII – versione a 15 stelle e 15 strisce (1795 – 1818) nota come “Star-Spangled Banner” (bandiera adorna di stelle).
A differenza di Betsy su Mary Pickersgill (1776 – 1857) non vi sono dubbi. Nata l’anno della dichiarazione d’indipendenza cucì nel 1813 la Star Spangled Banner (la bandiera adorna di stelle); non poteva saperlo ma la “sua” bandiera avrebbe pochi mesi dopo ispirato il futuro inno nazionale americano. Ne fabbricò due[18] una grande circa dodici metri per nove, l’altra circa sette per cinque, su commissione di Fort McHenry a Baltimora (Maryland) e per riuscire a cucire cotanta stoffa dovette ricorrere all’aiuto di tutta la sua famiglia.
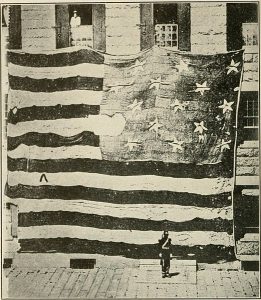
8 – La bandiera di Fort McHenry del 1814, esposta nel cantiere navale della US Navy di Boston nel 1873.
Commosso da quella vista Scott Key scrisse di getto la canzone La difesa di Fort McHenry, in onore di quel vessillo che pur danneggiato dai bombardamenti era ancora al suo posto:
What so proudly we hail’d at the twilight’s last gleaming,
“Di’, puoi vedere alle prime luci dell’alba
ciò che abbiamo salutato fieri all’ultimo raggio del crepuscolo,
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming?
Le cui larghe strisce e brillanti stelle, nella battaglia pericolosa,
sui bastioni che sorvegliavamo, sventolavano valorosamente?
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there,
E il bagliore rosso dei razzi e le bombe che esplodevano in aria
hanno dato prova, nella notte, che il nostro vessillo era ancora là.
O say does that star-spangled banner yet wave
O’er the land of the free and the home of the brave?”
Di’ dunque, sventola ancora la nostra bandiera adorna di stelle
sulla terra dei liberi e la patria dei coraggiosi?”
Tornato a Baltimora Scott Key completò la sua opera con altre strofe e fu pubblicata su diversi giornali della costa orientale. Vien da dire “purtroppo” la completò, dato che da schiavista convinto Scott si lasciò andare nelle ultime strofe contro gli schiavi e i mercenari utilizzati dagli inglesi. Fin dalla prima pubblicazione[21] sui giornali a noi nota, Scott Key aveva precisato che i suoi versi dovevano essere cantati sulla melodia di To Anacreon in Heaven, che aveva già utilizzato per un’altra sua canzone dal titolo When the Warrior Returns del 1805.[22] Adattata la melodia al testo, al momento di pubblicare la canzone completa dello spartito musicale il titolo cambiò in Star Spangled Banner. Curiosamente però, non si sa se Scott Key lo sapesse o meno, la melodia scelta era opera dell’inglese John Stafford Smith. To Anacreon in Heaven era infatti l’inno costituzionale dell’Anacreontic Society,[23] un club musicale per soli gentlemen di Londra, ed era nota negli Stati Uniti tramite la sua parodia utilizzata per una canzone in sostegno di John Adams[24] dal titolo “Adams and Liberty”. In questo club londinese si beveva molto e si cantava altrettanto, era infatti dedicato «al brio, all’armonia e al dio del vino», e questo ha dato origine al mito che fosse una drinking song ovvero una canzone da pub. La melodia era sì l’inno di un club canterino e goliardico ma pur sempre culturale, ponendo il suo inno a un livello più alto delle drinking song; non va quindi confuso con il nostro bevilo tutto per intenderci. Gli americani tra l’altro non sono stati i soli, la stessa melodia aveva fatto da base all’inno nazionale del Granducato di Lussemburgo tra il 1839 e il 1864. Ad ogni modo, la canzone patriottica di Scott Key ebbe molto successo: un successo popolare che continuò a crescere insieme al sentimento della bandiera, rinforzandosi a vicenda, finendo per soppiantare l’inno ufficioso degli Stati Uniti che era Hail Columbia del 1798 (oggi ancora in uso come inno del vice presidente), il cui testo era opera di Joseph Hopkinson figlio del di cui sopra Francis. Nel 1889 Star Spangled Banner divenne inno della U.S. Navy, nel 1916 il presidente Wilson ordinò che fosse eseguita a ogni evento militare, ed infine nel 1931 il Congresso rese legalmente la canzone, limitata alla prima strofa,[25] inno ufficiale degli Stati Uniti.
Tornando invece alla bandiera di Fort McHenry è conservata, in una camera ad ambiente controllato, presso il Museo nazionale di storia americana di Washington; a Baltimora la casa di Mary Pickersgill è diventata un museo dal nome “Star-Spangled Banner Flag House”.
Un cambiamento continuo
Il 4 aprile 1818 un nuovo atto del Congresso stabilì che le strisce sarebbero tornate a essere definitivamente tredici, mentre le stelle dovevano essere una per ogni stato; inoltre stabiliva che la modifica alla bandiera sarebbe avvenuta il 4 luglio successivo all’adesione di un nuovo stato. Il 4 luglio 1818 furono aggiunte cinque stelle in quanto gli Stati erano diventati venti, disposte in quattro file da 5.

VIII – versione a 21 stelle e 13 strisce (1819 – 1820).

9 – Fourth of July Celebration in Centre Square, Philadelphia, 1819 di John Lewis Krimmel (1819),

IX – versione a 24 stelle (1822 – 1836) nota come “Old Glory”.
Fu così che la bandiera accompagnò il capitano Driver su e giù per i mari per tredici anni in diverse avventure, tra cui anche il recupero di alcuni superstiti del HMS Bounty. Lasciata la marina dopo la perdita della prima moglie, Driver tornò nel Tennessee, si risposò, ebbe molti figli e prese l’abitudine di far sventolare la Old Glory sulla sua casa durante le festività. La guerra civile lacerò la sua famiglia, alcuni dei suoi figli si arruolarono nell’esercito sudista e per Driver, fervente unionista, fu un dramma. Subito dopo la secessione il governatore Isham G. Harris mandò un comitato a casa Driver per chiedere la consegna della bandiera unionista, ma come anche altri tentativi successivi, furono tutti respinti dall’ex capitano. Driver per sicurezza, dato l’infuriare della guerra, cucì la bandiera in una coperta e la nascose. Nel 1862 Nashville fu occupata dalle truppe unioniste del Sesto Ohio e Driver si recò di persona per chiedere di parlare con chi era al comando; insistette ma alla fine parlò con il generale William Nelson e davanti alle truppe lacerò la coperta per estrarre la bandiera e raccontare cosa aveva fatto per proteggerla. Il generale ordinò che la Old Glory fosse issata sull’asta della bandiera dello stato del Tennessee, tra le ovazioni dei soldati. Driver fu nominato provost marshal per la città di Nashville e lavorò negli ospedali fino alla fine della guerra. Alla sua morte sorse una disputa familiare tra sua figlia e sua nipote su chi delle due avesse avuto in eredità la Old Glory originale. Lo Smithsonian Institute le possiede entrambe ma reputa quella della figlia la vera Old Glory che è esposta, come la Star Spangled Banner, al Museo nazionale di storia americana di Washington. Oggi Old Glory è il benevolo nomignolo con cui ogni cittadino statunitense chiama la bandiera nazionale.
Oltre al nomignolo la bandiera è oggetto anche di un giuramento. Nel 1892 Francis Bellamy, ministro della chiesa battista e autore per una rivista, scrisse il Pledge of Allegiance, come programma per le scuole in occasione della cerimonia di apertura della Fiera mondiale Colombiana di Chicago. Il testo è un giuramento di fedeltà alla bandiera e alla repubblica americana ed è recitato tuttora, ma ci si può rifiutare, dai bambini a scuola. Bellamy fu anche un sostenitore dell’istituzionalizzazione del Columbus Day.

X – versione a 48 stelle (1912 – 1959) con cui gli Stati Uniti combatterono le guerre mondiali.

10 – Marines statunitensi innalzano la bandiera a 48 stelle sopra il monte Suribachi il 23 febbraio 1945, durante la battaglia di Iwo Jima. La foto di Joe Rosenthal, nota come Raising the Flag on Iwo Jima, divenne una delle più iconiche immagini della seconda guerra mondiale.

XI – versione a 49 stelle, rimasta in vigore per solo un anno: dal 4 luglio 1959 al 4 luglio 1960.

XII – versione a 50 stelle, in vigore dal 4 luglio 1960.
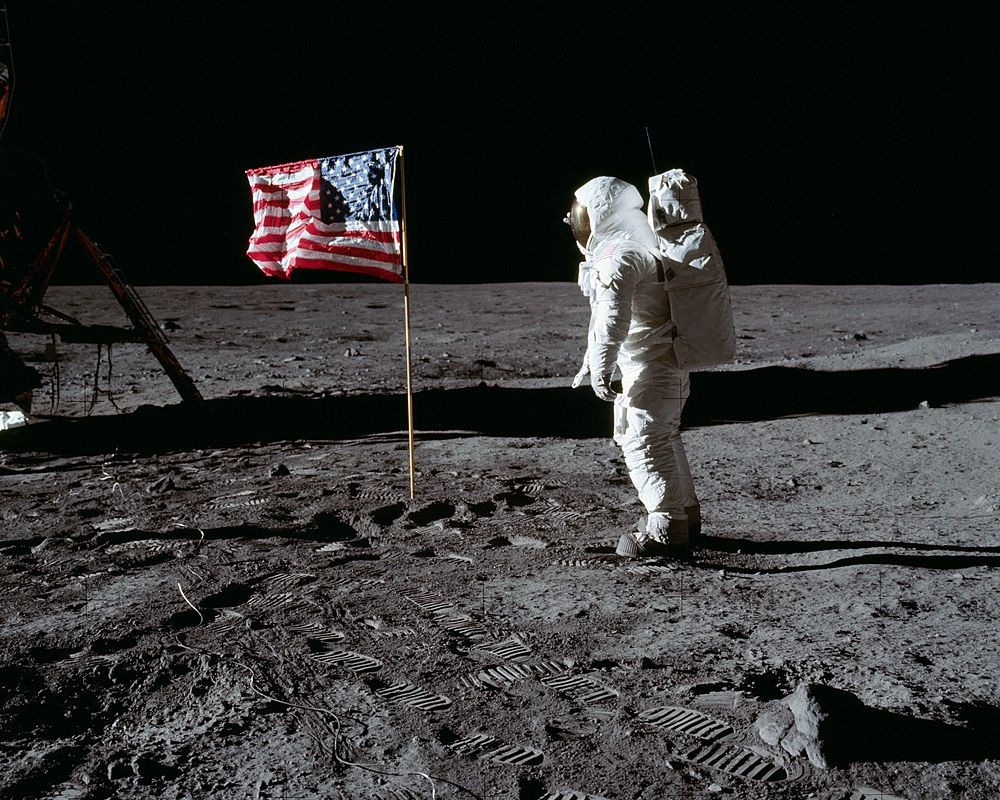
11 – 21 luglio 1969, l’astronauta Edwin E. Aldrin della missione Apollo 11 saluta la bandiera USA sulla Luna: è la versione a 50 stelle.
Cinquanta stelle e fine della storia? Non proprio. Gli Stati Uniti posseggono territori non ancora innalzati al rango di stato dell’unione tra cui Porto Rico, Isole Vergini Americane, isole Samoa Americane e altre; se uno di questi territori diventerà stato la relativa stella andrà aggiunta. In ogni caso la bandiera ha una sua festa: nel 1916, con atto del presidente Woodrow Wilson, il 14 giugno di quell’anno fu dichiarato festa nazionale come Flag Day; la festa è stata poi istituzionalizzata ogni anno a partire dal 1949. L’inno nazionale invece non teme cambiamenti ma è anche vero che non è eseguito sempre allo stesso modo, lasciando volutamente che ognuno possa suonarlo e cantarlo in libertà alla propria maniera.
Bandiera e inno oggi
Forse tutto questo fervore verso la bandiera e l’inno da parte degli americani può apparirci strano. Su questo rimandiamo ad analisi sociologiche e geopolitiche più accurate e ci limitiamo a dire che non si può giudicare tutto con le proprie “lenti”, soprattutto quando questo tipo di sentimento verso la bandiera e l’inno è comune a tutta la popolazione. Va inoltre considerato che gli Stati Uniti d’America sono fondamentalmente una nazione di immigrati dalle più disparate parti del mondo e con diverse fedi religiose. Come osservato da alcuni, si tratta di una nazione multietnica ma non multiculturale;[28] la cultura che si impone è quella imperniata su bandiera, inno, guerra rivoluzionaria e dichiarazione d’indipendenza. Una religione laica per compattare la nazione, pena lo scollamento della comunità, con tutto il resto delle varie culture che al massimo può sopravvivere come folklore (come per esempio la festa di San Patrizio). Questo può spiegare perché il Pledge of Allegiance (giuramento di fedeltà[29]) è ancora recitato a scuola e perché non c’è evento sportivo che non sia proceduto dall’esecuzione dell’inno nazionale americano.

12 – Jimi Hendrix suona l’inno nazionale a Woodstock lunedì 18 agosto del 1969.
Il gesto costò a Kaepernick il posto e la carriera in quanto nessuna squadra di NFL lo volle più ingaggiare, ma fu poi ripreso dal movimento Black Lives Matters a seguito dell’omicidio di George Floyd nel 2020, ed è poi andato oltre i confini USA diventando un simbolo della protesta contro il razzismo. A prescindere dall’opinione che si può avere, ciò che risalta è la veemente reazione che Kaepernick ha innescato. A proposito di football americano e inno, le esecuzioni prima del Super Bowl sono spesso memorabili e per molti statunitensi la performance di Whitney Houston per il Super Bowl del 1991 resta l’esecuzione più bella ed emozionante di sempre in assoluto. Possiamo pensarla come vogliamo, ma per ogni americano ciò che conta è che la Old Glory continui a sventolare su quella che considerano la terra dei liberi e la patria dei coraggiosi. ∎
Note
- [1]Come nacque lo raccontiamo qui.↩
- [2]La White Ensign, in sintesi bandiera inglese con Union Jack nel cantone, era invece esclusiva delle navi militari.↩
- [3]Il motto «no taxation without representation» deriva dalla frase «la tassazione senza rappresentanza è tirannia» dell’avvocato e attivista politico americano James Otis (1725 — 1783).↩
- [4]Tra cui il passaggio in cui Jefferson accusava il re Giorgio III di aver violato la libertà e la vita di «a distant people who never offended him, captivating and carrying them into slavery in another hemisphere, or to incur miserable death in their transportation thither.»↩
- [5]Sia la Red Ensign sia la Blu Ensign sventolano ancora su diverse isole dei Caraibi.↩
- [6]
“U.S. Flag Facts“, U.S. Embassy and Consulates in the United Kingdom. Web.↩
- [7]Alcune fonti però riportano come luogo di nascita Philadelphia.↩
- [8]Nonostante la famiglia Ross fosse ben nota prevalse il divieto assoluto di sposare uomini di altro orientamento religioso.↩
- [9]Tra cui il fatto che non vi è alcuna traccia da nessuna parte a differenza dell’incarico per le bandiere della marina della Pennsylania, che la data del giugno 1776 non quadra con l’atto del 1777 e che il tutto si basa sui racconti familiari tramandati.↩
- [10]
“Betsy Ross House” in Historic Philadelphia. Web.↩
- [11]La battaglia di Cowpens fu combattuta il 17 gennaio 1781 nelle vicinanze di Cowpens in Carolina del Sud e vide la vittoria dell’esercito continentale e delle milizie americane contro le truppe britanniche e i “lealisti”.↩
- [12]Nella State House del Maryland tra l’altro è possibile ammirare bandiere americane con le stelle a otto punte.↩
- [13]Resta il fatto che la presenza di questa bandiera ai tempi dell’indipendenza resta possibile ma non certa.↩
- [14]L’attraversamento del Delaware: durante la campagna di New York e New Jersey, Goerge Washington guidò una colonna dell’esercito continentale atraverso il fiume Delaware ghiacciato per condurre un attacco a sorpresa ai mercenari assiani di stanza a Trenton.↩
- [15]I coniugi Mastai di professione antiquari e collezionisti hanno raccolto diverse testimonianze di queste bandiere difformi dall’originale.↩
- [16]Sempre in tema di quadri Trumball ha dipinto la bandiera con le stelle disposte a quadrato nell’opera La morte del generale Mercer alla Battaglia di Princeton e nell’opera La resa di lord Cornwallis.↩
- [17]
“The East India Company’s ship Bridgewater successfully defending…” in Christie’s, 2012. Web.↩
- [18]Se vi state chiedendo come erano disposte le stelle, erano nell’ordine corretto anche se un po’ storte.↩
- [19]Era a bordo per una missione di scambio di prigionieri e a scambio avvenuto la nave fu trattenuta per evitare che rivelasse i piani di battaglia inglesi.↩
- [20]Gli inglesi attaccarono sia via terra sia via mare ma persero la battaglia. Allo scontro su terra partecipò la bandiera del 3° Maryland.↩
- [21]Probabilmente del 17 settembre 1814.↩
- [22]All’epoca in America era uso scrivere canzoni utilizzando melodie già composte da altri.↩
- [23]Fondata nel 1766.↩
- [24]Sempre quel John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti.↩
- [25]In modo analogo, nel 1952 anche l’inno tedesco fu “epurato” delle prime due strofe per evitare fraintendimenti con il passato nazionalsocialista della Germania.↩
- [26]L’ammissione dell’Alaska al rango di stato avvenne i 3 gennaio del 1959; il 4 luglio successivo venne ufficializzata la bandiera a 49 stelle; quindi il 21 agosto del 1959 fu ammesso lo stato delle Hawaii la cui stella sarebbe stata aggiunta alla bandiera (come consuetudine) solo il 4 luglio dell’anno successivo, il 1960.↩
- [27]cfr. “Flag laws in the United States” in Flags of the worlds. Web.↩
- [28]Il tema è stato trattato diverse volte dalla rivista Limes.↩
- [29]originariamente composto da Francis Bellamy nel 1892 e adottato formalmente dal Congresso nel 1942.↩
Bibliografia e fonti
- Cianci, Bruno La stoffa delle nazioni: storie di bandiere Bologna: Odoya, 2016. ISBN 978-8862883207
- Cianci, Bruno “Stoffa e Sangue. Il mito della bandiera” in Limes, “Il Potere del Mito”, 2/2020.
- Furst, Henry e Enrico Monaldini “Vermont” in Enciclopedia Italiana. Treccani, 1937. In Treccani. Web.
- “Kentucky” in Enciclopedia Treccani.Web.
- Mariani, Guido “Una patria da cantare” Il Manifesto, 15 giugno 2018.
Cooper, Grace Rogers “Thirteen-Star Flags: Keys to Identification” Smithsonian Studies in History and Technology. 1–62, 1973.
Van Gelder, Lawrence “INTERVIEW: A Collector of ‘Overlooked’ Art–the Flag” in New York Times, 19 febbraio 1978.
“The man who wrote the Pledge of Allegiance” in Smithsonian Magazine, novembre 2003. Web.
Jenkins, Sally “How the Flag Came to be Called Old Glory” in Smithsonian Magazine, ottobre 2013. Web.
Clague, Mark “Star-Spangled Mythbusting” in Chorus America, 5 giugno 2014. Web.
Cavanaugh, Ray “The Star-Spangled Banner: an American anthem with a very British beginning” The Guardian, 4 luglio 2016. Web.
Wolters, Claire “Flag Day’s long—and surprising—history explained” in National Geographic. Web.
Blakemore, Erin “America declared independence on July 2—so why is the 4th a holiday?” in National Geographic 2 luglio 2020. Web.
Blakemore, Erin “Betsy Ross likely didn’t sew the first U.S. flag” in National Geographic 1 luglio 2021. Web.
“The Star-Spangled Banner” in Smithsonian Institute. Web.
“United States of America” in Flags of the World. Web.
“Flag of the United States of America” in Encyclopædia Britannica. Web.
“Betsy Ross” in Encyclopædia Britannica. Web.
“Francis Hopkinson” in Encyclopædia Britannica. Web.
“Great Seal of the United States” in Encyclopædia Britannica. Web.
“Thomas Jefferson and John Adams die” in History.com, 16 novembre 2019. A&E Television Networks. Web.
“American Flag History & Evolution” in National Fag Foundation. Web.
- “Cinque miti sulla bandiera americana” in Il Post, 14 giugno 2011. Web.
“Betsy Ross and the American flag” in USHistory.org, Philadelphia: Independence Hall Association. Web.
“Facts about the United States Flag” in Smithsonian Institute. Web.
- “Un percorso a 10 tappe per la bandiera americana” in Liberty Bell, 4 aprile 2018. Liberty Bell edizioni. Web.
“Francis Hopkinson” in USFlag.org. Chamber of Commerce. Web.
“Betsy Ross” in USFlag.org. Chamber of Commerce. Web.
“Betsy Ross’s Flag: What Did it Look Like and Why Is it Important?” in Allegiance. Web.
The Maryland State House. Web.
“Star Spangled Banner Flag House” in National Park Service. U.S. Departement of Interior. Web.
Immagini
- copertina: foto di Samuel Branch / Unsplash,
- Sewing the american flag, illustrazione del Tacoma Times del 14 giugno 1904. Seppure non specificato, è sottinteso che la sarta sia “Betsy” Ross. [PD] Commons.
- The birth of our nation’s flag, stampa cromolitografica del 1893 dal dipinto omonimo di Charles H. Weisgerber (1892) [PD] Library of Congress.
- The Spirit of 1776, Archibald Willard (1875 circa) [PD] Commons.
- https://it.wikipedia.org/wiki/File:Washington_Crossing_the_Delaware_by_Emanuel_Leutze,_MMA-NYC,_1851.jpg
- The East India Company’s ship Bridgewater successfully defending her cargo from an attack by the American privateer Hampden on her way from St. Helena to England on 8th March 1779, dipinto di Francis Holman, 1779 [PD] Commons.
- ibidem, dettaglio.
- US Navy, 1993 c.a [PD] Commons.
- 1850 c.a, pubblicato in in The Literary History of Philadelphia di Ellis Paxson Oberholtzer (Philadelphia: George W. Jacobs & Co., 1906) [PD] Commons.
- 1873, foto di George Henry Preble: la bandiera di Fort McHenry del 1814 esposta al cantiere navale militare di Boston; da Frank A. O’Connell; Wilbur F. Coyle. National Star-Spangled Banner Centennial, Baltimore, Maryland, September 6 to 13, 1914. Baltimore: National Star-Spangled Banner Centennial Commission, 1914. p. 66. [PD]
- Independence Day Celebration in Centre Square, Philadelphia dipinto di John Lewis Krimmel (1819) [PD] Commons.
- Raising the Flag on Iwo Jima fotografia di Joe Rosenthal, 22 febbraio 1945. [PD] Commons.
- Luna, 21 luglio 1969, NASA [PD] National Archives
- Woodstock (USA), 18 agosto 1969. Fotogramma da registrazione video, autore sconosciuto.
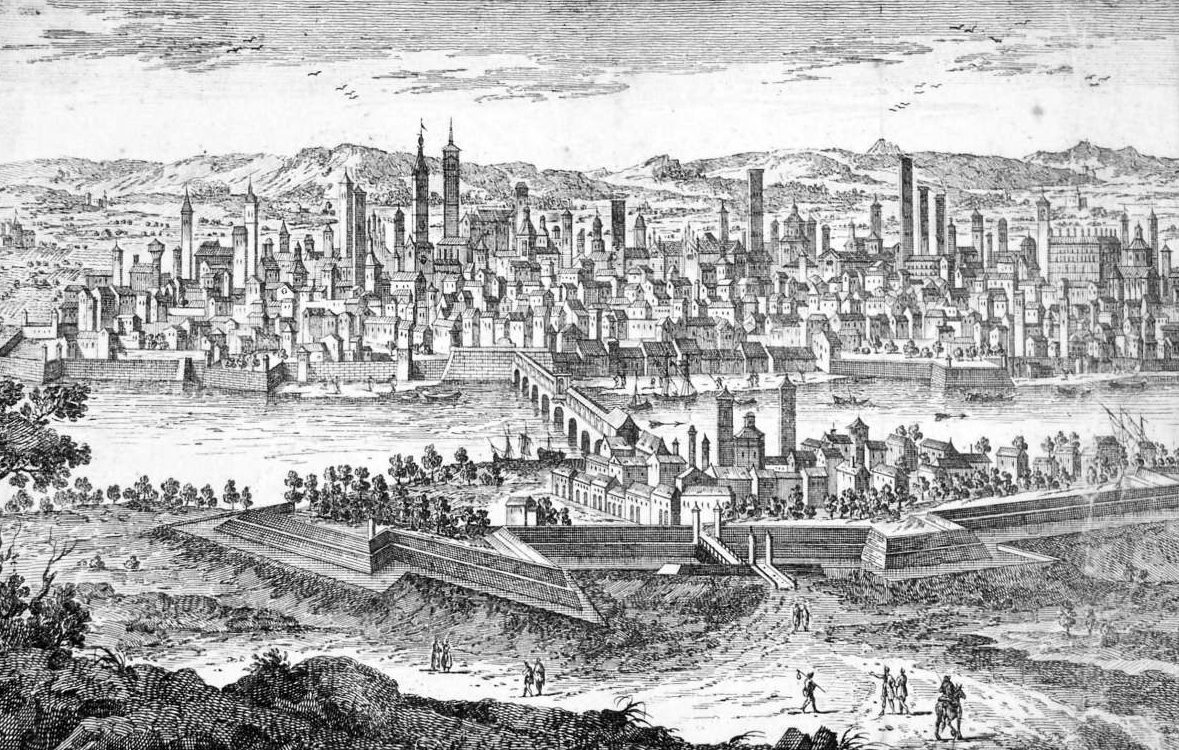
Veduta di Pavia del 1751.
È noto che la città di Pavia deplora, e soffre nella calda stagione i più tristi effetti di un’aria insalubre; motivo per cui trovasi essa in tal tempo abbandonata dai più agiati Cittadini, ed il resto del Popolo vi languisce vittima di morbi, che direbbonsi contagiosi.Carlo Castelli
Il dotto prelato esponeva quindi innanzitutto l’origine del problema: a suo dire erano «le acque che stagnano nelle vicinanze di Pavia quelle, a cui devesi attribuire l’infezione dell’aria […]. L’esperienza e la Fisica insegna che le acque prive di moto, specialmente se a piccolo spazio circoscritte, se dotate di poca profondità, se aventi fondo limaccioso, qualora comprese siano da un dato calore, si corrompono, che nella loro corruzione si generano[5] delle infette esalazioni, per cui rendesi insalubre, e contagiosa l’aria circostante».
Di paludi all’epoca, effettivamente, ce n’erano ancora parecchie, ad esempio nei pressi di San Lanfranco. Secondo l’autore però non potevano essere queste le acque che ammorbavano Pavia, sia per la loro distanza dall’abitato,[6] sia per i boschi che vi si frapponevano contribuendo a depurarne l’aria, sia perché le loro esalazioni dovevano per forza giungere in città attraverso l’azione di venti da nord ed «è un fatto, su cui ormai convengono tutt’i moderni e più oculati Fisici, che le esalazioni dei terreni i più paludosi sono pressoché nulla infette, qualora ci sono recate dai venti settentrionali». Le acque che producevano l’infezione dell’aria della città erano invece quelle che stagnavano nelle immediate vicinanze della stessa, e cioè quelle che si trovavano fra le porte Calcinara e Borgoratto[7] e quelle comprese tra il Ticino e il Gravellone,[8] cioè alle spalle del Borgo.
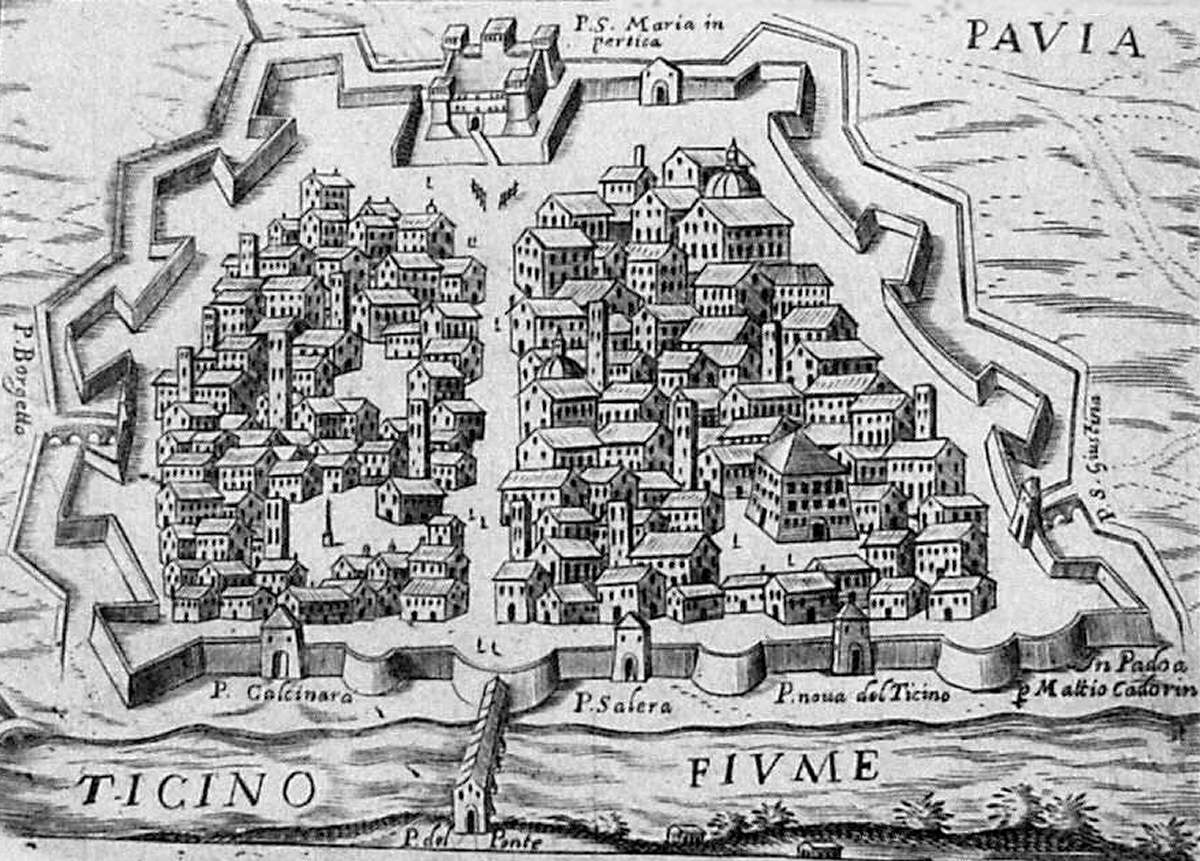
In questa pianta di Pavia di fine XVI secolo sono indicate le porte: a sinistra ed in bosso a sinistra si vedono rispettivamente “Porta Borgetto” (anche di Borgoratto), che si trovava in corrispondenza dell’attuale monumento alla Minerva, e “Porta Calicinara” sul Ticino, ancora esistente.
Per quanto riguarda le prime, «tali Paludi ebbero, com’è noto, origine da una forte irruzione, che il fiume Ticino fece contro il Baluardo di Porta Calcinara. […] Ritornato il fiume al primiero suo corso […] un danno ne sopravvenne non minore, per essersi fatto quel sito ricettacolo di torbide acque, cagione delle più infette esalazioni. La Roggia Carona,[9] ch’è destinata a portare le fecce delle città nel Ticino, venendo a perdere per questa Laguna la forza necessaria al trasporto delle fecciole materie, accrebbe, è vero, coi suoi depositi l’altezza di quel Fondo, ma lo rese tutt’insieme di più trista qualità». Si trattava quindi, in questo caso, non solo di acqua stagnante, ma anche inquinata, soprattutto a causa delle sporcizie trasportatevi dalla Carona, per di più a ridosso di un quartiere assai popolato.

Porta Calcinara a Pavia (Commons).

La roggia Carona in Strada Nuova, primi ‘900: in inverno veniva deviata in superficie e fatta scorrere lungo la via, per spazzare la neve accumulatasi.
Siccome l’origine di questa palude era da ricercarsi nell’erosione del fondale, la soluzione più semplice era «rimettere le cose nel primiero loro stato», cioè innalzare il fondo per evitare il ristagno di acqua. Il lavoro si sarebbe del resto potuto fare con poca spesa, utilizzando in primo luogo dei rottami ammassati presso le mura in occasione di demolizioni, i quali, fatti rotolare giù, potevano formare il primo strato. Inoltre, poco prima del ponte, si trovava un’isola formata da terra riportata dal fiume stesso,[10] che, trasportata per mezzo di barche, sarebbe stata utilissima per completare l’opera. A questo punto si sarebbe dovuto convenientemente mettere a coltura il terreno riguadagnato, anche servendosi dell’opera di privati, i quali, «perché il fiume non usurpi di nuovo, o renda infruttuoso il Fondo, sapran bene rimediare sul momento, e porre rimedio alle prime corrosioni con quelle difese […] che efficaci sono, adoperate in tempo opportuno.»

In questa pianta di Pavia del 1786 si vede, in basso (appena a monte del ponte e del Borgo) l’ “isola boschiva” formata dai due rami del Ticino che si ricongiungono poco prima del ponte.
Problema ben più grave rappresentava invece «l’isola compresa fra l’Alveo del Ticino, ed il suo ramo minore detto il Gravellone, quella è appunto che contiene il più ampio Teatro delle acque stagnanti a danno della città di Pavia. Uno sguardo, che diasi a quest’Isola nei Mesi Estivi, non incontra che Paludi, Lanche e Fossi, ricettacoli di oziose acque putrefatte. Il graveolento odore, che esalano, il torpore da cui il capo resta oppresso, e la difficile respirazione che provasi, fornisce una prova sperimentale, siccome dell’infezione dell’aria, che vi regna, così della causa, che la produce». L’area era caratterizzata da un livello del terreno più basso rispetto all’alveo dei due fiumi, e per di più ricco di irregolarità. Tuttavia, l’area interessata era troppo vasta e troppo diverse le motivazioni del fenomeno per farne una trattazione unitaria: «essendo detta Isola bipartita dalla strada, che dal Ponte Ticino porta al Gravellone, distinguo primieramente le acque, che stagnano nella parte dell’Isola posta alla destra di questa strada da quelle, che trovansi nella parte dell’isola posta alla sinistra della strada medesima: partitamente poi esamino quelle acque, che stagnano all’intorno del Borgo di S. Antonio[11]».

In questa pianta della Regia città di Pavia con suo borgo del 1792 si vede in basso il Borgo di S. Antonio (attuale Borgo Ticino). All’epoca era un’isola, «bipartita dalla strada, che dal Ponte Ticino porta al Gravellone», in quanto delimitata a nord dal Ticino e tutt’intorno dal ramo detto appunto Gravellone. L’abitato del Borgo era inoltre circondato dai bastioni realizzati tra il 1685 e il 1725.
Venendo alle prime, andava rilevato che il corso del Ticino si era modificato diverse volte negli anni, ora occupando nuovi terreni, ora lasciandone liberi altri prima coperti dalle acque.[12] In occasione di piene importanti avveniva che le acque, in ragione della loro forza, invadendo un’area già bassa e accidentata, contribuissero a creare nuovi rialzi e avvallamenti, e che non potessero poi ritirarsi completamente, lasciando acquitrini sui quali poi prosperavano la flora e la fauna tipiche delle zone palustri, con ulteriore peggioramento della qualità dell’aria. A sinistra della strada la situazione era anche più grave, perché si trattava di una zona ancor più depressa, tanto da essere inondata ad ogni minimo innalzamento delle acque del Ticino o del Gravellone. Come conseguenza di ciò, i proprietari non si curavano affatto di questi terreni, non potendo coltivarli. In verità erano stati aperti, in tempi diversi, alcuni canali e colatori con l’intento di far defluire le acque, ma essi erano ormai del tutto inutilizzabili a questo scopo, perché alcuni dei proprietari, nella speranza di trarre almeno un minimo vantaggio, avevano piantato delle “gabbe”,[13] utilizzando poi i canali per il trasporto della legna ottenuta, finendo quindi otturarli in gran parte con residui vegetali. Altri avevano munito i loro fondi di piccoli argini, con il pretesto di impedire le inondazioni, ma in realtà per poter catturare i pesci che restavano imprigionati negli avvallamenti del terreno quando l’acqua si ritirava, peggiorando in tal modo la situazione. Infine, le paludi adiacenti a Borgo Ticino erano le più perniciose per la salute pubblica, perché immediatamente a ridosso di una zona abitata, ed erano originate dai lavori di fortificazione avvenuti negli anni 1685 e 1725. Per costruire dei bastioni a protezione dell’abitato, si era recuperata la terra necessaria scavando delle fosse, a loro volta utilizzabili a fini difensivi, ma queste ultime, sia per le piene del Ticino, sia soprattutto per la difficoltà di far defluire l’acqua proprio a causa delle opere di difesa innalzate, e per incuria, si erano trasformate col tempo in fetidi acquitrini.

Veduta di Pavia dal confluente con il rotto del Gravellone, 1855-1859; dipinto di Francesco Trécourt (fondazione Cariplo),
Distinte dunque, e diverse son le cagioni delle Paludi esistenti nel circondario di quest’Isola. Provengono le prime dalla indole, e violenza del Fiume. Le seconde dalla natura del sito; e delle ultime n’è cagione l’opera e l’indolenza degli uomini. […] Diverse essendo le immediate cagioni del male, v’ha d’uopo a rimoverle un diverso rimedio.Carlo Castelli
Si trattava in effetti di un problema molto sentito dalla popolazione, tanto che il “volgo” proponeva diversi rimedi apparentemente di buon senso, tutti però confutati dal Castelli. I più ritenevano che la soluzione migliore fosse cingere tutto il perimetro della zona interessata con un alto e robusto argine, in modo da impedire l’ingresso delle acque e quindi il loro ristagno. Si trattava però di una soluzione impraticabile per diversi motivi, ad iniziare della spesa spropositata. Ma anche tralasciando questo aspetto, il rimedio non sarebbe stato sicuro, perché il fiume poteva essere assai impetuoso, e la sua direzione imprevedibile, senza contare che il materiale naturalmente a disposizione per l’opera (per lo più sabbia e ghiaia minuta) non avrebbe avuto la forza necessaria per reggere il peso dell’acqua. Inoltre, soprattutto nella zona del Gravellone, il livello del terreno era troppo basso, e l’acqua del fiume vi si insinuava «per travenazione», non solo dando origine a vere e proprie sorgive, ma impregnando il suolo anche laddove la terra pingue e argillosa sembrava ostacolarla efficacemente, rendendo quindi concreto il pericolo che l’aumento della pressione in caso di piene creasse dei fontanazzi. Infine, l’argine a nulla sarebbe valso contro la pioggia, che non potendo essere assorbita dal terreno già zuppo, né defluire a causa dell’argine stesso, avrebbe contribuito in tal modo ad alimentare ulteriormente gli acquitrini.
Altri, al contrario, proponevano non già di impedire l’accesso alle acque, ma anzi di sfruttare le piene per colmare i dislivelli per il tramite del deposito di materiali portati dallo stesso fiume. Anche questo ripiego però era da scartare, perché le acque del Ticino non sono sufficientemente torbide. La conferma di ciò veniva dal fatto che, nonostante il fiume esondasse nella zona da circa un secolo, non si era verificato alcun sensibile rialzamento dei terreni. Inoltre, anche nel caso in cui si fosse potuto avere qualche deposito consistente, sarebbero serviti secoli prima di giungere allo scopo. Altri ancora consigliavano di livellare i terreni interessati, togliendo terra dalle zone più alte per colmare gli avvallamenti più profondi, ma ciò era infattibile, perché l’area era troppo depressa, e, per di più, i pochi fondi leggermente rialzati erano terreni coltivi tanto preziosi quanto rari, la qual cosa avrebbe certo causato l’opposizione dei proprietari, soprattutto perché, appena al di sotto dei pochi palmi di terra fertile, si trovava solo ghiaia.

Il ponte medievale sul Ticino a Pavia, dipinto di Riccardo Pellegrini: 1900 circa (Fondazione Cariplo).
V’era anche chi riteneva la soluzione migliore aprire un canale derivatore a monte del “Ponte Ticino” per tenere in movimento l’acqua delle paludi, impedendone la putrefazione in estate. Ciò non solo avrebbe comportato la perdita di quei terreni, perennemente inondati, ma avrebbe soprattutto minacciato di deviare stabilmente l’intero corso del fiume, eventualità che «sì fatale riuscirebbe» da dover essere evitata con la massima cura.[14] Esisteva poi lo «specioso progetto» di impedire il debordamento del Ticino «mediante un rettifilo del suo cavo», nella speranza di aumentare la velocità delle acque grazie ad una via più breve, ipotesi di cui l’autore dimostra l’insussistenza, giacché la velocità dei fiumi dipende soprattutto dalla loro foce. Se lo sbocco fosse libero, e il Ticino si gettasse in Po tramite una cascata, l’idea avrebbe anche potuto avere qualche fondamento, ma la loro confluenza avviene pressoché allo stesso livello, tanto che si poteva ben osservare che spesso, durante le piene, erano le acque del Po ad introdursi in Ticino.
Da ultimo, l’autore fa cenno ad «un altro più grande disegno» da lui stesso concepito, cioè dare al Ticino uno sbocco più basso, onde fornire alle acque una maggiore pendenza. In seguito ad uno studio di fattibilità più approfondito, il Castelli aveva però abbandonato l’idea, sia per la propensione del Po «di cambiar direzione, e di otturare con le sue deposizioni le bocche de minori Fiumi influenti», sia per il pericolo che la maggiore declività del Ticino ne avrebbe, soprattutto in tempi di magra, messo a repentaglio la navigabilità.[14]
Ma qual sarà mai il provvedimento per me adottato a riparo di sì grave disordine?Carlo Castelli
Per quanto atteneva agli acquitrini a destra della strada, si sarebbe dovuto iniziare dando sistematicità agli “arginelli” già costruiti dai proprietari dei terreni, riparandoli e livellandoli laddove necessario, e costruendone di nuovi, in modo da impedire l’ingresso di altra acqua in caso di piene di lieve e media entità. Le “bassure” poste al di sotto del livello del Ticino e del Gravellone sarebbero poi state spurgate, per abbassarne il fondo fino a raggiungere la ghiaia, indice di comunicazione con l’aves (cioè la falda acquifera). Queste sarebbero poi state messe in comunicazione con gli stagni vicini posti ad un livello più alto tramite dei canali di scolo, in modo da divenire dei bacini di raccolta. In sostanza, meno specchi d’acqua ma di maggiore capacità: l’accresciuta quantità di liquido e il costante ricambio garantito dalla comunicazione diretta con la falda ne avrebbero impedito l’eccessivo riscaldamento e quindi l’imputridimento. Ovviamente l’indispensabile manutenzione di tutto il sistema avrebbe avuto un costo, ma enormemente inferiore di quello necessario per scavare dei canali direttamente comunicanti con il fiume.
Le paludi a sinistra della strada, come si è detto, erano caratterizzate da un fondo più basso, sommerso ad ogni minimo innalzamento del livello del Ticino e del Gravellone. Nell’attuale situazione di incuria ciò rappresentava indubbiamente uno svantaggio, ma questa continua comunicazione con le acque fluviali rendeva la zona atta ad impiantarvi una marcita.[15] Per fare ciò era innanzitutto necessario lo scavo di un colatore[7] posto nel punto più basso della zona; la terra così recuperata sarebbe stata utilizzata per il livellamento dell’area. Lo scorrere dell’acqua nella marcita, lento ma costante, ne avrebbe impedito la fermentazione.

Le case del Borgo Basso sul Ticino (Commons / CC BY-SA 4.0).
Misure più radicali richiedevano le paludi nei pressi del Borgo, in quanto la zona era abitata. La terra dei bastioni che — come detto — le avevano prodotte avrebbe potuto essere utilizzata per colmarle, tanto più che quelle fortificazioni erano ormai considerate inutili dallo stesso governo. Ma perché non pensare a risolvere contemporaneamente anche il problema delle piene, che tanto frequentemente affliggevano i borghigiani? Si lasciassero i bastioni dov’erano, anzi li si completasse ove mancanti, in modo da poter fare da argine, se non ai nemici, almeno all’acqua del Ticino! Per fungere efficacemente allo scopo, li si sarebbe dovuti abbassare ad un altezza pari al piano della strada che andava verso il Gravellone, giacché sarebbe stata inutile una maggiore altezza delle sponde se il livello dell’acqua fosse salito a sufficienza da entrare comunque per quella via. La terra così ottenuta si sarebbe utilizzata per creare un piano inclinato, risolvendo così il problema degli acquitrini posti sulla destra del Borgo. Quelli sulla sinistra, però erano troppo estesi e la terra recuperata non sarebbe stata sufficiente. Era però possibile restringere la cerchia degli argini al solo abitato, realizzando così un notevole avanzo di materiale di riporto, di nuovo utilizzabile per l’interramento dei restanti stagni all’interno della cerchia. Restava il problema degli acquitrini rimasti al di fuori. «Gli estremi mali ricercano estremi rimedj»: mancando la terra per riempirli, si attendesse un periodo di siccità per asportare non solo i canneti e le erbe palustri, ma la terra stessa, scavando fino a trovare la ghiaia, in modo da convertire l’intera area in una darsena, confinante con le ultime case del Borgo e utilissima per il ricovero, la costruzione e la riparazione delle imbarcazioni, nonché per il carico e scarico delle mercanzie.
Ovviamente al Prevosto Castelli non sfuggiva l’aspetto economico delle sue proposte, che riconosceva non di poco conto. Tuttavia, posta la premessa che il problema aveva soluzioni tanto limitate quanto necessarie, aveva ragionato su come contenere il più possibile i costi. Innanzitutto non prevedeva la costruzione di opere in muratura: tutto si riduceva allo spostamento di terra e allo scavo di canali, per realizzare i quali si sarebbe potuto far ricorso alle macchine allora esistenti, in modo da ridurre l’utilizzo di manodopera. Inoltre i canali sarebbero stati utilizzabili anche per il trasporto di materiale e persone tramite barche, già in corso di esecuzione dei lavori, riducendone la durata. Infine, per la manovalanza si sarebbe fatto ricorso in primo luogo «ai Forzati e Condannati», che ovviamente non sarebbero stati pagati, e quindi ai mendicanti, «obbligando così i poveri a prestarsi giusta le lor forze al servizio di quest’Opera».[16]
Tutto ciò considerato, la spesa preventivata per tutti gli interventi proposti era stimata in 207 000 lire austriache.[17] «Se tale spesa sembrasse nelle attuali circostanze alquanto gravosa», si considerasse che i lavori potevano essere eseguiti in tempi diversi, cominciando dalle paludi vicino a Porta Calcinara, affare di piccola entità. In secondo luogo, la spesa non doveva necessariamente gravare interamente sul governo della Lombardia Austriaca: «la Provincia, la Camera, i pubblici Spedali, i Luoghi Pii, la Navigazione, l’Agricoltura, il Commercio, la Pescagione potendo sentir vantaggio delle disegnate provvidenze, parmi, che possan chiamarsi a parte delle spese per le medesime richieste». Per di più, avvalendosi «della gente più bisognosa e del più basso popolo» si sarebbero spesi dei soldi in cambio di lavoro a vantaggio della pubblica utilità anziché in sovvenzioni «alla oziosa mendicità». Ultimo ma non ultimo, si sarebbero garantiti l’onore e la salute «di una Città delle più ragguardevoli dello Stato». ∎
Note
- [1]«Professore emerito di fisica e socio di svariate accademie»↩
- [2]op. cit.↩
- [3]Ciambellano di S.M., Consigl. Int. Att. di Stato, e Primo Consultore presso il R. Governo della Lombardia Austriaca.↩
- [4]Rerum senilium libri, lettera a Boccaccio del 17 dicembre 1365, in cui questi viene invitato dal Petrarca a raggiungerlo presso Pavia. Il Petrarca fu effettivamente ospite di Galeazzo II Visconti diverse volte, tra il 1363 e il 1369.↩
- [5]L’autore sembra dare credito alla cosiddetta teoria della generazione spontanea: si riteneva in sostanza che gli esseri viventi più semplici, come i vermi e gli insetti, potessero nascere spontaneamente dal fango o da carcasse in putrefazione. Tale credenza venne confutata definitivamente solo nel 1864 da Louis Pasteur.↩
- [6]Ovviamente dobbiamo pensare ad una Pavia molto più ristretta di quella attuale e limitata, grossomodo, al recinto delle Mura spagnole.↩
- [7]Porta Calcinara è ancora esistente e la si può ammirare, per quanto per nulla valorizzata, nei pressi dell’omonima via. Era indicata con questo nome perché dedicata soprattutto allo scarico della calce. Porta di Borgoratto si trovava alla fine dell’attuale Corso Cavour (zona Minerva) e venne abbattuta negli Anni Venti del secolo scorso.↩
- [8]All’epoca era a tutti gli effetti un ramo del Ticino. Venne canalizzato nel corso dell’Ottocento, divenendo un colatore, e scorre tutt’ora a sud di Pavia. Si tratta peraltro di un corso d’acqua importante dal punto di vista della Storia pavese e non solo: fu infatti il confine tra la Lombardia austriaca e il Regno di Sardegna fino al 1859. Varcandolo, il 29 marzo 1848 Carlo Alberto diede inizio alla Prima guerra di indipendenza.↩
- [9]Altro corso d’acqua molto caro ai pavesi, nasceva da un fontanile nei pressi di Zibido San Giacomo. Il ramo principale, la Carona Magistrale, entrava in città da Mirabello, dividendosi poi in vari rami. La Carona di Strada Nuova, quella di cui parla l’autore, staccatasi da un ulteriore ramo (la Carona dei Mulini), arrivava nell’area dell’attuale Porta Milano, portandosi poi all’imbocco di strada Nuova, che era ed è tuttora percorsa nel suo sottosuolo da una cloaca fognaria di epoca romana. In condizioni metereologiche normali la roggia era incanalata in tale cloaca per tenerne pulito il fondale, ma in inverno, in occasione di nevicate sulla città, veniva deviata in superficie e fatta scorrere lungo la via, per spazzare la neve accumulatasi.↩
- [10]Il corso del Ticino era diverso rispetto ad oggi, e diviso, a monte del Borgo, in due rami che si riunivano poco prima del ponte, tra i quali si trovava appunto l’ “isola boschiva” di cui parla il Castelli.↩
- [11]Cioè l’attuale Borgo Ticino. Gli antoniani, chiamati anche “cavalieri del fuoco sacro”, erano un ordine di canonici ospedalieri. Si dedicavano alle cure degli ammalati di ergotismo (il “Fuoco di San Antonio”, termine che oggi si riferisce invece ad una particolare forma di Herpes Zoster). A Pavia si trovavano presso la zona al di fuori di Porta San Vito, oggi Porta Milano. Nel 1360 furono “sfrattati” da Galeazzo II per la costruzione del Castello Visconteo e si trasferirono in Borgo Ticino, dove costruirono una chiesa con ospedale per il ricovero dei pellegrini.↩
- [12]Le acque del fiume erano all’epoca assai meno “obbligate” nel loro defluire e più libere di sfogare.↩
- [13]Cioè piante di salice bianco, un albero deciduo presente in tutte le regioni d’Italia, che cresce presso i laghetti e nelle zone umide, su suoli da argillosi a fangosi periodicamente inondati. Il legno non marcisce presto in terreni saturi di acqua; i rami giovani, soprattutto di piante capitozzate, sono utilizzati come vimini per la costruzione di ceste, sedie, ecc. Il termine potrebbe però anche riferirsi, genericamente, a qualsiasi pianta venga capitozzata.↩
- [14]Pavia era una città fluviale e la stabilità del Ticino come via d’acqua era fondamentale per la sua economia. Peraltro, l’autore sostiene che il fiume, non molti anni prima, aveva minacciato di fare esattamente quanto paventato, comportando per la città «cure, e spese gravissime».↩
- [15]La marcita è una tecnica colturale caratteristica della Pianura Padana; essa consiste nell’utilizzo dell’irrigazione a gravità anche nella stagione invernale. L’acqua viene mantenuta in continuo movimento dalla conformazione dolcemente declinante del terreno, impedendo in questo modo che il suolo ghiacci; lo sviluppo della vegetazione prosegue così anche durante l’inverno rendendo possibile effettuare annualmente almeno sette tagli di foraggio (ma spesso anche nove), contro i 4-5 ottenuti dalla coltivazione del migliore prato stabile. Il nome di marcita deriva dall’antica consuetudine di lasciare l’ultimo taglio invernale a “marcire” nel prato irriguo.↩
- [16]«Si avrebbe da ciò il modo di liberare la Città dalla mendicità oziosa, o di sottrarla dal peso del suo mantenimento, qualora i poveri per iscansare il lavoro si appigliassero alla fuga».↩
- [17]È impossibile calcolare con precisione l’entità della spesa attualizzata, ma si può provare a rendere l’idea. In Lombardia la sostituzione della lira austriaca con la lira italiana avvenne in contemporanea con l’occupazione sabauda del 1858, con il cambio 1 lira austriaca = 0,86 lire italiane. Si otterrebbero così 178.020 lire italiane. Secondo l’Istat, tale cifra nel 1861 equivaleva a circa 858 000 euro del 2014. Applicando in maniera arbitraria un tasso di inflazione medio dell’1% per il periodo che va dal 1792 (anno della pubblicazione dello studio del Castelli) fino al 1861, si otterrebbe un totale, probabilmente sottostimato, di circa 1 450 000 euro.↩
Bibliografia e fonti
- Castelli, Carlo Piano ragionato […] sui mezzi più efficaci per liberare la Città di Pavia, e suoi dintorni dall’infezione dell’aria, che vi domina, Milano: presso Giuseppe Galeazzi, 1792
- Manfredi, Rodolfo Dizionario Pavese-Italiano, coll’aggiunta delle frasi più comuni. Pavia: Stabilimento Tipografico Successori Bizzoni e Milano, presso Carlo Brigola, 1874.
- Atti del Consiglio Provinciale di Pavia, Pavia: Tipografia dell’Artista Grossi e Comp., 1871.
Piove, filtra poca luce dalle tende, è un tipico pomeriggio d’autunno a Milano. La mia amica Tina versa il thè in tazzine di rara bellezza e mi parla pacatamente, come sempre, mentre mi racconta la storia della zia Antonietta, del suo fascino e della sua eleganza (celebri nella Milano degli anni Trenta e rimasti proverbiali in famiglia), ma anche della sua disperazione per quell’unico figlio maschio rimasto ucciso proprio l’ultimo giorno di guerra. Sì, proprio l’ultimo giorno, mi assicura Tina, perché il figlio della zia Antonietta, Ludovico, morì l’8 settembre 1943 combattendo sull’Aspromonte contro i canadesi, una manciata di ore prima che venisse proclamato via radio l’armistizio tra il Regno d’Italia e gli Alleati. Povera zia Antonietta e povero Ludovico, che destino tragico. E che sfortuna, morire proprio l’ultimo giorno di guerra. Mentre bevo il thè e attraverso il fiume dei ricordi di Tina penso a quest’uomo e a ciò che deve avere rappresentato per la sua famiglia, se dopo più di settant’anni il suo ricordo è ancora così vivo. Alla fine non posso fare a meno di congedarmi dalla mia amica con una promessa: ricostruire, almeno in parte, la vicenda di Ludovico. E quella che segue è (anche) la storia del suo ultimo giorno di vita.
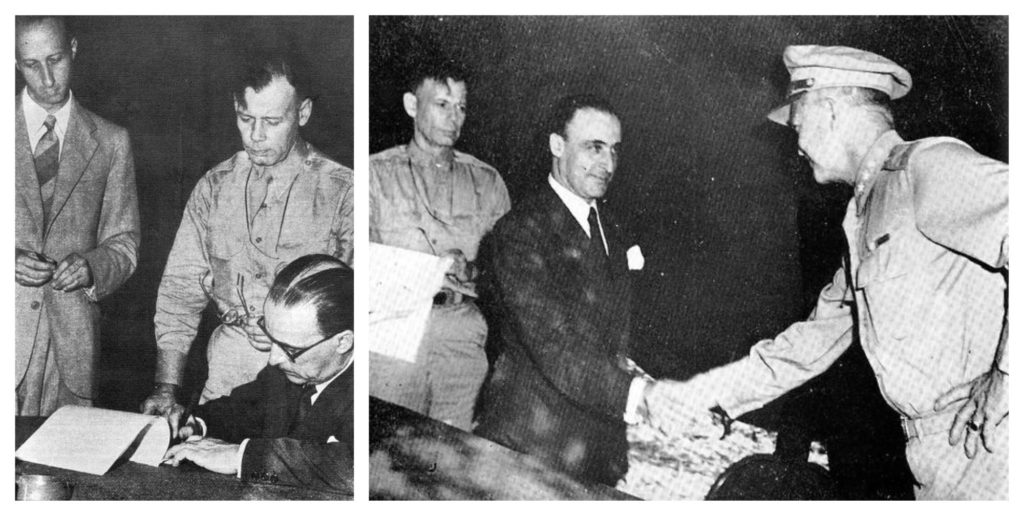
Cassibile (Siracusa) 3 settembre 1943. A sinistra, il generale Giuseppe Castellano sigla l’armistizio per conto di Badoglio. A destra, Castellano stringe la mano a Eisenhower subito la firma.
Ludovico Picolli de Grandi, classe 1910, nel settembre 1943 era capitano di complemento della Divisione “Nembo”, l’unità di paracadutisti del Regio Esercito che letteralmente si sfaldò all’annuncio dell’armistizio, quando ogni singolo componente della Divisione, posto di fronte ai tragici fatti dell’8 settembre, scelse secondo coscienza da quale parte schierarsi: un certo numero di paracadutisti continuò a combattere con i tedeschi contro gli Alleati, nei ranghi della Repubblica Sociale Italiana (RSI), e un altro numero, invece, entrò a far parte del cosiddetto esercito co–belligerante che risalì la Penisola combattendo con gli Alleati contro i tedeschi.[1]

Paracadutisti dell’Aeronautica Militare Repubblicana (R.S.I.) durante un’esercitazione a Venegono Superiore (VA) nel 1943.
Non è detto, quindi, che se fosse sopravvissuto all’8 settembre Ludovico sarebbe tornato vivo dalla campagna d’Italia, come la storiografia anglo–americana si pregia di definire i fatti d’arme che fecero da cornice alla guerra civile che dilaniò l’Italia tra il settembre 1943 e l’aprile 1945 (e oltre).[2] Ma Ludovico non fece in tempo a fare alcuna scelta di campo, né militare né ideologica, perché l’8 settembre 1943, che per molti soldati italiani fu il giorno della vergogna, fu per lui — e per l’intero VIII battaglione del 185º Reggimento di fanteria paracadutisti della Divisione “Nembo” — il giorno del sacrificio supremo e della gloria. Almeno così ammonisce la lapide eretta nel 1995 sull’Aspromonte, nei luoghi dello scontro tra italiani e canadesi, che perentoria afferma:
«Qui sullo Zillastro, epigone di una guerra disastrosa, l’8 settembre 1943, suscitando l’ammirazione ed il rispetto delle preponderanti forze Anglo–Canadesi, i quattrocento paracadutisti dell’VIII Btg. del 185º Rgt. della div. NEMBO, combattendo per l’onore della Patria, si coprirono di gloria».
A questo punto andrebbe ricordato perché Ludovico e gli altri paracadutisti della “Nembo” si trovavano sull’Aspromonte nell’autunno del 1943. E per farlo occorre ricordare che il citato 185º Reggimento di fanteria paracadutisti, in cui Ludovico serviva, aveva fatto parte della 1ª Divisione paracadutisti del Regio Esercito, creata nel settembre 1941 e in seguito denominata 185ª Divisione paracadutisti “Folgore”[3]. Anziché essere inviato in Africa come gli altri reggimenti della “Folgore” (poi annientati a El Alamein), il 185º Reggimento era rimasto in Patria per costituire il nerbo di una nuova divisione paracadutisti, la 184ª Divisione “Nembo”, creata il 1º novembre 1942 con il concorso dei nuovi reggimenti in via di addestramento presso le Scuole di paracadutismo di Tarquinia e di Viterbo[4]. In ragione del più avanzato grado di preparazione, il 185º Reggimento fu il primo reparto della neo–costituita “Nembo” ad essere impiegato in combattimento (a partire dall’aprile 1943 nella zona di Gorizia, per contrastare le infiltrazioni dei partigiani jugoslavi in territorio friulano), mentre il resto della Divisione venne trasferito, nel giugno 1943, in Sardegna, presunto obiettivo della temuta invasione alleata[5].
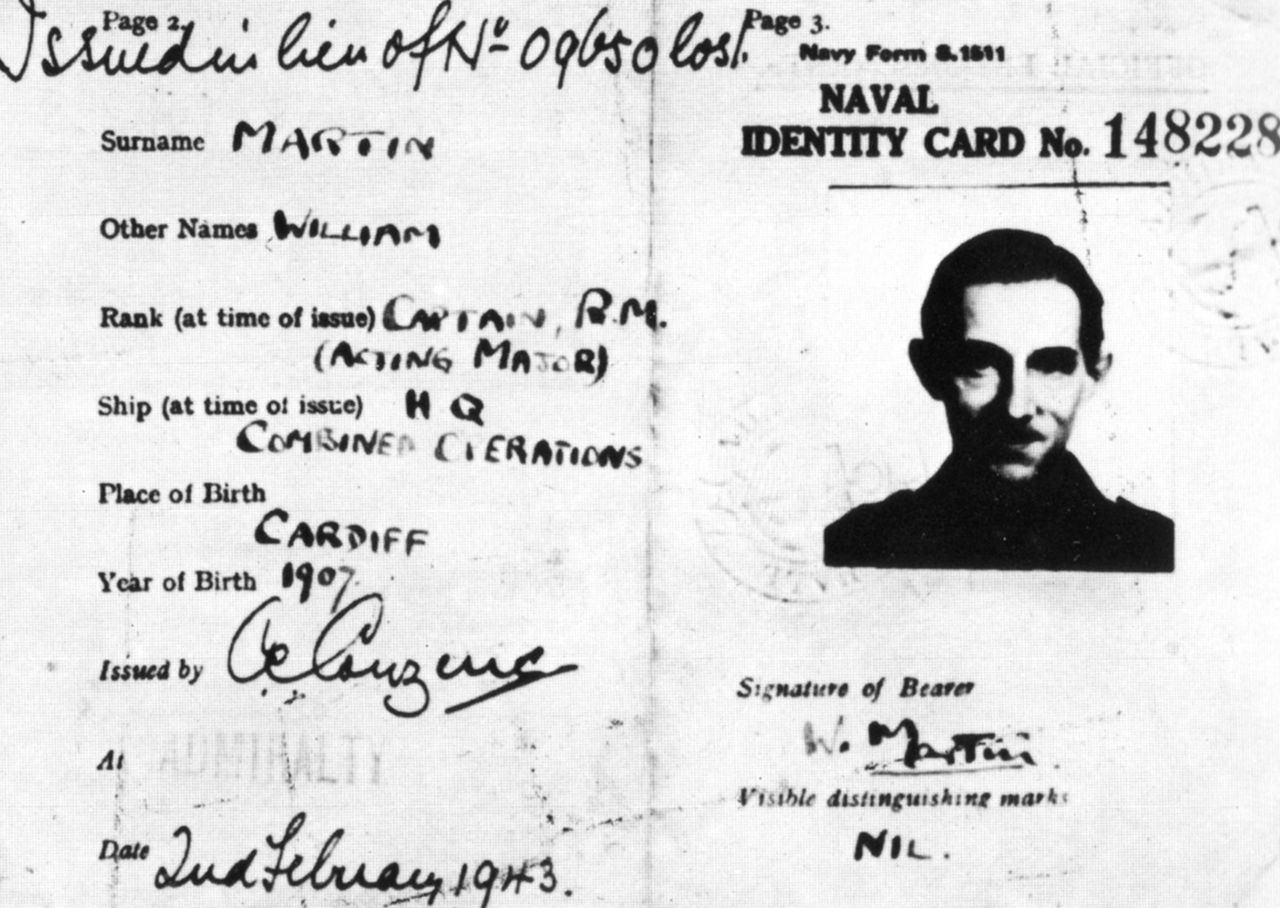
Operazione “mincemeat“: il documento di identità militare del “falso” Maggiore William Martin. Facendo rinvenire sulle spiagge spagnole il cadavere di un falso ufficiale dei Royal Marines (in realtà un senzatetto) munito di falsi documenti e di falsa corrispondenza, l’intelligence britannica era riuscita a convincere il controspionaggio tedesco che lo sbarco nell’Europa del Sud sarebbe avvenuto in Sardegna e in Grecia, anziché in Sicilia.
Lo sbarco in Sicilia, vero obiettivo degli anglo–americani (operazione Husky), colse quindi di sorpresa i comandi italiani, che, nel tentativo di frenare l’avanzata anglo-americana, inviarono nell’isola invasa anche il 185º Reggimento (composto dai battaglioni III, VIII e IX). Con la caduta della Sicilia, avvenuta il 17 agosto, il Reggimento rientrò in Calabria; ma qui fu presto costretto a riprendere contatto con gli Alleati, sbarcati sul continente il 3 settembre (operazione Baytown).

Operazione “Husky”: l’esercito britannico sbarca a Licata il 10 luglio del 1943 (foto: Lt. C.H. Parnall, 1943, Imperial War Museum).

Operazione “Baytown”: gli alleati sbarcano a Reggio Calabria il 3 settembre del 1943 (foto: No. 2 Army Film & Photographic Unit / Imperial War Museum)
In Calabria, i primi scontri tra la “Nembo” e le forze britanniche si verificarono nei pressi del nodo stradale di Gambarie d’Aspromonte, che domina le camionabili verso lo Ionio e il Tirreno, ma la preponderante superiorità numerica del nemico convinse il comando italiano a disimpegnare il 185º Reggimento per riorganizzarlo su una nuova linea difensiva. Così, mentre il III e il IX battaglione iniziarono a ripiegare verso Nord, l’VIII battaglione si schierò di retroguardia nella zona tra Bagaladi e San Lorenzo, per contrastare l’avanzata degli Alleati. Anche stavolta, tuttavia, la sproporzione tra le forze in campo convinse il comando di battaglione a rompere il contatto con il nemico e a iniziare il ripiegamento: alla sera del 7 settembre ciò che restava dell’VIII battaglione raggiunse Piano dello Zillastro, tra Platì e Oppido Mamertina, nel cuore dell’Aspromonte, e qui si accampò per la notte, l’ultima della sua esistenza.
All’alba dell’8 settembre, in una splendida faggeta posta a più di 1 000 metri di altitudine, i 400 paracadutisti italiani sono sorpresi dai soldati canadesi di due diversi reggimenti (il West Nova Scotia e l’Edmonton), che durante la notte, quasi senza rendersene conto, li hanno raggiunti e accerchiati nella loro avanzata verso Nord. Non appena capiscono di essere circondati, i paracadutisti, piuttosto che arrendersi, attaccano al grido «Nembo!» e combattono — nella proporzione di 1 contro 12 — fino all’esaurimento delle munizioni, passando poi al corpo a corpo con pugnali e baionette e imponendosi all’ammirazione dello stesso nemico. Il numero dei caduti italiani non è mai stato accertato: sepolti sul posto, solo cinque corpi furono recuperati nel dopoguerra[6] Tra questi, secondo alcune fonti, anche il corpo del capitano Ludovico Picolli de Grandi, ucciso nel tentativo di liberare il comandante di battaglione catturato dai canadesi nelle prime fasi del combattimento e per questo insignito della medaglia d’argento “alla memoria”[7].
Quella di Piano dello Zillastro è stata l’ultima battaglia combattuta dal Regio Esercito contro le forze anglo–americane durante la seconda guerra mondiale. E dopo di essa, come già ricordato, i paracadutisti italiani prenderanno strade diverse: alcuni continueranno a combattere con i tedeschi nei ranghi della RSI, altri si schiereranno dalla parte degli Alleati. I primi si scontreranno con gli anglo–americani a Lanciano, Ortona, Orsogna (dicembre 1943) e sul fronte di Anzio, fino alle porte di Roma (Castel di Decina, giugno 1944)[8]; i secondi contro i tedeschi a Monte Marrone (marzo 1944) e a Filottrano (luglio 1944), solo per citare i nomi delle battaglie più note. Va infine ricordato che, subito dopo l’8 settembre, alcuni elementi della Divisione “Nembo” di stanza in Calabria diedero vita ad un reparto (denominato “1º Reparto Speciale Autonomo” e, dal marzo 1944, “Squadrone da Ricognizione F”) che svolgerà attività di ricognizione, incursione e sabotaggio per gli anglo–canadesi e che, nella notte del 20 aprile 1945, avrà l’onore di svolgere l’ultima operazione aviotrasportata della seconda guerra mondiale, paracadutandosi dietro le linee tedesche nella zona tra Modena, Ferrara e Mantova (operazione Herring)[9].

Paracadutisti italiani salgono a bordo di un aereo statunitense Douglas C-47 Dakota/Skytrain all’aeroporto di Rosignano per l’operazione “Herring”, 20 aprile 1945.

Crocifisso dello Zillastro (o di Zervò).
A celebrare il sacrificio dell’VIII battaglione del 185º Reggimento di fanteria paracadutisti della Divisione “Nembo” ha provveduto, nel 1951, l’amministrazione comunale di Oppido Mamertina, che fece collocare una croce metallica sul luogo della battaglia. Vent’anni dopo, nel 1971, la stessa amministrazione fece erigere un’altra croce, nei pressi della quale fu posta, nel 1995, la lapide recante l’epigrafe citata in precedenza. Ciò nonostante, e sebbene si svolga ogni anno una cerimonia in ricordo dei paracadutisti caduti, la battaglia di Piano dello Zillastro rimane una delle meno conosciute tra quelle svoltesi in Italia durante la seconda guerra mondiale, evidentemente perché combattuta contro il nemico “sbagliato”, come gli assetti politici e strategici del dopoguerra — e il conseguente allineamento di una parte consistente della storiografia e della pubblicistica europea e atlantica — hanno indotto molti italiani a ritenere.
Ma, forse, la cosa più tragica nella morte di Vico — come lo chiama ancora oggi la mia amica Tina — e degli altri “sacrificati” di Piano dello Zillastro è che il nemico contro cui vollero combattere fino alla morte, l’8 settembre 1943, non era più nemmeno tale, poiché l’armistizio proclamato alla radio dal Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio alle ore 19,45 di quello stesso 8 settembre era stato firmato in Sicilia il 3 settembre, e cioè cinque giorni prima. ∎
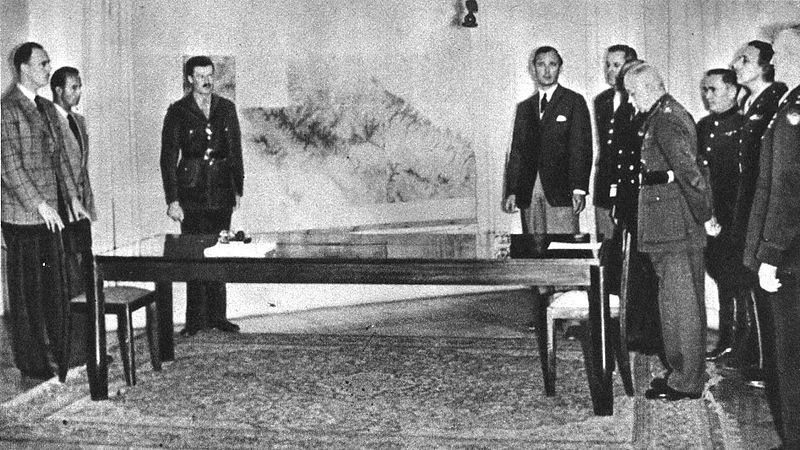
Resa di Caserta: il 29 aprile 1945 i delegati tedeschi (a sinistra) sottoscrivono la resa definitiva presso il quartier generale delle forze alleate in Italia, nel palazzo della Reggia dei Borbone a Caserta.
Riproduzione riservata
Note
Il titolo del presente articolo riprende quello di un celebre film di guerra diretto da John Ford, interpretato da Robert Montgomery (che curò anche parte della regia), John Wayne e Donna Reed e distribuito dalla Metro–Goldwin–Mayer a guerra ormai terminata, nel dicembre 1945 (in Italia il film è circolato con un doppio titolo: I sacrificati e I sacrificati di Bataan). Nella finzione cinematografica, uno squadrone di motosiluranti statunitensi di stanza nelle Filippine combatte contro le preponderanti forze giapponesi subendo uno stillicidio continuo di uomini e mezzi, fino all’inevitabile, eroico, annientamento. Il film si ispirava alle reali vicende di guerra del Motor Torpedo Boat Squadron Three, di stanza a Cavite tra il settembre 1941 e l’aprile 1942, il cui comandante fu insignito della Medal of Honor, la più alta decorazione statunitense al valore militare.
- [1]A seguito dell’armistizio, tra le unità della Divisione schierate in Sardegna (dove si trovavano dal giugno 1943) si verificarono gravi disordini e sbandamenti, che furono sedati con difficoltà e che portarono all’arresto di alcuni ufficiali (tra cui il vice comandante della Divisione), oltre che alla destituzione del comandante della Divisione medesima: l’episodio più rilevante fu la diserzione del XII battaglione (comandato dal maggiore Mario Rizzatti), che si unì alla 90 Panzergrenadier–Division tedesca, seguendola prima in Corsica e poi sul continente. Anche tra le unità della Divisione schierate in Calabria (dove si trovavano dal luglio 1943) si verificarono disordini e sbandamenti: il III battaglione, quasi per intero, si unì alle forze tedesche presenti nella zona, ripiegando verso la Campania con la 29 Panzergrenadier–Division (il comandante del III battaglione, capitano Edoardo Sala, in quell’occasione coniò il motto che in seguito avrebbe accomunato tutti i combattenti della RSI: “Per l’Onore d’Italia”). Gli elementi della Divisione “Nembo” schieratisi con i tedeschi — insieme ad alcune compagnie del 10º Reggimento Arditi, agli Arditi Distruttori della Regia Aeronautica (ADRA), ad alcune compagnie della costituenda terza ed ultima Divisione di paracadutisti del Regio Esercito (la Divisione “Ciclone”) — formarono il primo reparto paracadutista della RSI, denominato “Raggruppamento Volontari Paracadutisti Italiani” (in seguito “Raggruppamento paracadutisti “Nembo”), che poi confluirà nei reparti paracadutisti della Aeronautica Nazionale Repubblicana della RSI. Diversamente, le unità della “Nembo” rimaste fedeli al Governo del Re costituirono il “185º Reparto Autonomo Arditi Paracadutisti Nembo”, che venne dapprima incluso nel “1º Raggruppamento motorizzato” e poi riassorbito dalla Divisione, rientrata dalla Sardegna nell’aprile 1944 per essere impiegata sulla Linea Gustav. Pochi mesi più tardi, nel settembre 1944, la Divisione “Nembo” sarà comunque sciolta e parte dei suo elementi confluirà nel “Reggimento fanteria paracadutisti Nembo” inquadrato nel “Gruppo di combattimento Folgore” (che comprendeva anche il “Reggimento Marina San Marco” articolato sui battaglioni “Bafile”, “Grado” e “Caorle”, nonché il “Reggimento artiglieria paracadutisti Folgore”). Per approfondimenti, si rimanda ai volumi editi dall’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito: Il I Raggruppamento motorizzato italiano (1943 — 1944), Roma, 1949; Il Corpo italiano di liberazione (aprile — settembre 1944), Roma, 1971 (II ed.); I Gruppi di combattimento Cremona Friuli Folgore Legnano Mantova Piceno (1944-1945), Roma, 1951.↩
- [2]Che si sia trattato di una guerra civile e fratricida — più che di una guerra di “liberazione” — è confermato dai numerosi e più o meno noti episodi di guerra partigiana, che videro confrontarsi unità regolari e non della RSI (dall’Esercito Nazionale Repubblicano alla Guardia Nazionale Repubblicana alle Brigate Nere) e formazioni partigiane di diversa estrazione politica ed esperienza militare: episodi cui, come molti sanno, dopo il 25 aprile 1945 fecero seguito regolamenti di conti e vendette politiche e personali. Ma forse non tutti sanno che, ancora poche settimane prima della fine della guerra, nel marzo 1945, sul fiume Senio si scontrarono i militi del 1º battaglione bersaglieri d’assalto “Forlì”, composto da giovani fascisti toscani e romagnoli, e i fanti del “Gruppo di combattimento Folgore”: cfr. https://digilander.libero.it/lacorsainfinita/indice/in43.htm#SUD icon [type=”external-link”], consultato nel novembre 2018, nonché Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, I Gruppi di combattimento, cit., pag. 256. Le vicende della stessa Divisione “Nembo” confermano quanto affermato: basti qui ricordare che, nel tentativo di convincere gli elementi del XII battaglione (di cui si è detto alla nota precedente) a restare fedeli al Re, trovò la morte il tenente colonnello Alberto Bechi Luserna, capo di stato maggiore divisionale, ucciso per mano di un altro paracadutista.↩
- [3]Le premesse del paracadutismo militare italiano sono sufficientemente complesse da impedirne la trattazione esaustiva in questa sede (cfr., per approfondimenti, N. Arena, Folgore. Storia del paracadutismo militare italiano
, Roma, 1969). Sinteticamente può dirsi che — dopo alcuni esperimenti condotti in Libia con militari indigeni — nell’ottobre 1939 venne creata a Tarquinia la Regia Scuola Paracadutisti dell’Aeronautica, che licenziò le prime unità dell’Esercito nel luglio 1940. Alcuni elementi di queste unità entrarono in azione il 30 aprile 1941 paracadutandosi sull’isola greca di Cefalonia, senza peraltro incontrare resistenza. Al settembre 1941 la consistenza organica delle unità in questione era ormai tale da permettere la costituzione della 1ª Divisione Paracadutisti, destinata ad essere impiegata nell’ambito della progettata invasione di Malta (operazione C3). Tuttavia, l’evolversi della campagna nordafricana determinò l’annullamento di quest’ultima operazione e il trasferimento in Nord Africa della 1ª Divisione, ribattezzata dapprima (per ragioni di intelligence) 185ª Divisione “Cacciatori d’Africa” e in seguito, nell’agosto del 1942, 185ª Divisione paracadutisti “Folgore”.↩
- [4]Si trattava del 184º Reggimento di fanteria paracadutisti e del 184º Reggimento di artiglieria paracadutisti, costituiti tra l’agosto e il settembre 1942, cui si aggiunse, nel gennaio 1943, il 183º Reggimento di fanteria paracadutisti.↩
- [5]Con l’operazione Mincemeat (letteralmente, “carne trita”) l’intelligence britannica — facendo rinvenire sulle spiagge spagnole il cadavere di un falso ufficiale dei Royal Marines munito di falsi documenti e di falsa corrispondenza — era riuscita a convincere il controspionaggio tedesco che lo sbarco nell’Europa del Sud sarebbe avvenuto in Sardegna e in Grecia: la vicenda, descritta dallo stesso ideatore del piano (Ewen Montagu) in un libro del 1954 dal titolo The man who never was, ispirò nel 1956 il film omonimo diretto da Ronald Neame e interpretato da Clifton Webb.↩
- [6]Secondo C. Sframeli, “L’ultima battaglia della Divisione Nembo: fedeltà nel sacrificio” , in Strettoweb.com del 12 settembre 2013, qualche tempo dopo gli scontri il parroco di Platì fu chiamato a benedire la faggeta denominata “Mastrogianni”, perché un impresario boschivo, procedendo al taglio di quei faggi, aveva rinvenuto diversi resti umani.↩
- [7]A onor del vero, la motivazione della decorazione al valore (inizialmente, nel 1945, una medaglia di bronzo, commutata nel 1949 in medaglia di argento) non fa menzione del tentativo ricordato. Del resto, contrariamente a quanto affermano alcune fonti, tradizione famigliare vuole che al Cimitero Monumentale di Milano si trovi solo il cenotafio di Ludovico, il cui corpo non sarebbe stato mai ritrovato, né tanto meno consegnato alla famiglia. Per fugare ogni dubbio in proposito, l’autore si riserva di svolgere le necessarie ricerche presso l’archivio del Cimitero Monumentale.↩
- [8]Negli scontri di Castel di Decina trovò la morte, il 4 giugno 1944, il maggiore Mario Rizzatti, comandante di quel XII battaglione che, come detto alla nota 2, dalla Sardegna aveva seguito i tedeschi in Corsica e poi sul continente. Alla memoria di Rizzatti, caduto eroicamente mentre attaccava un carro armato Sherman armato soltanto di mitra e bombe a mano, la RSI conferì la medaglia d’oro al valore militare alla memoria.↩
- [9]In proposito si veda Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, I Gruppi di combattimento, cit., pag. 304 e ss. A dar vita al 1º Reparto Speciale Autonomo furono un pugno di paracadutisti del III battaglione (quello citato alla nota 1, che quasi per interno passò dalla parte dei tedeschi) al comando del capitano Carlo Francesco Gay, grazie anche all’intuizione e ai buoni uffici di un ufficiale inglese di origine italiana, il capitano Casimiro “Kim” Tomasi Isolani (1917-2004), distaccato presso la 1ª Divisione canadese. Tomasi Isolani, infatti, dopo un primo incontro con i paracadutisti comandati da Gay, li convinse ad entrare a far parte del gruppo esplorante della 1ª Divisione canadese, indipendentemente dagli accordi armistiziali e prescindendo da ogni considerazione di ordine politico: cfr. https://digilander.libero.it/lacorsainfinita/indice/in43.htm#SUD ” , consultato nel novembre 2018). Successivamente, nel novembre 1943, il Reparto passò alle dipendenze del XIII Corpo inglese. Per completezza, va ricordato che all’operazione Herring partecipò anche la “Centuria di Paracadutisti del Reggimento Nembo”, un reparto composto da volontari provenienti dal “Reggimento fanteria paracadutisti Nembo” del “Gruppo di combattimento Folgore” citato alla nota 1.↩
La cripta dei Chase agli inizi del ‘900, da West Indian tales of old (Londra 1915).
A voice spoke from the deep:
«Who is it sits all on my grave,
and will not let me sleep?»
Una voce parlò dal profondo
«Chi è seduto sulla mia tomba
e non mi lascerà dormire?»
The Unquiet Grave (La tomba inquieta), ballata popolare britannica
Sin dall’antichità si crede che i fantasmi siano le anime dei “morti inquieti”, intrappolati tra il mondo dei vivi e impossibilitati a raggiungere quello dei morti: destino questo riservato tanto agli insepulti, cui è mancata cioè una degna sepoltura, quanto ai morti ante diem, ossia prima del compimento del proprio legitimus tempus fati.[2] Una morte prematura quindi, proprio come accadde alla piccola Mary Anna Chase, deceduta nel 1808 a soli due anni, ed alla sorella Dorcas di quattro, che la raggiunse nel 1812. E al padre Thomas, suicidatosi solo un mese dopo. Una storia lugubre cui fa seguito un enigma sconcertante: tumulate nella cripta di famiglia nel piccolo cimitero coloniale britannico di Christ Church, ad ogni apertura della pesante lastra di marmo che ne chiudeva l’accesso le bare vennero ritrovate spostate e senza apparenti segni di effrazione. Non siamo però nell’Inghilterra dei castelli diroccati e delle antiche magioni, ma a Oistin Bays sull’isola di Barbados nel mar dei Caraibi, luogo forse più adatto ad una cartolina che ai racconti di fantasmi. E a differenza di questi ultimi, i fatti della cripta dei Chase sembrano essere ben documentati.
2 – Le incantevoli spiagge di Oistin Bay, Barbados.
Barbados è la più orientale delle isole dei Caraibi e la sua posizione geografica ne ha influenzato profondamente la storia e la cultura: comunemente considerata parte dell’arcipelago delle Piccole Antille, limite geografico fra il mar dei Caraibi e l’oceano Atlantico, in realtà si trova molto ad est rispetto a queste e relativamente isolata. Primo approdo quindi per le navi che provenivano dall’Atlantico, l’isola fu dal tardo XVII secolo un collegamento principale tra la Gran Bretagna, il continente africano e gli stessi Caraibi. Mentre le altre isole passavano di mano in mano tra le potenze coloniali, l’isolamento di Barbados contribuì ad una certa stabilità tanto che fu possedimento britannico ininterrottamente dal 14 maggio 1625, quando fu rivendicata come tale per conto del re Giacomo I d’Inghilterra[3] dal capitano Henry Powell, fino al 1966 quando ottenne l’indipendenza pur restando nell’ambito del Commonwealth.
Sull’isola si insediarono sin dai primi anni ricchi tenutari britannici che disboscarono gran parte della superficie per coltivare tabacco, cotone, canna da zucchero (importata dal Pernambuco ad opera degli olandesi nel 1640[4]) e, primi nei Caraibi, barbabietola da zucchero. Le piantagioni si rivelarono molto produttive e l’economia dell’isola prosperò a discapito degli schiavi importati dall’Africa per soddisfare la crescente richiesta di manodopera. Il diplomatico britannico George Downing annota che nel 1645 furono importati «non meno di mille neri»[4] e nel 1651 lo statuto di Barbados ammetteva candidamente che la fonte principale di ricchezza degli abitanti consisteva «nel lavoro dei loro servi».[4]
Inglesi quaccheri e schiavi africani in una piantagione di tabacco a Barbados, stampa olandese del 1700 c.a (New York Public Library )
Nel 1812 sarebbe stata purtroppo raggiunta dalla sorellina maggiore Dorcas, affetta da un male oscuro che oggi sarebbe stato forse diagnosticato come anoressia: quando morì, all’età di quattro anni, si disse che si era lasciata morire di fame nel disperato tentativo di sfuggire alla brutalità del padre. Che fosse vero o semplicemente maldicenze dovute alla sua cattiva fama, l’uomo più detestato di Barbados fu sopraffatto dal dolore per questa seconda, terribile perdita e soltanto un mese dopo, nell’agosto del 1812, si tolse la vita. Si racconta che ci vollero otto uomini per spostare la pesante lastra di marmo che chiudeva l’accesso, ma quando la cripta fu di nuovo aperta il 9 agosto per deporre la salma del colonnello, uno spettacolo inquietante si rivelò agli occhi dei presenti: le bare erano state evidentemente spostate da mani ignote e quella della piccola Mary Ann Maria aveva apparentemente attraversato la stanza e si trovava appoggiata nell’angolo opposto. La prima reazione dei bianchi convenuti al funerale fu ovviamente di accusare i lavoratori neri della profanazione, ma questi — altrettanto ovviamente — negarono con decisione di aver profanato la tomba. Le bare furono rimesse a posto aggiungendo il feretro di Thomas Chase; la cripta fu richiusa con cura e sigillata con il cemento.
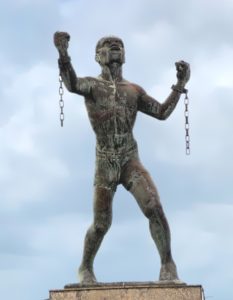
6 – Monumento alla “rivolta di Bussa” del 1816, eretto a Bridgetown nel 1985. La schiavitù a Barbados fu abolita nel 1834.
Tuttavia ciò era molto improbabile: nonostante il (comprensibile) risentimento nei confronti dello schiavista e degli inglesi tutti, la popolazione di colore era piuttosto superstiziosa e nessun africano o creolo avrebbe voluto nemmeno avvicinarsi al cimitero dopo il tramonto, per via delle voci sinistre che avevano iniziato a circolare sulla cripta. Figuriamoci entrare in una tomba di notte. Gli stessi inglesi, che pur non perdevano occasione per incolpare i negroes, non erano del tutto convinti di questa spiegazione perché il locale disponeva di un solo accesso e la pesante lastra di marmo blu del Devonshire che chiudeva l’ingresso non presentava segni di manomissione. Inoltre, se le bare delle bambine e della signora Goddard erano relativamente leggere, Thomas Chase era un uomo corpulento e la sua bara, rivestita internamente in piombo, aveva richiesto otto[8] o addirittura dodici[9] uomini per essere trasportata. Quante persone sarebbero state necessarie per mettere a soqquadro l’intera cripta?

L’attuale chiesa parrocchiale di Christ Church a Oistin, Barbados, nella parrocchia civile omonima. Intorno si vedono le varie cripte interrate del cimitero (foto: Commons ).
La stanza fu accuratamente ispezionata dal governatore e dai suoi attendenti alla ricerca di botole, passaggi, crepe, segni di manomissione, ma senza successo. Risistemate per l’ennesima volta le bare, il pavimento fu cosparso di finissima sabbia, in modo che un eventuale intruso non avrebbe potuto evitare di lasciare impronte. La lastra che chiudeva l’ingresso fu infine nuovamente sigillata con il cemento, sul quale però diversi funzionari, compreso il governatore, apposero questa volta i propri suggelli. Ormai la curiosità era altissima, l’intera isola parlava del mistero dei Chase e la popolazione fremeva per assistere alla prossima apertura. In mancanza del pretesto di un morto da metterci dentro o forse, come riferisce il reverendo Orderson, in conseguenza di un «rumore udito nella notte»,[10] il governatore ordinò una ispezione d’ufficio allo scopo di verificare lo stato del caveau. L’apertura straordinaria fu fissata per il 18 aprile 1820 e quel giorno migliaia di persone si affollarono dentro e fuori il piccolo cimitero, tanto che i villaggi rimasero deserti. La curiosità vinse sulle superstizioni e superò le barriere sociali: perfino i lavoratori neri si mischiarono ai bianchi nella folla galvanizzata[] e per un giorno almeno furono tutti uguali, uniti da un misto di ansia ed eccitazione per l’inspiegabile.
Da Memoirs and correspondence of field–marshal viscount Combermere (1866), vol. I pag. 391[]
Oltre allo stesso governatore le fonti citano tra i presenti all’ispezione, Mr. R. Bowcher Clarke (forse parente della sepolta Thomasina), Mr. Rowland Cotton, l’on. Nathan Lucas, il reverendo Orderson, rettore della parrocchia e il maggiore J. Finch, segretario militare del governatore, e una manovalanza di una decina di neri piuttosto riluttanti.[13] Ispezionato accuratamente l’esterno e verificata la perfetta integrità dei sigilli, si procedette con l’apertura dell’accesso. Questa volta, però, la lastra sembrava bloccata da qualcosa. Con grande sforzo gli operai riuscirono a spostare il marmo solo di qualche pollice e quando l’apertura fu sufficiente a far passare una persona si poté constatare che a bloccare la lastra era il pesante feretro di Thomas Chase appoggiato contro di essa. All’interno, le bare erano ancora una volta spostate e — fatto ancor più incredibile — il tappeto di sabbia fine era intonso, prova certa che né l’acqua né l’uomo erano entrati nella cripta. La bara della piccola Mary Ann Marie era stata scagliata con tanta violenza contro la parete opposta da lasciare un segno nell’arenaria. Fu eseguito un disegno dello stato della cripta e redatto un memorandum manoscritto siglato dal parroco Orderson:[13]
Signed Thomas H. Orderson,
Rector.
Firmato Thomas H. Orderson,
Rettore
da Folk–Lore, 1907[10]
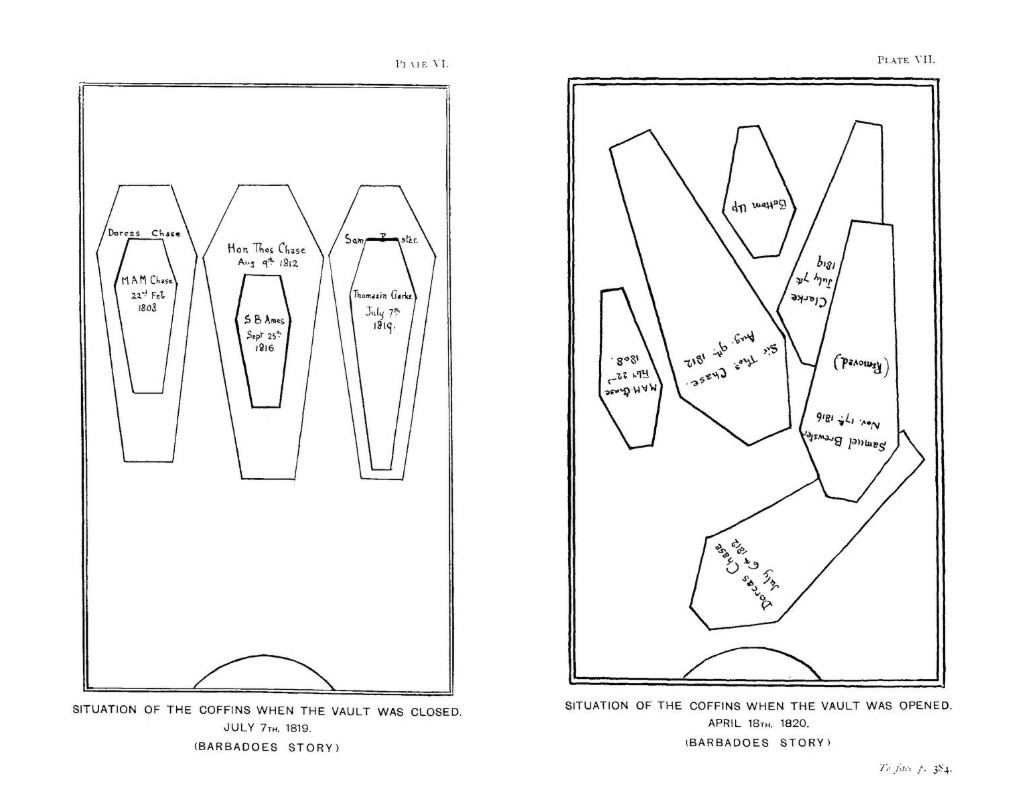
Disposizione delle bare al 7 luglio del 1819 e come furono all’apertura il 18 aprile 1820: schizzo riportato da Folk–Lore nel 1907 (op. cit.)
Quando è troppo è troppo. Fu ordinato che le bare venissero immediatamente rimosse e interrate separatamente; la cripta da allora fu lasciata aperta e vuota come si trova ancora oggi e nessuno la usò più. Da allora non si verificò più alcun fatto inspiegabile al suo interno o nel piccolo cimitero. La terza moglie del governatore, Mary Woolley, pubblicherà le Memorie e corrispondenza del Visconte Combermere a Londra nel 1866. La schiavitù a Barbados sarebbe stata definitivamente abolita nel 1834.
Quale misteriosa forza tormentava l’eterno riposo dei Chase? Già all’epoca qualcuno ipotizzò che fosse l’effetto di qualche attività vulcanica o sismica, ma non furono registrate attività sismiche rilevanti a Barbados tra il 1812 ed il 1820. Altra ipotesi è quella dell’acqua: nel 2014 lo scrittore e divulgatore scientifico Brian Dunning in un suo articolo su Skeptoid[8] ha calcolato che la bara di Thomas Chase avrebbe dovuto pesare non più di quattrocento chilogrammi per essere agevolmente spostata da otto uomini; pertanto, ipotizzando un volume tra i 400 e i 900 litri, per il principio di Archimede avrebbe potuto galleggiare. Una delle spiegazioni più bizzarre fu invece quella fungina:[9] il 19 luglio del 1952 apparve sul tabloid londinese Everybody’s Weekly un articolo sul caso della cripta dei Chase. Poco tempo dopo l’autore, Valentine Dyall, fu contattato da tale Mr Gregory Ames di Londra il quale esibì una lettera scritta il giorno di Natale del 1820 dal bisnonno barbadiano, parente stretto degli Ames (padre e figlio) sepolti nella cappella e testimone oculare dell’accaduto. Nella lettera, il bisnonno sosteneva che la causa dello spostamento delle bare fosse un fungo “esplosivo” che cresce abitualmente nelle grotte e nelle caverne di Honduras. Si riferiva probabilmente a qualche tipo di “vescia” o puffball fungi, nome volgare sotto cui vanno diverse specie fungine che, giunte a maturazione, rilasciano una piccola nuvola di spore che sembra una esplosione. A sostengo di ciò riferiva anche la testimonianza di uno schiavo anziano di Barbados, il quale gli aveva raccontato che il motivo per cui la cripta non ospitava il corpo del John Elliott che l’aveva fatta costruire nel 1724, era che si preferì seppellirlo altrove per via di misteriosi suoni, come «esplosioni ovattate», che si udivano al suo interno; questo molto tempo prima che vi fossero sepolti i Chase. Tuttavia le testimonianze sottolineano l’accuratezza delle ispezioni e non fanno menzione di funghi o tracce di essi; inutile dire poi che non si conoscono funghi esplosivi di tale potenza da spostare o fare a pezzi delle bare. Non mancarono poi teorie occultistiche o (in tempi più recenti) addirittura“ufologiche”[9] sulle quale non vale la pena dilungarsi. Escludendo forze soprannaturali, per molti la spiegazione più ovvia fu il vandalismo da parte dei lavoratori neri delle piantagioni. Avevano il movente, ossia la vendetta nei confronti dello schiavista Chase e della popolazione bianca in genere. Né le loro proteste d’innocenza, né il terrore che li teneva al largo dal cimitero furono considerate prove sufficienti a scagionarli. Del resto, «è colpa del nero» è un leitmotiv di cui — ancor oggi — il mondo occidentale fatica a sbarazzarsi. Ma già allora non tutti erano d’accordo sulla tesi dolosa e il tappeto di sabbia ritrovato intatto all’ispezione del 1820 certo non contribuiva ad avvalorala.
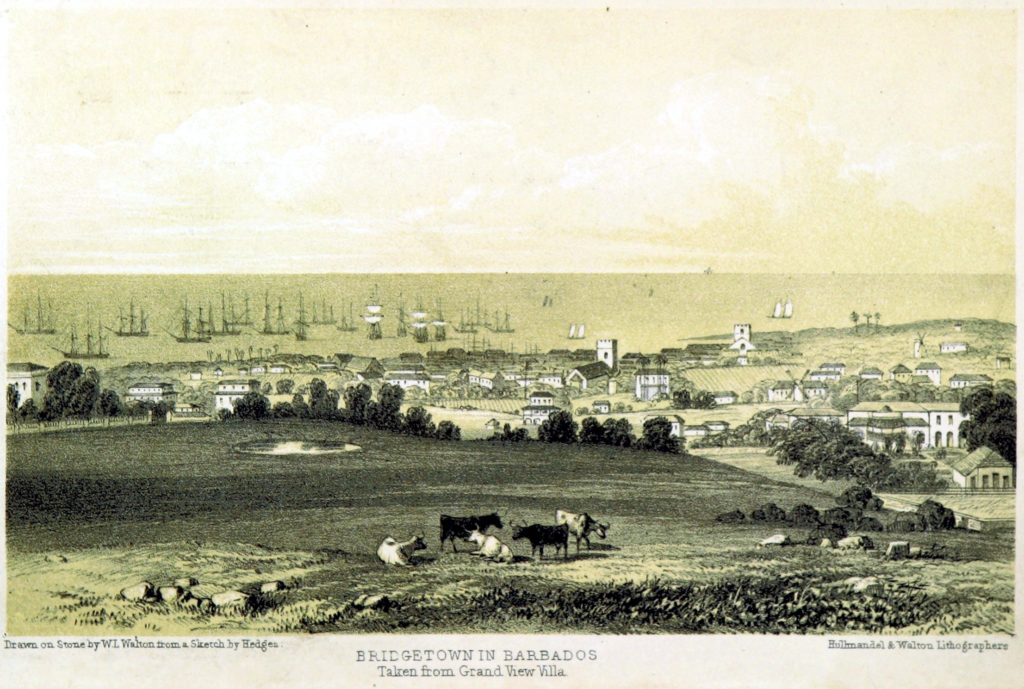
Bridgetown, il capoluogo di Barbados, in una litografia da The History of Barbados di R. H. Schomburgk, 1848 (op. cit.)
In effetti c’è una spiegazione ancor più semplice al fenomeno delle “bare erranti” di Barbados, e cioè che nulla di tutto ciò sia mai accaduto. La cripta è lì ancor oggi, essa stessa prova della propria esistenza ma non di ciò che vi avvenne all’interno. Il Book of Christ Church, il registro della parrocchia, conferma le sepolture[14] ma — proprio in quanto documento meramente burocratico — non fa menzione degli strani fatti ad esse collegati. Se esistettero altri registri, andarono probabilmente perduti nell’uragano del 1831 che distrusse la chiesa. A Barbados esistevano però i giornali: il Barbados Gazette veniva pubblicato dal 1731, ma la cronaca dell’epoca non fa menzione di questa storia, il che è molto strano se è vero, come si legge nelle Memorie e corrispondenza di Combermere, che i fatti di Christ Churh destarono molto clamore e interesse sull’isola. La prima testimonianza scritta e sopravvissuta sembra essere il libro del 1833 Transatlantic Sketches nel quale il capitano James Alexander annota le sue visite «nei luoghi più interessanti del Nord e Sud America, e le indie Occidentali [i Caraibi, n.d.a] con note sulla schiavitù nera e l’emigrazione canadese». Il capitano Alexander spende per la famigerata cripta qualche paragrafo, trattandola alla stregua di una curiosità locale da Lonely Planet: «Non è generalmente noto che a Barbados c’è una misteriosa cripta, dove nessuno osa depositare i morti. È in un cimitero in riva al mare».[15] Il libro tuttavia non riporta alcuna fonte, ed essendo Alexander salpato solo nel 1831 va da sé che la sua non può essere una testimonianza di prima mano. Nello stesso anno (1833) la storia venne raccontata dal giornalista Thomas Byerley (1789–1826), noto con lo pseudonimo Reuben Percy, nella “Percy’s Anedocte Gallery” del settimanale The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction (nº 22), ma cita come fonte proprio il libro del capitano Alexander. Nel 1848 anche il libro The history of Barbados del geografo Robert Herman Schomburgk, pubblicato anch’esso a Londra, tratta brevemente i fatti, con qualche differenza: sostiene che solo due volte si fosse trovata la cripta in disordine e che Lord Combermere avesse solo sentito parlare delle «misteriose circostanze» e che avesse presenziato all’ultima apertura, nel 1820. Sfortunatamente, anche Schomburgk non cita alcuna fonte se non «un disegno della posizione in cui furono trovate le bare, alcune copie del quale sono ancora presenti sull’isola». Si trattava probabilmente di copie del disegno che, secondo diverse fonti, fu tratto in occasione del sopralluogo del 1820 insieme al memorandum del reverendo Orderson. Uno di questi disegni fu pubblicato anche dalla celebre rivista letteraria inglese Once a Week dell’11 marzo 1865 ad accompagnamento di un articolo sul caso:
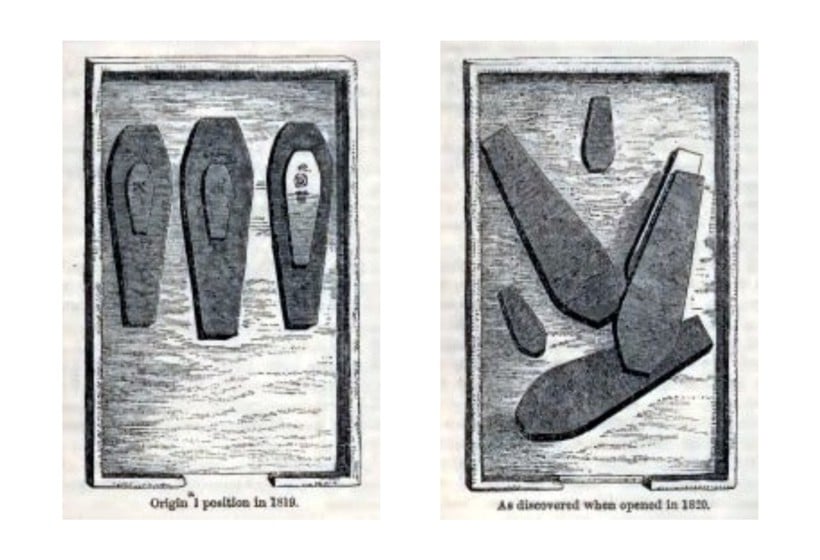
Il disegno della disposizione delle bare nella posizione originale e all’apertura nel 1820, pubblicato su Once a Week del 11 marzo 1865.
È interessante notare che tutte le fonti finora citate siano state pubblicate a Londra; sempre nella capitale britannica furono dati alle stampe nel 1860 un libretto anonimo sulla vicenda intitolato Death’s Deed, e nel 1866 le già citate Memorie e corrispondenza del governatore di Barbados, Lord Combermere, a cura della terza moglie Ann Woolley. Ques’ultimo conteneva sì un dettagliato resoconto sui misteriosi fatti del cimitero di Christ Church, a dispetto del titolo non si trattava però di una testimonianza diretta del governatore ma una ricostruzione della Woolley che per quanto riguarda la storia della cripta affermava di essersi basata su un «libello stampato e fatto circolare privatamente da un abitante dell’isola». Tuttavia, secondo il West Indian Tales of Old di sir. A. E. Aspinall (1915), il libello che ispirò la Woolley non fu stampato a Barbados ma anch’esso in Inghilterra: sarebbe infatti nient’altro che il sopraccitato Death’s Deed pubblicato a Londra sei anni prima.[13] Insomma, sembra che le fonti portino tutte a Londra e che siano, quando va bene, di seconda mano.
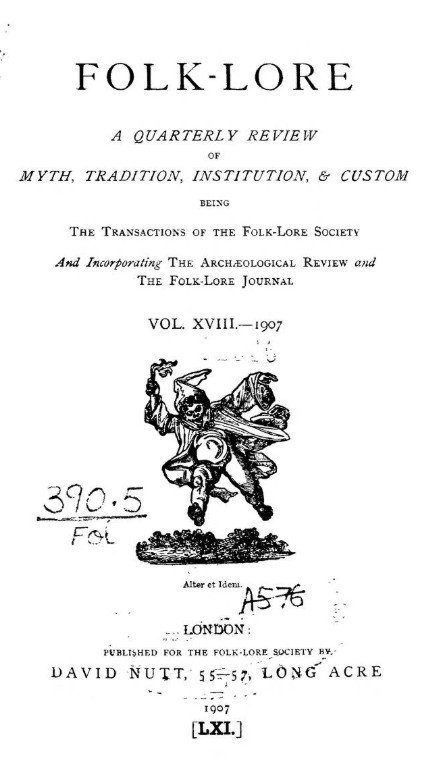
Frontespizio della rivista Folk–Lore, vol. XVIII, 1907.
Ma il fatto che il documento non fosse datato e che Anderson potesse essere la storpiatura di Orderson, il parroco che effettivamente aveva firmato il registro dei funerali dal 1803 al 1820,[14] suggeriva che il manoscritto fosse in realtà una copia, nemmeno troppo accurata, di qualche altro documento. E in effetti è molto simile al resoconto firmato proprio da «Thomas Harrison Orderson, D.D.», il parroco di Christ Church, riportato sul già citato Death’s Deed del 1860: ancora una volta le fonti sembrano riportare a Londra. Mr. Alleyne recuperò e inviò a Lang una terza versione, quella riportata sopra, leggermente diversa ma firmata sempre da Orderson e trascritta «da una vecchia copia in possesso della sorella di Mr. Clarke, che fu presente all’ultima apertura della cripta» (il che sembra essere un equivalente del moderno «mio cugino mi ha raccontato che…»). Una ulteriore versione del memorandum è attribuita invece all’on. Nathan Lucas, testimone oculare, e “certificata” (sic) dal parroco Orderson: è riportata nel libro West Indian Tales of Old di Algernon Edward Aspinall, pubblicato — di nuovo a Londra — nel 1915. Il disegno che la accompagna è diverso da quelli riportati da Once a Week nel 1865 e dal Folk–Lore nel 1907: questa volta è prospettico, e anche la posizione delle bare è differente.
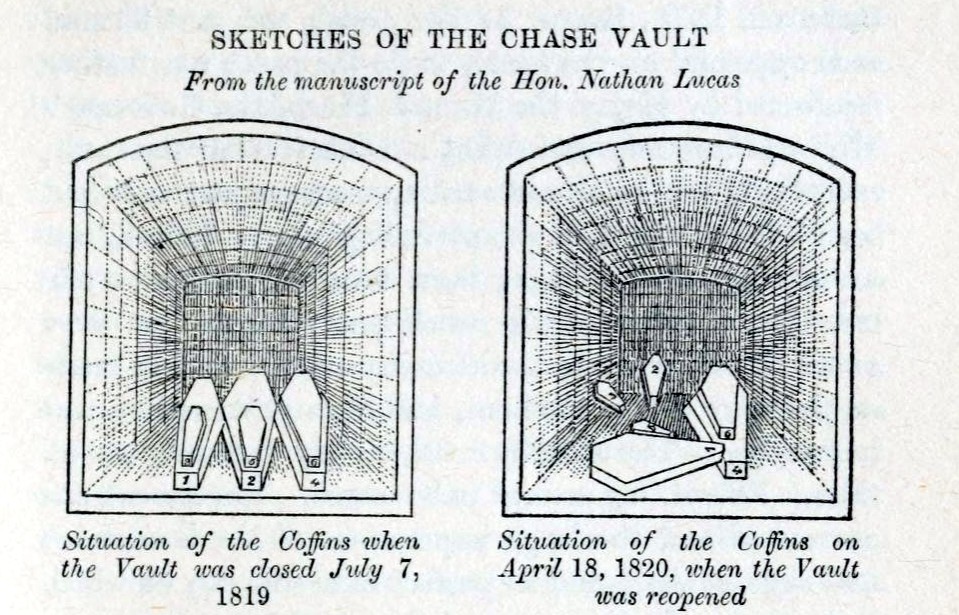
Posizione delle bare quando la cripta fu chiusa il 7 luglio del 1819 e quando fu riaperta il 18 aprile del 1820, dal «manoscritto dell’Hon. Nathan Lucas» come riportato da sir Aspinall in West Indian Tales of Old (1915, op. cit.).
Tra tutte queste copie e trascrizioni diventa difficile capire quale sia quella originale o per lo meno quella che vi si avvicini maggiormente. Ammesso che quel documento “originale”, scritto dal reverendo Orderson o dall’onorevole Nathan Lucas o entrambi che fosse, sia mai esistito. La vicenda della scripta dei Chase ha infatti in sé tutti gli elementi di quello che probabilmente è, ossia null’altro che una leggenda metropolitana ante litteram. C’è l’elemento misterioso o disturbante; è ricca di dettagli (nomi, date) che conferiscono legittimità alla storia rendendola più “vera”; ci sono testimoni autorevoli, come Lord Combermere, o apparentemente “vicini” come il parente che ha assistito all’apertura, ma ad una analisi più approfondita non si riesce mai ad arrivare alle fonti originali.

Kuressaare (Estonia), già Ahrensburg, in una cartolina del 1900.
Lang rileva inoltre l’incredibile somiglianza della vicenda con un’altra, collocata in Estonia nel 1844. C’è sempre un’isola, quella di Ösel — altrimenti nota come Saaremaa — nel mar Baltico. C’è un cimitero, questa volta luterano, quello di Ahrensburg (oggi Kuressaare). C’è una cappella, quella della famiglia Buxhoewden. A causa di strani ed inquietanti rumori, la cappella venne aperta e le casse vengono trovate «impilate disordinatamente». Anche qui ci furono resoconti ufficiali, i sigilli inviolati e — anziché la sabbia — la cenere di legna sparsa sul pavimento a rilevare eventuali impronte di profanatori; ma le bare furono trovate comunque in disordine e la cenere intatta esattamente come a Barbados. Inoltre le date delle aperture erano addirittura coincidenti: il 9 agosto, il 17 luglio, 25 settembre, 17 novembre e così via. Il presidente del comitato incaricato di svolgere le indagini su Ahrensburg sarebbe stato il Barone di Godenstubbé, i cui figli riferirono la vicenda ad un diplomatico americano a Parigi nel 1859, basandosi a loro dire sui racconti del padre. Quest’ultimo, Mr. Dale Owen, che aveva la passione per lo spiritismo ed era anzi «della specie più credulona e superstiziosa»,[10] pubblicò la storia in America nel libro Footfalls on the Boundaries of Another World (1861). Il fatto che ne esista una versione ambientata in Estonia sembra confermare la natura leggendaria della storia: è ben nota agli studiosi del folklore, infatti, la tendenza delle tradizioni popolari a “riciclare” vecchie leggende, ricollocandole in luoghi e tempi più vicini come accadde ad esempio con le numerose versioni della storia del pifferaio di Hameln (tra le quali ve n’è una ambientata anch’essa in un’isola del Baltico, Ummanz). Lang cita appunto il caso del parallelismo Barbados–Ösel come esempio di quelle che chiama “storie bi–locate” (bi–located stories). Un’altra storia simile è riportata dall’European Magazine and London Review nel 1815[16] e riguarda questa volta una cripta a Staunton, nel Sussex (Inghilterra). Anche qui, si legge, «diverse bare furono ritrovate fuori posto, con grande stupore degli abitanti del villaggio». Anche in questo caso ci sono parecchie analogie con la cripta di Barbados: si parla infatti di «una bara tanto pesante da richiedere otto uomini per sollevarla», esattamente come quella del colonnello Chase, ritrovata anch’essa ad ostruire l’ingresso; anche qui infine fu considerata l’ipotesi dell’allagamento per spiegare il fenomeno.[17]
Se — come si dice — le leggende nascondono sempre un fondo di verità, quali fatti possono celarsi dietro il racconto, così ben collocato nel tempo e nello spazio, di una tomba tormentata? Difficile dirlo. Le storie della tradizione popolare, come quelle del folklore urbano, riflettono un’angoscia, un timore diffuso che caratterizza l’epoca o il particolare contesto in cui nascono e per questo può risultare estremamente difficile interpretarne le metafore a posteriori. Alcune poi nacquero per fini politici, come quella dei villagi Potëmkin, inventata da un diplomatico detrattore di Caterina II di Russia (l’ambasciatore Helbig) per screditarla. Ma secondo lo studioso Joe Nickell del Center for Skeptical Inquiry (2001), la leggenda di Barbados potrebbe avere origini massoniche. Le leggende massoniche non sono racconti di fatti reali, storici, ma servivano invece a tramandare una conoscenza e il significato va ricercato nelle allegorie: il soffitto a volta della cripta, le pietre, i muratori, gli scalpellini, il martello, i sigilli, l’acqua sono tutti elementi ricorrenti del simbolismo massonico; anche le date così ben precisate, o il ricorrente riferimento agli «otto uomini» necessari a spostare la bara/la lastra potrebbero avere qualche significato simbolico. Nickell rileva inoltre che almeno due dei nomi citati nelle varie versioni della storia erano membri della massoneria britannica,[18] che era presente sull’isola dal 1740 e controllata dalle Logge di Londra ed Edimburgo. Saremmo quindi di fronte ad un racconto allegorico con un significato preciso, entrato a far parte del folklore assumendo le caratteristiche di quella che oggi chiamaremmo “leggenda urbana” ma nel quale un membro della massoneria avrebbe certamente riconosciuto gli elementi simbolici e compreso il “messaggio” codificato. Va aggiunto poi che il XIX secolo in Inghilterra era l’epoca della letteratura gotica: cimiteri, cripte e tombe scoperchiate erano classici cliché delle ghost stories e questa dei Chase aveva quindi tutte le carte in regola per essere un successo.
Nel XIV secolo il filosofo e frate francescano inglese Guglielmo da Ockham espresse un principio che è ritenuto alla base del pensiero scientifico moderno: tale principio, noto come Novacula Occami o “rasoio di Ockham” afferma che «a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire». Forse non sapremo mai con assoluta certezza cosa accadde dentro quella cripta seminterrata ad Oistin, ma la spiegazione più semplice, e quindi più probabile, è che non sia accaduto proprio nulla. ∎
Opera tutelata dal plagio su patamu.com con numero deposito 93154.
Note
- [1]Un anno: secondo la tradizione inglese era il tempo concesso ai vivi per il pianto e il dolore per la perdita di una persona cara. Entro il giorno successivo al dodicesimo mese, il lutto doveva essere superato e la vita riprendere regolarmente, altrimenti il fantasma del defunto sarebbe stato strappato dalla tomba e costretto a vagare per la terra dei vivi (Cfr. Terre Celtiche )↩
- [2]Scotti, Massimo Storia degli spettri. Fantasmi, medium e case infestate fra scienza e letteratura Milano: Feltrinelli, 2013. 978-8807881992↩
- [3]James Stuart (1566 – 1625), contemporaneamente sovrano di Scozia con il nome di Giacomo VI di Scozia.↩
- [4]Rediker, Marcus, e Peter Linebaugh I ribelli dell’Atlantico: La storia perduta di un’Utopia libertaria. Milano: Feltrinelli, 2018. Pag. 159. ISBN 978-8807890574↩
- [5]Christ Church, nella parte meridionale dell’isola, fu una delle prime civil parishes fondate dai coloni a Barbados. La parrocchia civile era, ed è tuttora, una istituzione tipicamente inglese e legata alla presenza della chiesa anglicana sull’isola. Dopo lo scisma anglicano (XVI secolo) il governo del territorio nelle aree rurali fu lasciato infatti alle parrocchie anglicane che avevano il diritto di riscuotere una tassa sui prodotti, la cosiddetta “decima”.↩
- [6]Woolley, Mary Memoirs and correspondence of field–marshal viscount Combermere (op. cit.)↩
- [7]Clayton, Ian R. “The Bussa Rebellion“, Worldsagas.com.↩
- [8]Dunning, Brian, (op. cit.)↩
- [9]Fanthorpe, Lionel and Patricia. The World’s greatest Unsolved Mysteries. Dundurn, 1997. Pagg. 64–75.↩
- [10]Lang, Andrew (op. cit.)↩
- [11]introdotto dal medico britannico Edward Jenner nel 1796.↩
- [12]Inventata nel 1804 da Trevithick↩
- [13]West Indian Tales of old, 1915 (op. cit.)↩
- [14]Come ebbe modo di verificare Mr. Alleyne nel 1907. Cfr. Lang (op. cit.)↩
- [15]Alexander, pag. 161 (op. cit.)↩
- [16]“The Curious Vault at Staunton, Suffolk” in European Magazine and London Review, luglio–dicembre 1815, vol. 68. Pag. 226 Hati Trust.↩
- [17]Il caso di Staunton è citato anche da Aspinall nel West Indian Tales of Old del 1915 (op. cit.)↩
- [18]Nickell, Joe Real–Life X-Files: Investigating the Paranormal. University Press of Kentucky, 2001.↩
Bibliografia
Alexander, sir James Edward Transatlantic sketches Londra: ed. R. Bentley, 1833. Pagg. 161–162 . Archive.org
Schomburgk, Robert Hermann The History of Barbados. Londra, 1848. Pag. 220–221 . Archive.org
Woolley, Mary Memoirs and correspondence of field–marshal viscount Combermere, from his family papers Londra: Hurst & Blackett, 1866. Vol. 1. Pagg. 385–393 . Google Books.
Lang, Andrew “Deaths Deeds, a bi–located story.” in Folk-Lore: A Quarterly Review on Myth, Tradition, Institution & Custom, Vol XVIII, 1907. Pagg. 376–390 . Archive.org
Aspinall, sir Algernon Edward West Indian Tales of old. Cap. X: “A Barbados Mystery”. Londra: Duckworth & Co. 1915. Pag. 224–233 . Archive.org
“History of Barbados” in Barbados.org. Web.
- Polidoro, Massimo “La tomba che si muove” in Enigmi e misteri della storia — La verità svelata. Milano: Piemme, 2013. ISBN 978-8856627794
Dunning, Brian “The Moving Coffins of Barbados” in Skeptoid, 28 gennaio 2014. Web.
John Milton, Lost Paradise (1674)[1]
Il parco del Retiro si estende per oltre un chilometro quadrato sull’area che fu quella del Palacio del Buen Retiro, un complesso di edifici e giardini voluto dal Re Felipe IV come residenza estiva e luogo di svago della corte spagnola, realizzato tra il 1630 ed il 1640 alle porte di Madrid. Della favolosa reggia, in gran parte distrutta durante le guerre napoleoniche (1808–1814), rimangono solo due edifici: il Casón del Retiro, ex–sala da ballo, e il Salón de Reinos, un tempo ala del palazzo. I giardini, con il lago artificiale ancor oggi solcato da barche a remi, furono aperti al pubblico nel 1767 e divennero proprietà municipale dopo la rivoluzione “settembrina” del 1868 che portò alla detronizzazione di Isabella II.
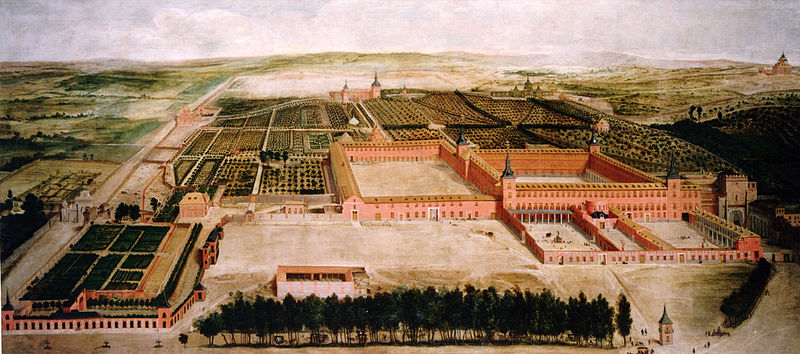
2 – Il “Palacio del Buen Retiro” in un dipinto dl 1637.
È l’unico monumento pubblico in Europa raffigurante Lucifero e si trova a 666 metri sul livello del mare.
Via via arricchito di fontane ed edifici (tra cui il Palacio de Cristal di ispirazione vittoriana), animato da spettacoli e artisti di strada, oggi il Retiro è uno dei parchi più grandi e belli della capitale. Tra le numerose sculture che adornano i suoi viali, una in particolare attira l’attenzione di turisti e appassionati di storie occulte: quella dell’Ángel Caído, l’angelo caduto, l’unica statua pubblica in Europa raffigurante Lucifero,[2][3] posta in cima a una fontana ornata da maschere dall’aspetto demoniaco. Inoltre, la statua si troverebbe esattamente alla quota di 666 metri sul livello medio del mare ad Alicante (che in Spagna costituisce lo “zero” altimetrico ufficiale), proprio il “numero della bestia” secondo l’Apocalisse di San Giovanni, cosa in cui alcuni vorrebbero vedere un ulteriore tributo a Satana. Perché dunque fu scelto quel luogo, e di chi fu la volontà di erigere un monumento ad una figura tradizionalmente associata al male?

3 – Veduta aerea del Parque del Retiro, al centro il lago con il monumento ad Alfonso XII di Spagna.
Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della Bestia: infatti è numero d’uomo, e il suo numero è seicentosessantasei.Apocalisse 13,16-18
In realtà la statua dell’Angelo Caduto fu realizzata dallo scultore madrileno Ricardo Bellver, ispiratosi al celebre Paradise Lost dell’inglese John Milton, poema epico pubblicato a Londra nel 1674. Il libro primo infatti narra della caduta di Lucifero che, insorto contro Dio, viene cacciato all’inferno con le sue legioni[4] per diventare Satana (attenendosi alla tradizionale intepretazione giudaico–cristiana dell’Antico Testamento, secondo la quale Satana sarebbe Lucifero dopo la ribellione e l’esilio[5]). Milton presenta il Principe dei Demoni come un eroe romantico, tormentato da passioni umane:
Said then the lost Archangel, “this the seat
That we must change for Heaven?—this mournful gloom
For that celestial light? Be it so, since he245
Who now is sovereign can dispose and bid
What shall be right: farthest from him is best
Whom reason hath equalled, force hath made supreme
Above his equals. Farewell, happy fields,
Where joy for ever dwells! Hail, horrors! hail,250
Infernal world! and thou, profoundest Hell,
Receive thy new possessor—one who brings
A mind not to be changed by place or time.
disse quindi, l’arcangelo caduto, «questa la sede
che in cambio del Ciel ci è destinata? Questa tetra
oscurità in cambio della celeste luce? Sia pur così,245
poiché Colui, ch’ora è sovrano, giudica e dispone
ciò che sarà giusto: quanto più lontano tanto meglio,
lungi da Chi la ragione ha reso uguale a noi, e
la forza, tra i suoi pari, lo ha fatto sommo. Addio,
campi felici, ove la gioia in eterno alberga! E, salve250
orrori! salve mondo infernale! E tu, infinito Abisso,
il nuovo tuo signore accogli, uno cui la mente
non potrà mutare a seconda del luogo o dell’età.
John Milton, Lost Paradise (1674), traduzione di F. Giacomantonio[6]
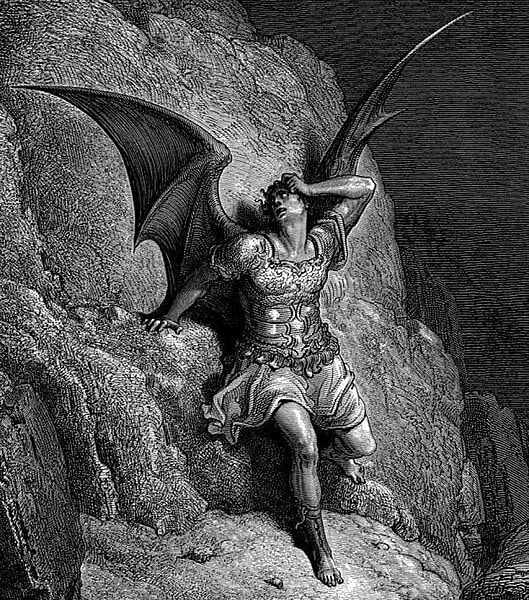
4 – Satana/Lucifero in una incisione di Gustave Doré per il Paradise Lost di Milton.
Di estrazione religiosa e puritana, Milton non intendeva certo esaltare Satana quanto invece — come scrive nello stesso poema — «svelare all’uomo la Provvidenza eterna» (Libro I, verso 26). Il suo Lucifero è infatti una figura esclusivamente poetica: contraddittoria ed affascinante quanto si voglia, ma pur sempre condannatosi alla dannazione eterna senza possibilità di riscatto. Esiliato per il suo desiderio di affermare la propria individualità, è il prototipo dell’eroe byroniano,[7] orgoglioso ed “imperfetto”, che avrebbe pervaso la letteratura ottocentesca ispirando figure quali il vampiro (il Lord Ruthven di John Polidori), il dottor Frankenstein di Mary Shelly,[8] i pirati letterari come il corsaro Conrad dello stesso Lord Byron, il Long John Silver di Stevenson e il Capitan Uncino di Barrie,[9] Victor Hugo, Baudelaire e i decadenti,[10] fino al “brigante” del romanticismo popolare.[8]
Il poeta e pittore William Blake (1757 – 1827), autore delle illustrazioni per alcune edizioni ottocentesche del Paradise Lost, scrisse che Milton stesso «era un vero poeta, e stava dalla parte del diavolo senza saperlo».[11] Ma forse, per Milton, la sconfitta di Lucifero aveva anche un significato politico: era una allegoria del crollo del Commonwealth d’Inghilterra, la Repubblica puritana di Oliver Cromwell (di cui il poeta fu sostenitore) e della conseguente restaurazione monarchica.

5 – Ricardo Bellver y Ramón.
Anch’egli evidentemente colpito da questa figura così epica e allo stesso tempo tragica, il giovane scultore Ricardo Bellver y Ramon (1845 — 1924) realizzò la scultura in gesso nel 1877 mentre si trovava a Roma per una borsa di studio della Academia de España, come “lavoro regolamentare” a conclusione del triennio. Ispirandosi probabilmente ad un altro Lucifero, quello dell’italiano Costantino Corti mostrato all’Esposizione Universale di Parigi del 1867,[12] Bellver raffigurò l’Angelo Caduto di Milton come un adolescente bello ed atletico, ma nella cui «espressione ammirabile — scrisse entusiasta il giornalista Eusebio Martínez de Velasco ne La Ilustración Española y Americana — nel suo volto, nel suo atteggiamento, nelle sue membra contratte, si rivelano chiaramente la disperazione, il risentimento, l’odio satanico dell’angelo ribelle, che pretendendo si essere uguale a Dio, fu vinto e precipitato negli abissi del male».[13]

6 – Bozzetto per l’Ángel Caído, incisione del 1877 di Ricardo Bellver.
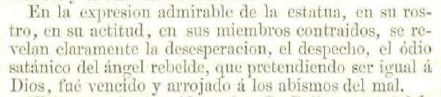
L’opera venne infatti inviata a Madrid (per questo ne scrisse Martínez de Velasco) per partecipare alla Exposición Nacional de Bellas Artes del 1878, sul cui catalogo viene riportata al numero 406 con la seguente descrizione:
…por su orgullo cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás. Agita en derredor sus miradas, y blasfemo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado.[12][14][13]
nella quale si riconoscono alcuni versi del Libro I del Lost Paradise Milton:[15]
Had cast him out from Heaven, with all his host
Of rebel Angels […]
superbia, fu bandito dal Ciel con tutta la legione
di spiriti ribelli […][16]
(36–38)
Torments him: round he throws his baleful eyes,
That witnessed huge affliction and dismay,
Mixed with obdurate pride and steadfast hate
or lo tormenta: volge lo sguardo torvo attorno,
a testimoniare afflizione immensa e turbamento,
frammisti ad implacabile odio ed ostinato orgoglio.[16]
(55-58)
L’opera di Bellver suscitò emozioni contrastanti nei critici d’arte connazionali: qualcuno ne sottolineò i difetti, come il braccio destro «troppo corto» (tale Rouget), mentre altri ne riconobbero una certa potenza come Jacinto Octavio Picón (1852 — 1923) che la descrisse come «una composizione audace, di disegno non corretto, ma vigoroso, energico, di aspetto molto decorativo». Nemmeno il parere della giuria fu unanime: Eugenio Duque, a parte difetti anatomici e inappropriate reminiscenze barocche, la trovò «del tutto sprovvista di buon gusto […] e priva di alcuna relazione poetica con la fantastica creazione [di Milton]».[12] Nonostante i pareri discordanti, per la sua drammaticità ed originalità, l’Angelo Caduto di Bellver vinse il primo premio della Exposición Nacional de Bellas Artes e fu selezionato per la Expositions Universelle di Parigi del 1878. Da quel momento i detrattori sembrarono svanire e l’opera divenne quasi unanimemente ammirata.
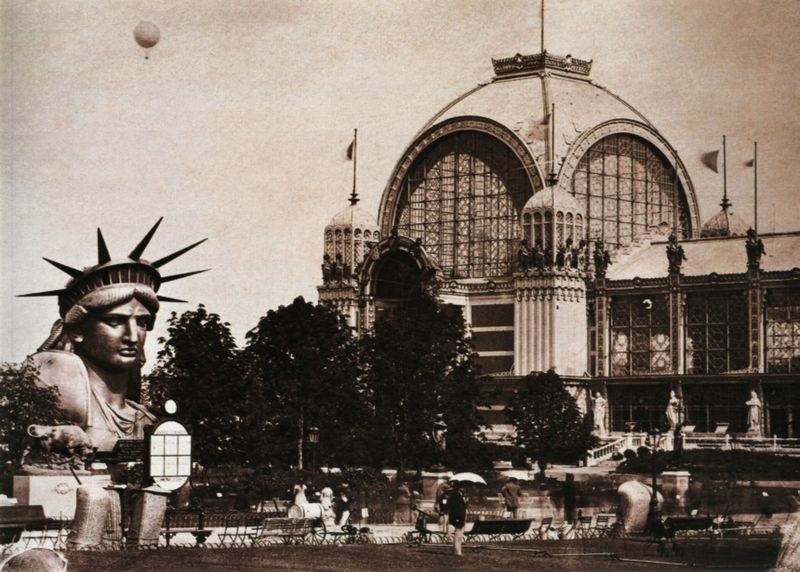
8 – Parigi, “Exposition Universelle” del 1878: si vedono la facciata del Palais du Champ-de-Mars e la testa della Statua della Libertà.
La critica francese si dimostrò entusiasta: la scultura di Bellver venne descritta come «travolgente»;[17] per Henry Juin, archivista della “Commissione Generale dell’Inventario delle ricchezze d’arte della Francia”, era come se «l’artista avesse visto Lucifero nella sua caduta improvvisa.» Léonce Dubosc de Pesquidoux (1829 — 1900) non esitò ad affermare che «avrebbe fatto onore a qualunque artista»:
Saggiamente posizionato e modellato, la figura ha una espressione inedita […]. Si indovina il dolore del suo rancore nel modo violento con cui solleva il petto, torce le dita e getta un’incomprensibile imprecazione a Dio.[12]

9 – L’Ángel Caído al Retiro, Madrid.
La scultura di Bellver ricevette le attenzioni anche della critica italiana. Tullo Massarani, (1826 – 1905), ex senatore del Regno d’Italia[18] e futuro fondatore della SIAE,[19] partecipava all’esposizione universale parigina come presidente del “I Gruppo” e della Giuria Mondiale delle Belle Arti. Ne L’arte a Parigi (1879), saggio sull’Exposition Universelle, scrisse che «il Lucifero del Bellver innegabilmente si toglie fuori dal dotto volgo delle cose mediocri». Sottolineò inoltre una sulfurea fisicità, propria della statua e assente nel Paradiso Perduto:
…quella sua fragorosa caduta, quel grido di minaccia e di terrore che gli spalanca la bocca, quel triplice serpe che lo avvinghia, e fin le roccie vulcaniche
su cui precipita, dànno al poema una interpretazione che sente più assai lo zolfo della Santa Hermandad, che non le sublimi astrazioni di Milton.
La “Santa Hermandad” (Santa Fratellanza) evocata da Massarani fu un corpo di polizia spagnolo istituito da Isabella I di Castiglia nel 1476 e sciolto solo nel 1836, che godeva di una pessima reputazione a causa dei metodi repressivi, della corruzione e negligenza dei suoi membri. Era strumento della Corona e dell’inquisizione spagnola (fu guidata nientemeno che da Tomás de Torquemada):[20] una organizzazione “diabolica” quindi, secondo Massarani, che sembra aver ispirato lo scultore più di quanto non l’abbiano fatto le «sublimi astrazioni» di Milton. A parte l’insolito paragone, sottolineare tale distanza significava anche riconoscere all’Angelo Caduto di Bellver dignità di opera a sè stante, non più solo “illustrazione” scultorea di un celebre poema.

10 – Fuente del Ángel Caído, dettaglio delle maschere.
L’autore intendeva riportare la statua a Roma per realizzarne una fusione in bronzo, ma già dopo il primo premio all’esposizione di Madrid lo stato spagnolo si era interessato per acquistare il modello in gesso. L’opera fu ceduta per 4 500 pesetas il 4 gennaio del 1879, mentre si trovava ancora a Parigi; tornò quindi in Spagna come proprietà pubblica e lo stato spese ulteriori 10 000 pesetas per la fusione in bronzo, operazione che comportò la distruzione del modello in gesso. Il 31 ottobre dello stesso anno il bronzo fu ceduto in deposito alla Municipalità di Madrid ed affidata al “Museo Nacional de Pintura y Escultura”, l’attuale Museo del Prado che si trova sull’omonimo paseo (viale) in prossimità del parco del Retiro. Fu proprio l’allora direttore del museo, Benito Soriano Murillo (1827 — 1891), a proporre alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione l’esposizione della statua in un luogo pubblico:

11 – La Fuente del Ángel Caído nel parco del Retiro, al centro di una glorieta all’incrocio tra Paseo Fernán Nuñez e Paseo de Cuba.
La petizione fu accolta e si scelse uno spazio libero nel parco del Retiro, nell’area dove tra il 1759 ed il 1808 operò la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro (popolarmente detta “La China”), voluta da Carlo III sul modello della manifattura di Capodimonte e distrutta anch’essa nel 1812 durante la guerra di indipendenza. Nel 1880 fu affidato all’architetto Francisco Jareño (1818 — 1892), responsabile delle opere del Museo del Prado per il ministero dei lavori pubblici, di progettare un piedistallo per l’esposizione della statua. Fu realizzata una fontana ottagonale del diametro di circa 10 metri, con un pilone centrale ornato da mostruose maschere di bronzo da cui sgorgano getti d’acqua, per un’altezza complessiva (inclusa la statua) di circa 7 metri. Il complesso, posto al centro di una glorieta (una aiola circolare), allineata sull’asse principale del parco con le preesistenti fontane “del carciofo” (1766) e “delle testuggini” (1832), divenne così la Fuente del Ángel Caido che fu inaugurata ufficialmente nel 1885.[22] Ne esiste una replica realizzata in resina di poliestere, esposta alla Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, in calle Alcalá: ad oggi, quindi, le statue di Lucifero a Madrid sono di fatto due.
In conclusione, l’Angelo Caduto di Bellver rappresenta Lucifero? Sì, senza alcun dubbio, ma questo non vuol dire che ne sia apologetico: è invece un monumento alla sconfitta della superbia, al poema di Milton, all’arte scultorea, ma non certo al “male”. E la presunta quota di 666 metri? Non è poi così sorprendente, visto che il vicino Observatorio del Retiro si trova a 667 metri sul livello del mare[23] e l’altitudine media dell’intera città di Madrid è di 657 metri.[24] ∎
Opera tutelata dal plagio su patamu.com con numero deposito 72155.
Note
- [1]Libro I, versi 36–38 — traduzione dall’inglese di Lazzaro Papi (1811)↩
- [2]Ring, Trudy e Noelle Watson Southern Europe: International Dictionary of Historic Places. Routledge, 2013 (1ª ed. 1996). Pag. 400.↩
- [3]Ve n’è un’altra, molto nota, in piazza Statuto a Torino, che la tradizione vorrebbe raffigurante Lucifero: in realtà si tratta del monumento al Traforo del Frejus. Anche a Santa Cruz de Tenerife c’è una statua detta dell’Angel Caído, ma è invece un monumento al Generale Franco realizzata nel 1966 dallo scultore Juan De Ávalos per celebrare la vittoria franchista nella guerra civile spagnola. La statua fu reintitolata per effetto della “Legge per la Memoria Storica” del 2007, che imponeva la rimozione di qualsiasi elemento pubblico volto a celebrare la passata dittatura.↩
- [4]Nel Paradise Lost, gli angeli ribelli stabiliscono una propria “capitale” o meglio un palazzo dove si riuniscono in Concilio in una sorta di democrazia infernale. Milton chiama questo edificio Pandæmonium, dal geco pan– (tutto, ogni) e daimónion (demonio), da cui l’espressione pandemonio per dire una gran confusione, o una discussione molto accesa.↩
- [5]Questa identificazione Satana/Lucifero non è universalmente accettata.↩
- [6]Libro I, versi 242–253 — traduz. da F. Giacomantonio pag. 70 (op. cit.)↩
- [7]Tipico delle opere di Lord Byron (1788 — 1824). Cfr. Giacomantonio, in Paradiso Perduto pag. 85 (op. cit.)↩
- [8]Cfr. F. Giacomantonio, in Paradiso Perduto pag. 85 (op. cit.)↩
- [9]Spencer, Alexander Romantic narratives in international politics: Pirates, rebels and mercenaries Manchester University Press, 2016. Pag. 54. ISBN: 978-0-7190-9529-0↩
- [10]Cfr. F. Giacomantonio, in Paradiso Perduto pag. 15 (op. cit.)↩
- [11]Blake, William The Voice of the Devil, 1973.↩
- [12]Reyero, C. Enciclopedia del Museo del Prado (op. cit.).↩
- [13]La Illustración Española y Americana, 30 marzo 1878 (op. cit.)↩
- [14] vol. 2, pag. 381.↩
- [15]Spesso citata erroneamente come un”frammento” del poema di Milton, sembra in realtà una “sintesi” di versi non consecutivi tra loro.↩
- [16]Traduzione di Flavio Giacomantonio in Paradiso Perduto pag. 65 (op. cit.)↩
- [17]Da Clovis Lamarre e Lucien Louis–Lande. Cfr. Reyero, Enciclopedia del Museo del Prado (op. cit.)↩
- [18]Nella XII Legislatura, 1874 — 1876↩
- [19]Fondata nel 1882 come Società Italiana degli Autori (SIA).↩
- [20]Davies, Norman Storia d’Europa Milano: Mondadori, 2006. Pag. 502. ISBN 978–8842499640↩
- [21]Archivo General de la Administración, Caja 6821. Cit. in Reyero, Carlos Escultura, museo y estado en la España del siglo XIX: historia, significado y catálogo de la colección nacional de escultura moderna, 1856-1906. Alicante: Fundación Eduardo Capa, 2002. ISBN 84-931949-6-4.↩
- [22]L’ingresso sud–ovest del parco, dalla calle de Alfonso XII, da dove inizia il paseo Fernán Nuñez che arriva appunto alla fontana, prese invece il nome di “Puerta del Ángel Caido”.↩
- [23]Agencia Estatal de Metereologia.↩
- [24]Agencia Estatal de Metereología.↩
Bibliografia e fonti
- Nash, Elizabeth Madrid Milano: Mondadori, 2004 (1ª edizione 2001). Pag. 48–49. ISBN 978–8–8615–9168–4
- Meridiani, marzo 2004. Anno 17, nº 126. Pagg. 19, 178–179.
Milton, John, Paradise Lost, Londra 1674.
- Milton, John (traduzione e note di Flavio Giacomantonio) Paradiso Perduto. Roma: Newton Compton, 2016.
Martínez, Eusebio “Nuestros grabados” in La Ilustración Española y Americana, Madrid, Anno XXII, Nº XII, 30 marzo 1878. Pag 203–204.
- Reyero, C. Enciclopedia del Museo del Prado, 2006, Tomo II, pp. 381-383.
- Massarani, Tullo. L’arte a Parigi. Roma: Tipografia del Senato, 1879. Pag. 165–166.
Nash, Elizabeth “Madrid enjoys the devil of a row over a fallen angel” in Independent, 26 maggio 1998. Web.
- Ramirez Muro, Veronica Madrid insolita e segreta, Venezia: Edizioni Jonglez, 2011. Pag. 35–37. ISBN 978–2–9158–0773–8
Immagini
- © Alberto Gardin/Fotolia #94111486
- 1637, Jusepe Leonardo (1601–1652), olio su tela. Commons
- Ayuntamiento de Madrid [CC BY-SA 2.0] Commons
- Gustave Doré, 1866 [PD] Commons.
- da La Ilustración Artística.,30 marzo 1891. Commons
- da La Ilustración Española y Americana, pag. 204 (op.cit.)
- ibidem, pag. 203.
- 1878. Commons
- © Alfonso De Tomas/Fotolia #50744377
- 3/2/2017 © Silvio Dell’Acqua
- 2012, © Pixachi/Fotolia #76151340
- © jonba/Fotolia #81655587
Tornerà il bianco per un attimo a brillare dalla calce, regina arsa e concreta di questi umili luoghi dove termini, meschinamente, Italia, in poca rissa d’acque ai piedi di un faro. È qui che i salentini dopo morti fanno ritorno col cappello in testa. Vittorio Bodini, poeta barese (1914 – 1970)
Il capo di Leuca deve il nome all’antico toponimo greco (lingua tuttora parlata nel Salento[1]) τα Λευκά (ta Leucá, le Bianche) con cui, secondo lo storico e geografo greco Strabone (60 a.C. — c.a 21–24 d.C.), veniva anticamente chiamato questo luogo in riferimento alle bianche rocce delle sue scogliere. Ai tempi della Serenissima il Mare Adriatico era noto come Golfo di Venezia,[2] a sottolineare non solo la supremazia della Repubblica sulle sue acque ma anche la separazione geografica di questo lembo chiuso di Mediterraneo, un braccio di mare esteso dalla Laguna Veneta al canale d’Otranto che ne costituisce l’imbocco.
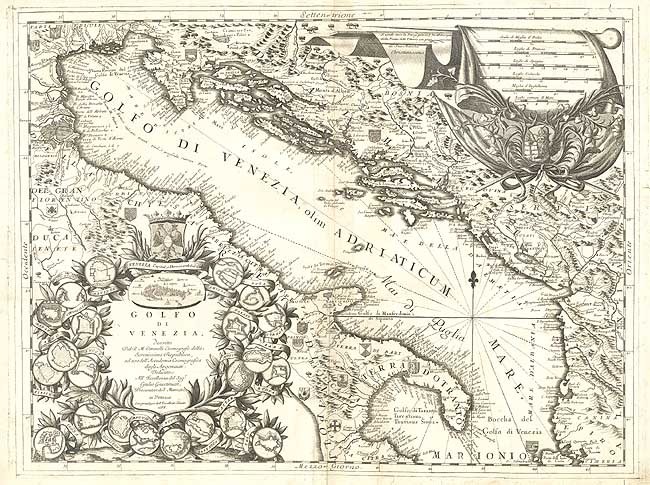
2 – L’Adriatico indicato come “Golfo di Venezia” su una mappa del 1688.
Bastioni naturali di questo ingresso sono, a oriente, l’isola greca di Corfù e a occidente il Capo di Leuca, estremo meridionale della costa adriatica: da qui passa il confine tra lo Ionio e l’Adriatico e non solo per convenzione nautica ma anche perché da qui, in talune condizioni, l’incontro delle correnti crea una differenza cromatica tra le acque che rende tangibile tale linea, suggerendo da sempre alla fantasia popolare l’esistenza di un confine “fisico” fra i due mari. Tutto questo avviene in corrispondenza di un promontorio, l’estremità di una terra, il Salento, che già di per sé è una lingua stretta e lunga che accompagna verso l’ignoto, il mare aperto, le lontane terre d’Oriente: naturale quindi che il Capo di Leuca fosse considerato De Finibus Terrae, “ai confini della terra” come lo chiamavano i Romani per indicare che qui si trovava l’estremo limite dei cives, i cittadini, frontiera al di là della quale cominciavano i provinciales, gli abitanti delle colonie.

3 – Il Capo di Leuca, frontiera della provincia romana, visto dalla Punta della Ristola
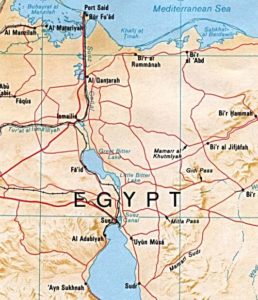
4 – Il canale di Suez.
Era il 1848 quando l’ingegnere Carlo Afan De Rivera, ufficiale dell’esercito e direttore generale del “Corpo di Ponti e Strade”[3] del Regno delle Due Sicilie, nel trattato Dei Mezzi[4] prefigurava che, con l’apertura di un canale attraverso l’istmo di Suez, la navigazione a vapore nel mediterraneo avrebbe restituito «l’importanza di posizione delle Due Sicilie, che sono situate nel mezzo della conca di quel mare».[4] Di un canale a Suez parlavano già i mercanti veneziani all’inizio del 1500 ma fu Napoleone Bonaparte nel 1799, durante la Campagna d’Egitto, a riportarne in auge l’idea e i lavori si sarebbero ultimati solo nel 1869 ad opera della “Compagnie universelle du canal maritime de Suez”.[5] In vista di future rotte commerciali verso le Indie era evidente che la Puglia si trovava in una posizione chiave perché la vocazione storica di “Porta d’Oriente” evolvesse in un ruolo concreto. Dieci anni prima dell’inaugurazione del Canale e due anni prima dell’Unità d’Italia il Regno delle due Sicilie, che già dagli inizi dell’Ottocento aveva avviato progetti di potenziamento delle infrastrutture portuali, finanziò la costruzione di 42 nuovi fari sulle proprie coste, molti dei quali appunto in Puglia: Punta Palascia a Otranto, Isola di Sant’Andrea a Gallipoli, Isola di San Paolo e Capo San Vito a Taranto, Punta Riso a Brindisi, Punta San Cataldo a Lecce e, ovviamente, un faro a Capo di Leuca, all’imbocco dell’Adriatico.
Fari pugliesi finanziati nel 1859 dal Regno delle due Sicilie.
Non furono però solo le esigenze della navigazione e del commercio a richiedere un faro per illuminare il capo di Leuca: la sua funzione fu anche fortemente simbolica e celebrativa della sacralità e della unicità di un luogo, del finis terrae[6] dove, secondo una tradizione medievale, i fedeli si recavano in pellegrinaggio alla ricerca di un lasciapassare per il paradiso:[7] dove trovarlo, se non dove la terra finisce ed incontra il cielo? Qui infatti si trova il santuario di “Santa Maria de Finibus Terrae”, il cui edificio attuale è stato ultimato nel 1755 ma le cui origini risalgono ai tempi del primo cristianesimo (secondo la tradizione a Leuca sarebbe sbarcato l’apostolo Pietro, iniziando la sua opera di evangelizzazione della penisola) e anche prima, quando in questo luogo sorgeva un tempio pagano attribuito a Minerva.

5 – Basilica santuario di Santa Maria de Finibus Terrae (nota anche come “S. Maria di Leuca”): l’attuale edificio settecentesco e il piazzale dall’aspetto metafisico. La “colonna mariana” del 1694 è sormontata da una statua della Madonna, opera di Filiberto Aierbo d’Aragona.
La prima proposta di un faro a Leuca fu sostenuta proprio dall’esplicito riferimento alla funzione di guida per i pellegrini diretti al Santuario di Santa Maria di Leuca: il 5 maggio 1841 il ministro degli affari interni del Regno delle Due Sicilie Nicola Santangelo (1754 — 1851) scrisse all’Intendente della Terra d’Otranto[8] per sottoporgli l’offerta del cavalier Virginio Bourbon, benefattore «sempre inteso al miglioramento del Santuario di Leuca», di assumersi i costi di costruzione di un faro sul promontorio «il quale servendo di guida ai divoti che colà occorrono, lo fosse pure all’altezza in che sarebbe posto ai naviganti di quei mari…». Si pronunciò anche il Ministero della Guerra e della Marina, che —come scrisse di nuovo il 3 luglio il ministro Santangelo all’intendente— trovava «vantaggioso su tutti i lati lo stabilimento di un Faro sul Promontorio di Leuca, presso il santuario di tal nome». Del progetto, di cui fu incaricato il direttore generale del Corpo di Ponti e Strade, si persero però le tracce. Dopo vent’anni di nulla di fatto, il 17 marzo 1861 venne proclamata l’unità d’Italia, culmine del risorgimento, e il faro di Leuca divenne affare del ministero dei lavori pubblici del neonato Regno d’Italia il quale finalmente, nel 1863, ne ordinò la costruzione a cura del Corpo Reale del Genio Civile.
Il faro monumentale di Leuca assumerà […] anche una forte valenza simbolica di “presidio”, di avamposto della nuova Italia unita in uno dei lembi più estremi del suo territorio.
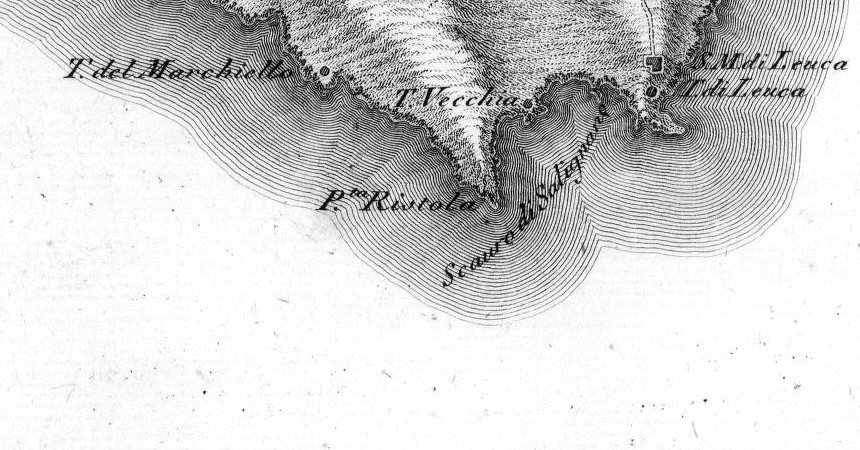
6 – La basilica di “S. M. di Leuca” (a destra) con la vicina “Torre di Leuca”, una torre costiera preesistente al faro fatta costruire da Carlo VI nel XVI secolo, citata come “cadente” nella relazione dell’ing. Rossi del 1863. Dettaglio da Atlante geografico del regno di Napoli, 1812.
Il progetto fu affidato all’ingegnere Achille Rossi[9] che scelse di collocare la costruzione «sulla spianata che è tra il Santuario di Leuca e la prossima cadente torre»,[10] (sopra) riferendosi ad una antica torre costiera fatta costruire da Carlo V a metà del XVI secolo: il faro monumentale di Leuca assumerà così, per il momento e per il luogo in cui fu costruito, anche una forte valenza simbolica di “presidio”, di avamposto della nuova Italia unita in uno dei lembi più estremi del suo territorio. I lavori iniziarono nel 1864 ad opera della ditta Perrone e nel 1867 il faro fu ultimato.

7 – Il faro di Capo Santa Maria di Leuca. Attualmente è gestito dalla Marina Militare Italiana.
Il faro
La torre ottagonale in tufo conchifero (detto “carparo”) si innalza per 45 metri dalla quota della spianata (55 metri s.l.m.) portando l’elevazione del fuoco a 102 metri sul livello del mare: un’altezza che lo avrebbe reso visibile ad una distanza stimata di 28 miglia geografiche,[11] «supposto l’osservatore a10 metri sul livello del mare».[12] Ai suoi piedi, il caseggiato a due piani dei fanalisti ospitava un forno, un magazzino per i ricambi, un deposito per l’olio combustibile, un ufficio per l’amministrazione e tre abitazioni di quattro camere. Dal vestibolo di ingresso si accede alla scala a chiocciola che, all’interno della torre, sale con i suoi 254 gradini fino alla lanterna metallica.

8 – La lanterna del faro di Santa Maria di Leuca. Le attuali lenti Fresnel furono installate nel 1954.
Il servizio del faro richiedeva tre fanalisti che vivevano presso la struttura. Se del clima non ci si poteva lamentare e le cisterne garantivano sufficiente acqua potabile, il personale viveva le difficoltà dell’isolamento pur essendo il faro “in terraferma”, ossia non si necessitava un barca per raggiungerlo. A parte case più o meno sparse (esistenti sin dalla fine Settecento[13]), il paese più vicino era Gagliano del Capo dove, nonostante i circa duemila abitanti (agli inizi del ‘900), si poteva comperare poco o nulla. Ancora nel 1904, in occasione del censimento dei fari pugliesi, l’ingegnere capo del Genio Civile di Lecce scriveva infatti che «per provvedersi dei generi di prima necessità i fanalisti devono recarsi quasi sempre ad Alessano, paese di maggiore importanza che dista 12 chilometri dal faro». Inoltre, «in Galiano del Capo vi sono le scuole elementari obbligatorie delle quali i figli dei fanalisti non possono neanche profittare, stante la distanza e la mancanza di mezzi di trasporto».
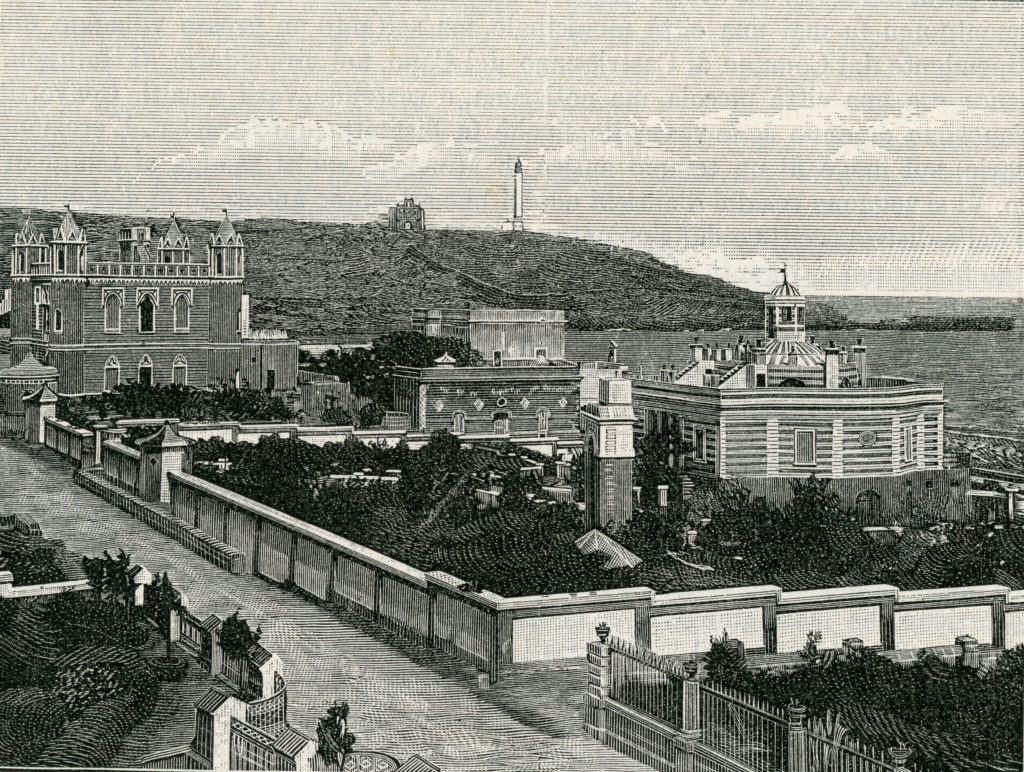
9 – I villini della Marina di Leuca in una incisione del 1899, sullo sfondo il Capo di Leuca con il faro.
La “marina” di Leuca
L’isolamento non era però destinato a durare a lungo. Già nel 1878 infatti, una decina di anni dopo l’ultimazione del faro, era stato firmato dallo stesso ingegnere Achille Rossi e dal collega Giuseppe Ruggieri il piano regolatore per un borgo di villeggiatura, dimora estiva della nobiltà e borghesia agraria e salentina, che sarebbe sorto proprio sulla cala sottostante: l’attuale Marina di Leuca[14] con il suo porticciolo e le sue «acconcie casinette» (come si legge in una delibera comunale del 1867).[15] Da sempre riparo naturale per i pescatori locali, la rada di Leuca è compresa tra la Punta Mèliso, che chiude convenzionalmente il Golfo di Taranto, e la Punta Ristola (foto 12). Se la prima, ai piedi del promontorio, è idealmente considerata l’estremità del Capo, geograficamente il punto più meridionale della Puglia è invece la meno nota Punta Ristola, circa un miglio più a est.[16] In questo luogo dove ogni lembo di terra e di mare sembra voler essere il limite estremo di qualcosa, termina anche il percorso del canale principale dell’acquedotto pugliese che, dopo aver irrorato la “siticulosa Puglia” —come scrisse Orazio nelle Epodi[17]— e alimentato l’ultima fontana nei pressi della Basilica, si getta in mare con la imponente cascata monumentale terminata nel 1939. Come a voler rimarcare, ancora una volta, lo status di Finis Terrae del Capo di Santa Maria di Leuca. ∎
- 10 – L’ultima fontana dell’acquedotto pugliese, nei pressi della basilica.
- 11 – La cascata monumentale dell’acquedotto pugliese.

12 – Marina di Leuca e il porto, visti dal promontorio: in fondo la Punta Ristola, che è il vero estremo meridionale della penisola salentina.
Note
- [1]Romano, Antonio “In Salento e Calabria le voci della minoranza linguistica greca” in Lingua Italiana. Treccani. Web.↩
- [2]Oggi per Golfo di Venezia si intende l’insenatura situata nell’Alto Adriatico che va dalla Punta di Goro nel Delta del Po fino a Capo Promontore, in Istria.↩
- [3]Il genio civile del Regno di Napoli e successivamente delle Due Sicile.↩
- [4]Dei mezzi più efficaci da procacciar lavoro agli operai facendo valere i vantaggi naturali. Napoli: dalla Reale Tip. della Guerra, 1848↩
- [5]Costituita il 15 dicembre 1858 e diretta da Ferdinand de Lesseps, console, promotore della realizzazione dei canali di Suez e di Panama. Padre di dello spadaccino Ismaël de Lesseps e dell’aviatore Bertrand de Lesseps che nel 1912 avrebbe costruito la “Auto Aero”, una dele prime →automobili ad elica.↩
- [6]“confine della terra”, espressione latina da cui derivano anche i toponimi Finisterre (Spagna) e Finistère (Francia).↩
- [7]cfr. Simonetti, E. “Una luce tra il cielo e il mare” in Martinelli—Carlone (op. cit.) pag. 20.↩
- [8]La Terra d’Otranto era una provincia del Regno delle Due Sicilie, poi mantenuta sotto il Regno d’Italia e sopravvissuta sino agli anni ’20 del Novecento.↩
- [9]Progettista anche del faro di Capo d’Otranto.↩
- [10]Achille Rossi, “Progetto del Faro al Capo S. Maria di Leuca.” (1863). Cit. in Martinelli—Carlone (op. cit.)↩
- [11]La portata geografica è la massima distanza dalla quale può essere avvistata una luce, esclusivamente in funzione della curvatura terrestre. Essa dipende quindi dall’elevazione dalla luce e dell’occhio dell’osservatore.↩
- [12]Achille Rossi, “Memoria relazione tecnica” per il progetto del faro al Capo S. Maria di Leuca, cit. in Martinelli–Carlone (op. cit.) pag. 89.↩
- [13]G. Carlone, in Il Faro di Leuca, pag. 27 (op. cit.)↩
- [14]Cfr. A. C. Morciano “Leuca: tre nomi, tre volti, una storia” in Leucaweb, 21 gennaio 2009. Web.↩
- [15]“Mozione alla terza classe del Posto Doganale del Porto di Leuca del Consiglio di Castrignano del Capo” Delibera del Comune di Castrignano del Capo, 5 dicembre 1867; cit. in Martinelli – Carlone (op. cit.) Pag. 27.↩
- [16]≈1,85 km.↩
- [17]«tantus… siderum insedit vapor / siticulosae Apuliae» (Epodi, 3, 16.) Cfr. Sirago, Prof. Vito. A. “La sete in Puglia da Orazio al 1914” (PDF) ↩
Bibliografia e fonti
- Martinelli, N. e G. Carlone (a cura di) Il faro di Leuca. 150 anni di luce e porta d’Oriente Bari: Mario Adda Editore, 2016. ISBN 978-8867172528
- AA.VV. Piano Comunale delle Coste. Comune di Castrignano del Capo (LE), adottato con atto Numero 37 del 20-11-2014. Consulenza tecnico–scientifica del Politecnico di Bari. Pagg. Pagg. 1–15. Web
- D’Ardia, Lavinia “La mappa delle sentinelle sul blu: fari pugliesi tra storia e leggenda” in Repubblica, 23 luglio 2003.
- Mola, Stefania “496. Castrignano del Capo. Il santuario di Santa Maria di Leuca” in Il giro delle Puglia in 501 luoghi. Roma: Newton Compton, 2015. ISBN 978-8854182301
- Rowlett, Russ “Lighthouses of Italy: Southern Puglia” in The Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill. 16–06–2006. Web.
Immagini
- © isaac74/Fotolia #87621257
- Vincenzo Maria Coronelli, 1688. Da <raremaps.com>
- Mboesch, 2009 [CC BY-SA 4.0] Commons
- Central Intelligence Agency, 1992 [PD] Commons
- >© Buesi/Fotolia #21140141
- 1812, (dettaglio) da Atlante geografico del regno di Napoli di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni [CC BY–NC–SA 3.0] fair use da David Rumsey Maps Collection
- © raffaelelagalla/Fotolia #77455163
- © 2016 Silvio Dell’Acqua
- da Strafforello Gustavo, La patria, geografia dell’Italia / Parte 4 (continuazione). Province di Bari, Foggia, Lecce, Potenza. Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1899. Commons
- La Cara Salma, 5-11-2011 [CC-BY-SA 3.0] Commons
- © filippoph/Fotolia #135402110
- © 2016 Silvio Dell’Acqua
Opera tutelata dal plagio su Patamu con numero deposito 64715.