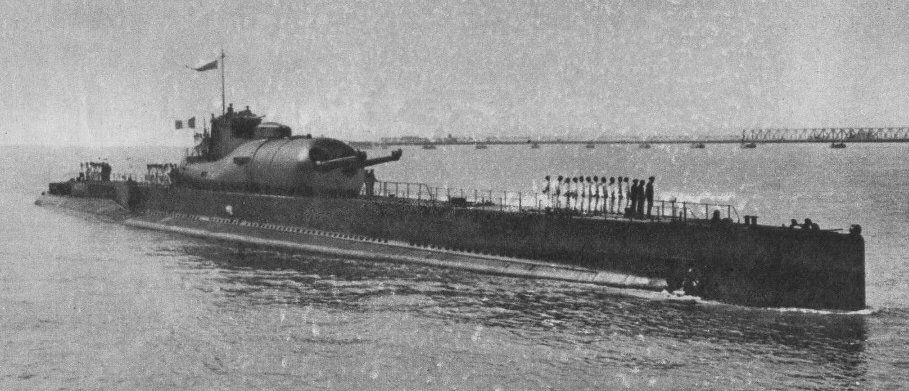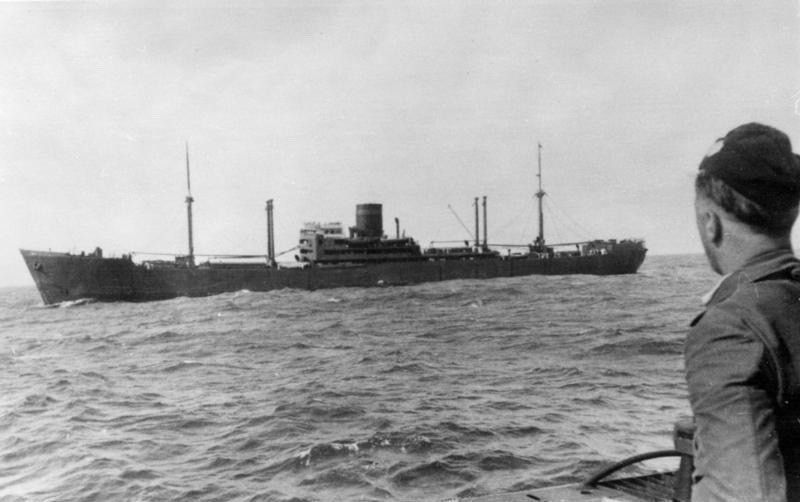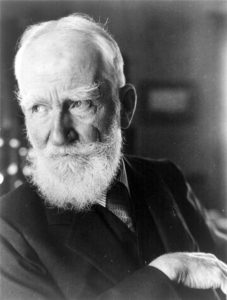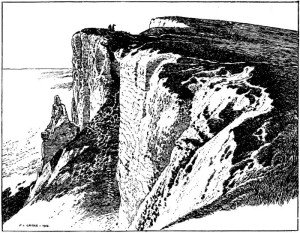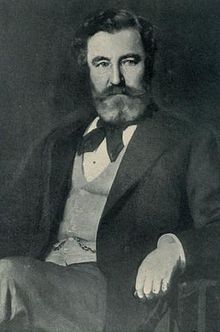Winston Churchill e Charles de Gaulle.
Non deve stupire che, in risposta all’invito del Primo ministro britannico Winston Churchill di unire le flotte della Francia Libera e dell’Inghilterra nella lotta comune contro la Germania nazista, Charles de Gaulle abbia risposto: «Il più grande piacere della marina della Francia Libera sarebbe quello di bombardare i britannici»[ref]Cfr. P. Lugaro, De Gaulle, in I Protagonisti, Famiglia Cristiana, 2002, pag. 72.[/ref]. Non deve stupire perché, il 3 luglio 1940, pochi giorni dopo la firma dell’armistizio franco–tedesco di Compiègne (22 giugno), una forza navale inglese (la “Forza H” di stanza a Gibilterra) si era presentata innanzi al porto nordafricano di Mers–el–Kebir, dove era ormeggiato il grosso della Marine Nationale francese, e aveva deliberatamente aperto il fuoco contro i moderni incrociatori da battaglia Dunkerque e Strasbourg, le corazzate Bretagne e Provence, la porta–idrovolanti Commandant Teste, il Mogador ed altri cinque cacciatorpediniere. Bilancio dell’incursione: quasi duemila morti, tra marinai imbarcati e a terra.
1 – Il cacciatorpedinere Mogador in fiamme dopo il bombardamento a Mers-el-Kebir il 3 luglio del 1940.
Ma non era finita qui. Lo stesso giorno dell’attacco a Mers–el–Kebir la marina britannica aveva sequestrato le navi francesi rifugiatesi nei porti d’oltremanica di Portsmouth e Plymouth (si trattava del Paris e del Courbet, vecchie dreadnought degli anni Dieci, ma anche di otto moderni cacciatorpediniere e di tre sommergibili, tra cui lo straordinario e sfortunato Surcouf);[ref name=”surcouf”] Il Surcouf (intitolato a Robert Surcouf, il corsaro francese che all’inizio dell’Ottocento combatté con maggior accanimento gli inglesi nei mari dell’India) era, all’epoca, il più grande e potente sommergibile del mondo: un vero e proprio incrociatore–sommergibile–portaerei di 110 metri di lunghezza, 9 di larghezza, 9 di pescaggio, 4250 tonnellate di dislocamento in immersione, 12 tubi lanciasiluri e ben 2 cannoni da 203/50 mm. Nelle sue linee, a giudicare dalle fotografie disponibili, il Surcouf sembrava uscito direttamente dalla fantasia di Jules Verne e tali erano le sue peculiarità che esso fu accuratamente esaminato non solo dall’Ammiragliato britannico, ma anche dai servizi segreti americani, nel corso della sua permanenza presso l’arsenale di Portsmouth (USA). Tornato in servizio nella marina della Francia Libera nel dicembre 1941, il Surcouf fu affondato da “fuoco amico” appena due mesi dopo, nel febbraio 1942, senza aver svolto alcun impiego operativo di rilievo contro le navi dell’Asse: giace inesplorato con i suoi 130 membri dell’equipaggio, a tremila metri di profondità a Nord del Canale di Panama (11° N 79° O).
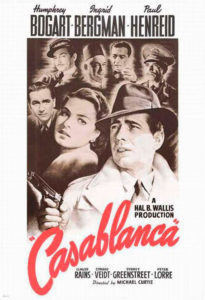
Locandina originale del film Casablanca, 1942.
Forse per un omaggio alla memoria, forse per un debito di riconoscenza, o forse per altri motivi, una fotografia del Surcouf fa capolino tra le carte dell’agente della Resistenza francese che viene ucciso nelle sequenze iniziali del celeberrimo film Casablanca: film che, sia detto per inciso, uscì nelle sale statunitensi il 26 novembre 1942, e cioè pochi giorni dopo lo sbarco alleato in quella città e l’inizio della “beautiful friendship” franco-americana, come sostiene beffardo il protagonista Rick (impersonato — c’è bisogno di ricordarlo? — da Humphrey Bogart) nell’ultima battuta del film medesimo.[/ref] il 5 luglio, aerosiluranti decollati dalla portaerei inglese Ark Royal avevano colpito nuovamente, per finirla, la Dunkerque (causando altri 200 morti); il 7 luglio, ad Alessandria d’Egitto, la corazzata Lorraine, quattro incrociatori e tre cacciatorpediniere erano stati ridotti all’impotenza; ancora il 7 luglio, forze navali inglesi avevano ripetuto il colpo di Mers–el–Kebir presentandosi innanzi al porto di Dakar e silurando la modernissima e possente nave da battaglia Richelieu, in fase di allestimento.[ref]La gemella della Richelieu, la Jean Bart, anch’essa in allestimento, era a Casablanca: sfuggita all’operazione “Catapult”, sparò alcuni colpi contro la forza d’invasione anglo–americana del Nord Africa (operazione Torch) e fu affondata da aerei statunitensi il 10 novembre 1942.[/ref]
Solo a questo punto lo Stato maggiore imperiale britannico poteva dirsi soddisfatto: con la riuscita di tutte le fasi dell’operazione “Catapult”, la parte migliore della flotta francese era stata messa in condizioni di non nuocere.
Mers–el–Kebir rappresenta per la Francia, nei rapporti con l’Inghilterra, ciò che la dichiarazione di guerra annunciata da Mussolini dal balcone di palazzo Venezia rappresenta nei rapporti con l’Italia: una “pugnalata alla schiena”.[ref]Più o meno in questi termini si era espresso l’ambasciatore francese a Roma, André François–Poncet, appena ricevuta la dichiarazione di guerra per mano del Ministro italiano degli affari esteri, Galeazzo Ciano. In realtà, pare che l’ambasciatore abbia esclamato «E così, avete aspettato di vederci in ginocchio, per accoltellarci alle spalle» (cfr. F. Perfetti, 1940: non ci fu la “pugnalata alla schiena” alla Francia, in Il Tempo del 10 giugno 2009), mentre nel suo Diario Ciano riporta la frase, più forbita, «È un colpo di pugnale ad un uomo in terra. Vi ringrazio comunque di usare un guanto di velluto» (cfr. G. Ciano, Diario 1937–1943, Castelvecchi, 2014, pag. 165 e ss.).[/ref] Con la differenza che, se Francia ed Italia si guardavano da tempo con diffidenza ed inimicizia, Francia ed Inghilterra erano state, fino all’armistizio di Compiègne, formali alleate.

3 – Mussolini al balcone di Palazzo Venezia annuncia la dichiarazione di guerra alla Francia e al Regno Unito il 10 giugno 1940.
È però vero che, già prima di Compiègne, l’alleanza anglo–francese aveva cominciato a scricchiolare di fronte al successo della Blitzkrieg tedesca, scatenata il 10 maggio, ed al “miracolo” di Dunkerque (e cioè il caotico ritiro del corpo di spedizione britannico in Francia: operazione “Dynamo”, 26 maggio — 4 giugno)[ref]A Dunkerque furono recuperati oltre 338 000 soldati, di cui 120 000 francesi: ma questi ultimi, appena giunti in Inghilterra, furono riorganizzati e frettolosamente rispediti oltremanica per continuare la lotta contro i tedeschi. Le ultime truppe britanniche e francesi (e di altri Paesi alleati, tra cui Polonia e Cecoslovacchia) presenti in Francia, e cioè oltre 215 000 uomini, furono recuperate tra il 14 ed il 25 giugno dai porti dell’Atlantico mediante un ulteriore “miracolo”: l’operazione Ariel. Pur avendo recuperato buona parte del proprio corpo di spedizione, al termine della campagna di Francia l’Inghilterra accusava comunque enormi perdite di materiale: 2 000 cannoni, 60 000 automezzi, 76 000 tonnellate di munizioni, 600 000 tonnellate di carburante e di rifornimenti di ogni genere (oltre l’armamento individuale dei soldati recuperati), 200 imbarcazioni di tutte le dimensioni, tra cui sei cacciatorpediniere e, infine, 177 aerei, di cui circa un centinaio erano preziosissimi aerei da caccia (cfr. la nota successiva→). Per avere un’idea dell’entità di queste perdite basti dire che, dopo Dunkerque, l’esercito inglese disponeva, per la difesa dell’intero territorio metropolitano, di appena 500 pezzi di artiglieria compresi quelli presenti nei musei. Da ciò le pressanti richieste di assistenza militare rivolte da Churchill all’amministrazione statunitense di Franklin Delano Roosevelt (allora neutrale), che si concretizzarono nell’approvazione, nel marzo 1941, del celebre Lend–Lease Act (la legge Affitti e Prestiti).[/ref]; ed è vero che, alla vigilia di Mers–el–Kebir, i rapporti tra i due alleati si svolgevano ormai in un clima di incomprensione e di reciproca sfiducia, culminato in tensioni ed incidenti più o meno gravi[ref]Il primo incidente nei rapporti anglo–francesi si era consumato il 14 maggio, già prima della ritirata di Dunkerque, quando il Governo francese aveva chiesto all’Inghilterra altri 10 squadroni da caccia della Royal Air Force allo scopo di assicurare la copertura aerea delle contro–offensive già pianificate contro l’invasione tedesca. Lo Stato maggiore imperiale britannico aveva discusso e respinto la richiesta francese sulla base del parere del Maresciallo dell’Aria Sir Hugh Dowding, secondo cui gli squadroni della RAF si rendevano indispensabili sul suolo inglese, e solo grazie alla mediazione svolta personalmente da Churchill era stato possibile far giungere in Francia una parte dei rinforzi aerei richiesti.
Questi furono comunque gli ultimi perché, pochi giorni dopo, conclusa l’operazione “Dynamo”, anche Churchill cambiò idea e nessun aereo inglese fu più stanziato in Francia. L’Inghilterra si preparava a sua volta all’invasione (operazione “Seelöwe” o “Leone Marino”, in seguito annullata) e non poteva più permettersi di rinunciare ad un solo aereo o ad un solo pilota: il ruolo decisivo svolto nella Battaglia d’Inghilterra dalla RAF, in condizioni di netta inferiorità numerica rispetto alla Luftwaffe, sarà riassunto dallo stesso Churchill nella famosa frase «Never was so much owed by so many to so few».[/ref]. Il più grave di questi incidenti si era consumato l’11 giugno presso l’aeroporto di Salon, vicino alle Bocche del Rodano, quando automezzi dell’esercito francese erano piombati sulla pista ed avevano impedito ai Vickers Wellington inglesi, che formavano la Haddock Force, di decollare per la prima missione di bombardamento del triangolo industriale Torino–Milano–Genova, poche ore dopo l’entrata in guerra dell’Italia. I francesi temevano che gli inglesi suscitassero la ritorsione italiana e non esitarono a sparare contro altri bombardieri inglesi (i meno brillanti bimotori Whitworth Whitleys) che, sorvolando lo spazio aereo francese, arrancavano dalle basi nello Yorkshire verso le fabbriche della Fiat, della Breda, della Caproni e della Ansaldo. L’attendismo francese nei riguardi dell’Italia terminerà solo il 14 giugno, con la prima (ed unica) azione aeronavale sferrata contro Genova e Savona in risposta ai bombardamenti effettuati dalla Regia aeronautica italiana su Tolone e sui porti della Corsica e della Tunisia; ma l’incidente di Salon scava un solco incolmabile tra Francia ed Inghilterra..
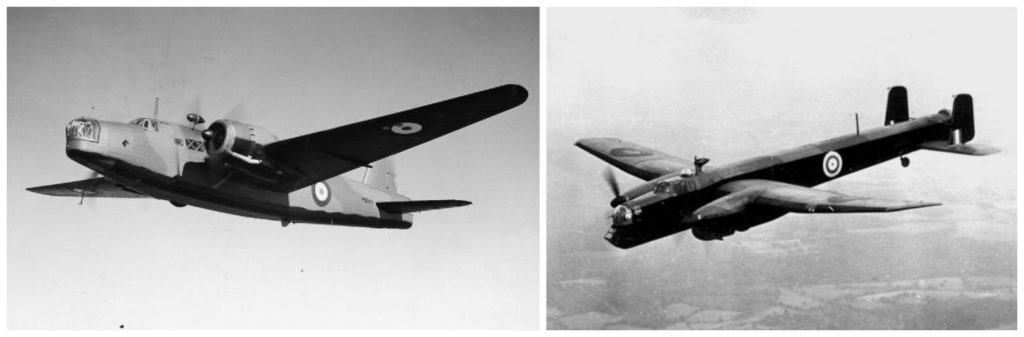
4 – Un Vickers Wellington Mk.1 (a sinistra) e un Armstrong Whitworth A.W.38 Whitley (a destra) della RAF.

5 – Dunkerque, 1940: navi britanniche evacuano le truppe alleate sotto il fuoco degli Stuka tedeschi.
La sorte della Marine Nationale è dunque segnata nel momento in cui la Francia, agonizzante di fronte alla fulminea avanzata tedesca, si decide a negoziare con la Germania una pace separata, che sarà appunto firmata a Compiègne il 22 giugno. Il governo di Sua Maestà britannica, previamente informato dai francesi, acconsente «a condizione, ed esclusivamente a condizione, che la flotta francese parta immediatamente per i porti britannici durante i negoziati».[ref]Cfr. M. Costa, Operazione “Catapult”, in Storia Illustrata, n. 149, 1970, pag. 87.[/ref] La condizione inglese è chiaramente inammissibile, ma risponde all’imperativo di evitare che la Germania si impadronisca della flotta francese (all’epoca la quarta al mondo, anche se sprovvista di sonar e radar) e che la Kriegsmarine nazista possa, così rafforzata, scatenare una “guerra di corsa” in grande stile contro l’Inghilterra, tale da troncare il flusso vitale dei rifornimenti provenienti dall’impero coloniale britannico.

6 – Hitler e il suo entourage a Compiègne il 21 giugno 1940 per la firma dell’armistizio tra la Francia e il Terzo Reich, siglato il giorno seguente nella stessa carrozza ferroviaria già utilizzata per l’armistizio del 1918.
In realtà le clausole armistiziali di Compiègne si erano rivelate assai generose ed avevano permesso che la flotta francese si auto–disarmasse nei porti metropolitani e coloniali.[ref]Le clausole armistiziali stabilivano, inoltre, che una parte ridotta della flotta mantenesse l’armamento a protezione dell’impero coloniale. E, in effetti, al momento dell’armistizio le navi francesi si trovavano, oltre che nei porti dell’Africa settentrionale (Algeri, Biserta, Casablanca e Mers-el-Kebir), in quelli dell’Africa occidentale (Dakar) e dell’Estremo Oriente (Saigon). La flotta presente a Saigon, troppo lontana per essere minacciata dall’operazione Catapult, venne peraltro impiegata con successo durante il breve conflitto franco–thailandese (ottobre 1940–gennaio 1941), che tuttavia terminò — conformemente alle condizioni imposte dalla mediazione giapponese e sancite dal trattato di Tokio del 9 maggio 1941 — con la cessione dei territori francesi rivendicati dalla Thailandia.[/ref] Lo stesso Hitler, durante l’incontro di Monaco del 18–19 giugno, era intervenuto personalmente su Mussolini affinché l’Italia non avanzasse pretese sulla flotta francese, come infatti sancì l’armistizio franco–italiano firmato a Villa Incisa il 24 giugno[ref]L’intervento di Hitler su Mussolini è riportato da Ciano nel suo Diario (cfr. G. Ciano, Diario, op. cit., pag. 189 e ss.). L’Italia si accontentò di trattenere i 7 sommergibili francesi catturati durante le brevi ostilità svoltesi nel corso del mese di giugno.[/ref]. A riprova della volontà francese di conservare la Marine Nationale fedele alla bandiera stavano inoltre i dispacci segreti diramati — sia prima che dopo i due armistizi citati — dal comandante in capo della flotta, ammiraglio François Darlan, con cui quest’ultimo ordinava ai suoi subordinati di auto–affondarsi in caso di violazione degli accordi armistiziali o di attacco tedesco ed italiano[ref]Cfr. M. Costa, Operazione “Catapult”, op. cit., pag. 92.[/ref].

8 – Armistizio franco–italiano di Villa Incisa, 24 giugno 1940: Badoglio legge le condizioni alla delegazione francese.

9 – 13 agosto 1941: il quotidiano francese Le Matin annuncia la nomina dell’Ammiraglio François Darlan della Marine Nationale a ministro della difesa.

10 – Galeazzo Ciano.
Potevano gli inglesi ignorare le clausole di Compiègne (e di Villa Incisa)? Evidentemente no. Ma poteva l’Inghilterra permettersi il lusso di fidarsi della parola data da Hitler ad una Francia in ginocchio? Evidentemente no. Infatti, il 25 giugno, tre giorni dopo la firma dell’armistizio franco-tedesco, Churchill esclamava ironicamente dai microfoni della BBC: «Chiedete a mezza dozzina di Paesi cosa pensano degli impegni solenni assunti dai nazisti».[ref]Cfr. ancora M. Costa, Operazione “Catapult”, op. cit., pag. 89.[/ref] Potevano gli inglesi non essere a conoscenza, tramite i propri servizi di spionaggio, degli ordini diramati dall’ammiraglio Darlan? Evidentemente no. Ma poteva l’Inghilterra correre il rischio che l’insubordinazione o l’infedeltà di qualche ufficiale francese consentisse il passaggio al nemico della Marine Nationale o di una parte di essa? Evidentemente no. La salvezza delle isole inglesi, nel 1940 come nel XVII secolo, dipendeva esclusivamente dal controllo dei mari e dalla rapidità delle mosse fatte sul mare, di cui l’Inghilterra aveva dato, nel tempo, prove più che convincenti.[ref]Basti ricordare, come diretto precedente di Mers–el–Kebir, il bombardamento di Copenaghen effettuato da navi inglesi nel 1807, durante il blocco navale napoleonico, allo scopo di catturare la flotta danese ed evitare che questa cadesse in mano francese.[/ref] Questo aspetto è fondamentale per comprendere le ragioni del contegno inglese ed è ben tratteggiato dall’allora Ministro italiano degli affari esteri, Galeazzo Ciano, che, dopo Mers–el–Kebir, scrisse nel suo Diario: «È presto per giudicare quali conseguenze avrà il gesto inglese: per ora prova che … la flotta di Sua Maestà ha ancora la durezza aggressiva dei capitani e dei pirati del ‘600».[ref]Cfr. G. Ciano, Diario, op. cit., pag. 221 e ss.[/ref]
Veniamo quindi alla tattica ed agli esiti dell’operazione “Catapult”. La forza navale inglese che si presenta innanzi a Mers–el–Kebir all’alba del 3 luglio è comandata dal vice–ammiraglio James Sommerville e si serve del capitano di vascello Cedric Holland, già addetto navale a Parigi, per indirizzare al comandante della flotta francese, ammiraglio Marcel–Bruno Gensoul, il seguente ultimatum: 1) unirsi alla marina britannica; 2) dirigersi, con equipaggi ridotti, verso un porto britannico; 3) disarmare le navi sotto controllo britannico; 4) affondare le navi sul posto. Nessuna di queste proposte sarà accettata dai francesi e alle 17:30, da una distanza di sole sette miglia, i cannoni da 381 mm della Hood, della Valiant e della Resolution centrano le navi francesi ancora agli ormeggi e praticamente inermi.[ref]Nel corso della giornata fatale Gensoul le tenta tutte: dapprima si rifiuta di ricevere Holland, adducendo questioni protocollari; prova, intanto, a contattare via radio l’ammiraglio Darlan, che però è irreperibile; poi si decide a ricevere Holland, rivelandogli gli ordini di autoaffondamento impartiti a suo tempo da Darlan; infine mette al corrente di questi ordini anche Sommerville, mediante uno scambio di messaggi. Purtroppo per Gensoul, nel pomeriggio di quello stesso giorno, da Parigi, l’ammiraglio Le Luc, capo di stato maggiore della marina, ordina alle navi di stanza ad Algeri ed a Biserta di recare soccorso alle unità intrappolate a Mers–el–Kebir: l’ordine di Le Luc, intercettato dallo spionaggio inglese, motiva la decisione di rompere gli indugi (l’ultimatum presentato da Holland era scaduto alle 14:00) e di aprire il fuoco contro le navi francesi.[/ref] Si salva solo la Strasbourg, che riesce a lasciare il porto ed a rifugiarsi a Tolone, con la scorta di alcuni cacciatorpediniere e della porta–idrovolanti Commandant Teste. Analogo ultimatum viene presentato a Dakar il 7 luglio e analoga è la risposta francese, anche se qui, come si è detto, il bottino inglese è meno cospicuo.
Efficace la tattica, disastrosi gli esiti, dal punto di vista strategico e politico. Le navi francesi superstiti convergono su Tolone, e dunque più alla portata degli appetiti (ed eventualmente dei cannoni) tedeschi ed italiani; praticamente nessuno tra gli ufficiali ed i marinai presi prigionieri a Portsmouth ed a Plymouth aderisce alla Francia Libera; la marina diventa popolarissima e molti ammiragli si ritrovano ad occupare posizioni-chiave nel nuovo governo di Vichy;[ref]È il caso del già citato ammiraglio Darlan, che viene nominato ministro della marina e vice presidente del Consiglio dei ministri, cioè capo del governo di Vichy. Per fare un altro esempio basterà ricordare che, nel 1941, il prefetto di polizia (sic!) di Parigi era il contrammiraglio François Bard, che ovviamente operava sotto il controllo della Gestapo.[/ref] l’intera Francia è scossa da un’ondata di anglofobia, che fa giudicare l’armistizio di Compiègne, la politica di Philippe Pétain e lo stesso governo di Vichy più che mai giustificati16;[ref]Anche se ciò non servirà ad evitare a Pétain, nel 1945, la condanna a morte per tradimento, commutata in ergastolo da de Gaulle. Il Maresciallo di Francia Henri–Philippe–Omer Pétain, il “Leone di Verdun”, l’eroe nazionale della prima guerra mondiale, morirà nel 1951 nel carcere dell’Île d’Yeu, al largo delle coste francesi, all’età di 95 anni.[/ref] il 5 luglio le relazioni diplomatiche con l’Inghilterra vengono rotte, con sommo giubilo della Germania; e quando, il 23 settembre, forze inglesi e della Francia gaullista tentano di sbarcare a Dakar (operazione “Menace”) saranno respinte a cannonate dalla guarnigione fedele – e come darle torto? – a Vichy, tanto che saranno costrette a ripiegare su Freetown, nella Sierra Leone britannica. Servirà tutta l’abilità del Presidente statunitense Roosevelt per riguadagnare la Francia alla causa alleata; anche se, in occasione degli sbarchi anglo-americani in Nord Africa dell’8 novembre 1942 (operazione “Torch”), si preferirà dotare i soldati inglesi di uniformi ed equipaggiamenti americani, per non farli riconoscere dalla guarnigione francese.

13 – I generali Spears e de Gaulle a bordo del piroscafo Westernland in viaggio verso Dakar per l’Operazione “Menace”.
L’operazione “Torch” causò, indirettamente, anche la fine di quanto restava della flotta francese. In risposta al facile successo conseguito dagli anglo-americani in Marocco ed in Algeria (tale da suscitare nei vertici nazisti il sospetto — fondato — di accordi segreti tra gli americani ed i rappresentati locali del governo di Vichy),[ref]L’operazione “Torch” è preceduta, accompagnata e seguita da un groviglio di trattative, accordi segreti e rese dei conti all’interno delle forze armate francesi. In questo contesto trova la morte, per cause mai del tutto chiarite, uno dei protagonisti di questa storia, l’ammiraglio Darlan. Dimessosi da capo del governo di Vichy nell’aprile 1942 (e sostituito dal filo–tedesco Pierre Laval), il giorno degli sbarchi alleati in Algeria ed in Marocco (8 novembre) Darlan, per una coincidenza davvero singolare, si trova ad Algeri in visita ad un figlio malato. Nella notte tra il 7 e l’8 novembre, membri della Resistenza francese compiono un colpo di Stato ad Algeri (uno dei pochi, se non l’unico, in cui un apparato di governo militare viene rovesciato con successo da civili) e arrestano, tra gli altri, Darlan ed il generale Alphonse Juin, comandante dell’esercito coloniale (quello stesso Juin che, nel maggio 1944, avrà sotto il suo comando i Goumiers marocchini autori dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità commessi nelle provincie di Frosinone e Latina all’indomani dello sfondamento della Linea Gustav). Contattato dai servizi segreti americani e dal generale Charles Clark, Darlan accetta, dopo alcune esitazioni, di dare ordine alla guarnigione francese di cessare la resistenza e, infatti, gli uomini di Juin depongono le armi (a differenza di quanto fanno, in Marocco, gli uomini del generale Charles Noguès, che resisteranno fino al 12 novembre alle forze del generale statunitense Patton). Ma, nel frattempo, un altro generale francese, Henri Giraud (protagonista di rocambolesche fughe dalle prigioni naziste), si precipita ad Algeri per conto di de Gaulle ed assume, il 9 novembre, il comando delle truppe francesi, al posto di Juin. Il governo di Vichy, intanto, allo scopo di salvare la faccia con la Germania, sconfessa l’ordine di resa di Darlan e nomina il generale Noguès comandante delle truppe francesi in Africa. Ma i rapidi successi militari alleati e la conclusione delle ostilità rimettono in gioco tutte queste decisioni: su pressione degli americani, e contrariamente alla volontà di de Gaulle, Darlan viene nominato Alto commissario per l’Africa e, di fatto, rappresentante presso le forze d’invasione alleate. Nella sua nuova carica, però, Darlan non durerà a lungo: il 24 dicembre sarà assassinato, nei corridori del palazzo di governo di Algeri, da un militante della Francia Libera (ma di idee monarchiche, Fernand Bonnier de la Chapelle). A Darlan succederà l’attivissimo Giraud, che, nell’arco di ventiquattr’ore, farà arrestare gli autori del colpo di Stato del 7–8 novembre (quasi tutti ebrei, i cui superstiti confluiranno più tardi nelle organizzazioni sioniste Haganah e Irgun e combatteranno contro gli inglesi in Palestina tra il 1946 ed il 1948) e farà fucilare Bonnier de la Chapelle, occultando per sempre la verità sulla morte di Darlan. Anche Giraud, però, non avrà grande fortuna: nominato nel giugno 1943 co–presidente del Comitato francese di liberazione nazionale, grazie all’appoggio del presidente Roosevelt (di cui era nota l’antipatia personale per de Gaulle), sarà estromesso da questa carica pochi mesi dopo e morirà nel 1949.[/ref] il 10 novembre 1942 i tedeschi violano l’armistizio di Compiègne — come a suo tempo presagito da Churchill — ed occupano l’intero territorio metropolitano francese (operazione “Anton”); tuttavia, non fanno in tempo ad evitare che la flotta si auto–affondi nel porto di Tolone, per mantenere fede all’impegno di conservarsi fedele alla Francia e per tenere alto l’onore della propria bandiera.

15 – Affondamento dell’incrociatore francese Marseillaise nel porto di Tolone, il 27 novembre del 1942.
E l’onore della bandiera inglese, dopo Mers–el–Kebir? Appena scalfito, se è vero, per dirla con George Bernard Shaw, che «non troverete mai nulla di così cattivo o di così buono che un inglese non faccia, ma non troverete mai un inglese dalla parte del torto».[ref]Cfr. H. Eckert, L’Inghilterra nel giudizio dei grandi, Roma, 1940, pag. 58. Più crudo il giudizio di Erasmo da Rotterdam: «L’Inghilterra riscuote generalmente una pessima fama tutte le volte che si tratta della Fedeltà», ibidem, pag. 6[/ref][endmark]
Riproduzione riservata.
Note
[references class=”compact” /]
Immagini
- Association des Anciens Marins Et des Familles de Victimes de Mers-el-Kébir.
- dalla rivista polacca Morze (“Mare”), nº 6/1936.
- Roma, 10 giugno 1940, fotografo sconosciuto.
- RAF Bomber Command, 1940 circa. —
- Dal documentario di Frank Capra Divide and Conquer (1943), realizzato con materiale di archivio sia da parte alleata che catturato al nemico.
- Deutsches Bundesarchiv / CC-BY-SA 3.0
- Deutsches Bundesarchiv / CC-BY-SA 3.0
- Roma 24 giugno 1940, autore sconosciuto.
- Le Matin, 13 agosto 1941. Anno 58, nº 20942. pag. 1
- Roma, 1937. Corbis
- 1932 c.a.
- Mers–El–Kebir, 3 luglio 1940. World War II Today
- Lt L C Priest, settembre 1940. Imperial War Museum
- Novembre 1942, Lt F. A. Hudson, fotografo ufficiale Royal Navy. Imperial War Museum
- Tolone, 27 novembre 1942. Bundesarchiv, Bild 101I-027-1451-20 / Vennemann, Wolfgang / CC-BY-SA 3.0
- 1934, Library of Congress

1 – Il faro di Belle Tout sopra la scogliera di Beachy Head.
È come una guerra tra noi e la natura,
stiamo tentando di ritirarci più rapidamente di quanto lei avanzi.[ref name=”argus1″]Watts, Alex. “Crucial Days On The Cliff” The Argus 16 Lug. 1998 (in Department of Geography, op. cit.)[/ref]
Beachy Head, o “Beechy Head”, è una corruzione del francese Beauchef (XII secolo), poi Beaucheif (XIV secolo) che significa “magnifico promontorio”, in riferimento alle maestose falesie bianche che si stagliano come una fortezza sulle acque del canale della Manica, appena ad est delle famose scogliere dette Seven Sisters.[ref]Seven Sisters: il nome, che significa “sette sorelle”, è riconducibile al numero di colli che si possono contare nella scogliera.[/ref] In cima a questo capo che si protende dalla costa dell’East Sussex (Inghilterra) si trova il faro di Belle Tout (scritto anche “Belle Toute” o “Bell Toot”), oggi inattivo e classificato dall’English Heritage come Grade II, ovvero «costruzione di speciale architettura o di interesse storico».
[mapsmarker marker=”133″ basemapDefault=”googleTerrain” width=”100″ widthUnit=”%” height=”400″ panel=”false”]
Le falesie di Beachy Head sono uno spettacolo da vedere da lontano. Se di giorno sono sempre state un importante punto di riferimento per la navigazione, di notte la distesa di scogli sottostante, nota come “cimitero dei marinai”, diventava una trappola per le imbarcazioni che si avventuravano troppo vicino alla costa, spinte dal mare mosso o da errori di navigazione.
Il “buco” del reverendo Darby

3 – Chiesa di East Dean (M.M. Viger, 1920 c.a)
Il primo tentativo di stabilire un segnale per rendere più sicuro il passaggio a Beachy Head risalirebbe alla fine del XVII secolo: si racconta infatti tale Jonathan Darby, parroco del vicino villaggio di East Dean, nel 1670[ref]Trinity House (op. cit.)[/ref] o 1680[ref]Holmes (op. cit.)[/ref] ricavò un rifugio nella parete della falesia, che divenne celebre con il nome di Parson Darby’s Hole (lett. “buco del parroco Darby”). Il sacerdote anglicano, a colpi di piccone e scalpello, ampliò una grotta naturale già usata dai contrabbandieri e scavò nella roccia una scala che dalla battigia raggiungesse l’imbocco della cavità, sei metri al di sopra del livello di alta marea.[ref name=”guardian99″]”On the Edge.” The Guardian 26 Gen. 1999 (in Department of Geography, op. cit.)[/ref] Qui sistemò alcune lanterne per rendere visibile la scogliera e spesso vi passava le proprie notti vegliando sul mare tempestoso, pronto a trarre in salvo eventuali naufraghi ed offrire loro un ricovero sicuro ed asciutto. I suoi parrocchiani non gradirono molto queste sue inclinazioni umanitarie perché le comunità locali, già dedite al contrabbando, come in altre zone costiere dell’Inghilterra (→Faro di Longships) traevano ingenti benefici economici dal wrecking, ovvero lo sciacallaggio dei relitti: i naufràgi, insomma, erano un businnes. I wrecker del Sussex sono citati anche nei versi della tragedia The Mourning Bride del drammaturgo inglese William Congreve (1670 – 1729), che così scrisse:[ref]da Congreve, William: The Works of Mr. William Congreve In Three Volumes. Consisting of His Plays and Poems. Vol. 1. Birmingham: Printed by John Baskerville; 1761.[/ref]
Look out when storms arise and billows roar;
Devoutly praying with uplifted hands
That some well-laden ship may strike the sands.
To whose rich cargo they may make pretence.
Guardano fuori quando le tempeste nascono e flutti ruggiscono;
Devotamente pregando con le mani alzate
Che qualche nave ben carica possa colpire le sabbie.
Il cui ricco carico possano rivendicare.
Per rappresaglia contro colui che stava rovinando il “mercato” locale i paesani —come le comari di Sant’Ilario nella canzone di De André,[ref]Bocca di Rosa (1967): «Ma le comari di un paesino/non brillano certo in iniziativa/le contromisure fino a quel punto/si limitavano all’invettiva.»[/ref] — iniziarono a diffondere malignità sul reale utilizzo del rifugio da parte del povero parroco, che con la sua iniziativa salvò invece la vita ad almeno trenta naufraghi: alla sua morte, nel 1729, fu sepolto nel cimitero di Friston con l’epitaffio «Sailors’ Friend», amico dei marinai. Il covo di Darby, una volta abbandonato, tornò ad essere utilizzato dai contrabbandieri ed oggi non esiste più, divorato dall’erosione costiera.[ref]Scomparve completamente tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX: cfr. The Guardian, (op. cit.)[/ref] Ma alla memoria del primo “faro” di Beachy Head è intitolata una birra: una stout[ref]Stout: birre scure ad alta fermentazione prodotte da malto d’orzo tostato, tipicamente inglesi e irlandesi.[/ref] prodotta da un birrificio della vicina Eastbourne porta infatti il nome “Parson Darby’s Hole”.[ref]Beer Searcher. Web. 18-1-2015.[/ref]

4 – Naufraghi a Beachy Head, in una stampa della fine del XVIII secolo.
Il faro di John Fuller
Dopo il rifugio di Darby, a Beachy Head tornò l’oscurità. Nel 1691 ci fu una petizione per la costruzione di un faro sul promontorio, ma fu ignorata ed il vuoto non sarebbe stato colmato per oltre un secolo. Nel febbraio 1833 fece naufragio Thames, un veliero di 1500 tonnellate di classe “East Indiaman”.[ref]L’East Indiaman (plurale East Indiamen) erano una classe di velieri, divisa in sottoclassi di diverso tonnellaggio, costruite in diversi cantieri inglesi tra il Settecento e l’Ottocento.[/ref] Un ricco filantropo di nome John ‘Mad Jack’ Fuller, ex-membro del parlamento britannico, fu talmente impressionato dal disastro che decise di interessarsi personalmente alla costruzione del faro.[ref]”Artists of the South East.” Inside Out. BBC, 30 Gen. 2006. Web. 18-1-2015.[/ref]Un edificio provvisorio in legno fu eretto in cima alla scogliera occidentale del promontorio, detta di “Belle Toute”. Il nome, apparentemente di origine francese, è invece una corruzione del celtico “Bael Tout”, che significa “sentinella di Bael”, la dea della guerra nella tradizione pagana anglosassone. La luce entrò in funzione il 1º di ottobre e si dimostrò subito efficace, riducendo in modo drastico il numero di incidenti.
Il faro di James Walker

5 – “il vecchio faro” di James Walker, in una cartolina dei primi del ‘900.
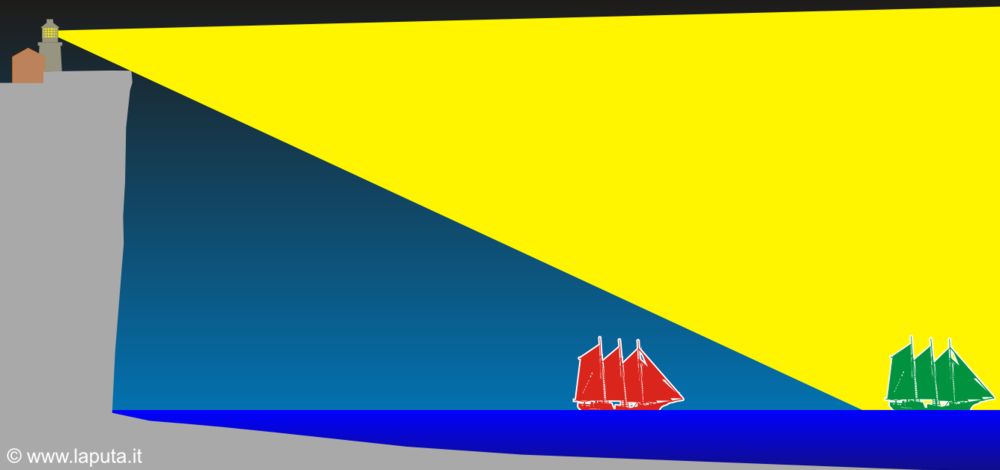
6 – La nave verde si trova ad una distanza sicura dalla scogliera e può vedere la luce del faro. La nave rossa invece è troppo vicina e si trova nella zona d’ombra dove la luce è occultata dalla scogliera: ciò allertava i marinai del pericolo.
Ben presto però si manifestarono due problemi. Il primo era che la luce, in cima alla scogliera, era troppo in alto e le frequenti nebbie (→nebbia sul Canale) lo occultavano alla vista delle navi. Il secondo è che l’erosione costiera causava, e causa tutt’ora, il continuo arretramento del margine della falesia, riducendo via via la distanza tra questo ed il faro. Di conseguenza, la zona d’ombra ai piedi della scogliera continuava a ridursi e le navi, ritenendo di essere al sicuro, si avvicinavano sempre di più alla costa rischiando il naufragio. Nel 1900 Trinity House iniziò così la costruzione di un nuovo faro a Bechy Head, questa volta ai piedi della scogliera e circa un miglio più a est, all’altezza della punta più meridionale del promontorio. L’edificio fu ultimato nel 1902, il 2 ottobre la luce fu accesa e lo stesso giorno il faro di Belle Tout fu messo fuori servizio. Ed è ora che inizia la parte più interessante della storia.

7 – Il nuovo faro di Beachy Head visto dalla scogliera di Belle Tout. (© D. Dixon/Geograph)
Dopo la dismissione

8 – L’impressionante scogliera di Belle Tout, con il faro di Walker. (R. Faulkner/Flickr)
Nel 1935 i coniugi ebbero l’onore di ricevere presso la pittoresca dimora nientemeno che Sua Maestà Giorgio V (1865 — 1936) e la regina consorte Mary di Trek che si trovavano nel West Sussex in soggiorno di convalescenza: «ospiti deliziosi e facili da intrattenere», come ricorda sir James. Il sovrano si appassionò «come un vecchio marinaio» alla collezione di oggettistica nautica che decorava l’abitazione e le raccomandazioni della regina consorte, preoccupata per le sue condizioni di salute,[ref]Il sovrano soffriva di enfisema polmonare.[/ref] non lo fecero desistere dal salire le ripide scale che portavano alla sala della lanterna.[ref]Dalla sala della lanterna, la regina gli urlò «George, non salire qui è troppo ripido per te!» La sua risposta fu: «Dannazione! Sto arrivando!». Cfr. Wright (op. cit.)[/ref]

9 – Giorgio V del Regno Unito e la regina consorte Mary di Tek.
La guerra
Nel 1939 gli eventi europei portano il Regno Unito nella seconda guerra mondiale. Non riuscendo a trovare un accordo con la Gran Bretagna, Hitler pensava di invaderla: la Luftwaffe iniziò una campagna di incursioni contro le difese costiere per preparare il terreno ad una gigantesca operazione di sbarco navale denominata Seelöwe, leone marino, che non ebbero mai modo di realizzare. Le coste furono evacuate dai civili, compresi i proprietari del faro che rimase vuoto. Nel 1942 fu installata una batteria contraerea circa 180 metri ad est dell’edificio. Il promontorio divenne teatro delle esercitazioni dell’artiglieria canadese, che utilizzava vecchie auto o sagome come bersagli per obici e cannoni leggeri, ma che non disdegnò di tirare pure verso il faro causando gravi danni alla struttura. Nel 1943 le pareti di granito erano tanto danneggiate che, nonostante lo spessore di due metri, la luce del sole poteva passare attraverso le crepe. Dopo la fine del conflitto la coppia ottenne 5 mila sterline di rimborso per i danni di guerra. L’edificio storico fu acquistato dal Municipio di Eastbourne, il quale però non aveva i fondi per restaurarlo e lo concesse in locazione con la formula anglosassone del leasehold, un “affitto con diritto di proprietà”,[ref]”Leasehold” Il Sansoni Inglese. Corriere della Sera.[/ref] a tale Edward Revill Cullinan, che inizò la ricostruzione della parte abitativa. Nel 1962 Cullinan rivendette[ref]Nel diritto britannico i contratti di leasehold possono essere venduti, come le proprietà.[/ref] per 15 mila sterline la concessione, che da allora passò in diverse mani fino a che nel 1986 fu acquistata per 250 mila sterline dalla BBC che utilizzò il faro come set per la miniserie The Life and Loves of a She-Devil, trasposizione sul piccolo schermo dell’omonimo romanzo di Fay Weldon del 1983. La produzione fece costruire un patio e, al termine delle riprese, vendette la concessione a Paul Foulkes e sua moglie Shirley che proseguirono il restauro nel rispetto delle caratteristiche “marittime” dell’edificio. Ma il faro era troppo lontano per andarci tutti i weekend e così nel 1995 si trovava di nuovo in vendita. Furono l’imprenditore australiano Mark Roberts e sua moglie Louise a rilevare la concessione per 200 mila sterline, finendo così per ritrovarsi in mano la pagliuzza corta.
Una corsa contro il tempo
Già, perché in tutti questi passaggi l’erosione costiera non si era certo arrestata ed anzi, smentendo gli ottimistici pronostici del geologo londinese, nel 1997 ormai restavano solo circa 10 metri a separare il piccolo faro dal precipizio, margine che continuava ad assottigliarsi. Che fare? I Roberts incaricarono la società di ingegneria Abbey Pynford Company di trovare una soluzione: non potendo arrestare il processo di erosione della scogliera, gli specialisti conclusero che era necessario spostare il faro. Ma servivano 250 mila sterline.
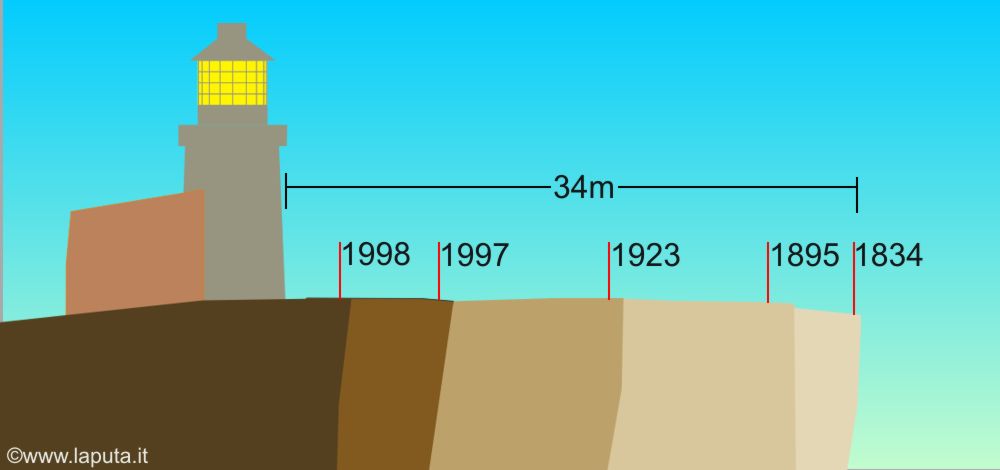
10 – Erosione costiera a Belle Tout.
Fu lanciata una campagna di crowdfunding i cui proventi erano destinati ad un apposito ente fiduciario, il “South Downs Lighthouse Trust”, con il compito di finanziare l’ardita operazione.[ref]Nel 1993 negli USA era già stato spostato un altro faro, quello di Block Island nel Rhode Island. Nel settembre del ’99, qualche mese dopo di quello di Belle Tout, nel North Carolina (USA) fu conclusa una analoga impresa: lo spostamento del famoso faro di Cape Hatteras, nell’arcipelago delle Outer Banks.[/ref] Era una corsa contro il tempo: una notte di novembre del 1998 si verificò un massiccio crollo della scogliera. Roberts, che quella notte dormiva nel faro, ricorda: «Io e mia moglie Louise siamo stati svegliati da un tremendo boato, molto simile ad un tuono, ma che durò per circa un minuto e capimmo che la tanto temuta frana era avvenuta». All’alba, solo 4 metri[ref name=”argus3″]”Race to save family’s teetering lighthouse” The Argus 16 Nov. 1998 (in Department of Geography, op. cit.)[/ref][backref name=”guardian99″ /] di roccia separavano la torre dal suo destino, rovinare sulla spiaggia 85 metri più sotto. Dal punto di vista ingegneristico muovere un edificio storico tutto d’un pezzo non era cosa di tutti i giorni, ma salvarlo dalla terra che si sgretola, inghiottita dal “nulla” come il mondo di Fantàsia ne La storia infinita di Michael Ende, rendeva il tutto vagamente epico.
Per cinque lunghi mesi gli operai lavorarono per rinforzare la struttura, scavare fin sotto l’edificio e realizzare le travi in calcestruzzo sulle quali, spinte da potenti martinetti idraulici e lubrificate con il grasso, sarebbero scivolate lentamente le 850 tonnellate di pietra. Il tutto a badile e carriole, i mezzi meccanici furono banditi perché le vibrazioni avrebbero potuto mettere a rischio la scogliera. L’annuncio che la guardia costiera avrebbe fatto brillare due bombe inesplose della seconda guerra mondiale ritrovate ai piedi del promontorio fece temere il disastro. Invece, il 17 marzo del 1999 tutto era finalmente pronto e — sotto gli occhi di stampa e televisione — furono accese le pompe idrauliche.

12 – I lavori di spostamento del faro, il 17 marzo del 1999 (da un servizio della BBC).
I martinetti, controllati con precisione millimetrica da un computer, spostavano la struttura con una lentezza estenuante: ci vollero tre ore per i primi due piedi (66 cm) ed un intero giorno per percorrere 28 piedi (8,5 m). Entro la serata del giorno successivo l’operazione era terminata con successo, il faro era stato spostato all’interno di 50 piedi,[backref name=”argus3″ /] poco più di 15 metri. Può sembrare poco, ma secondo le stime era sufficiente a metterlo al sicuro per almeno altri 60 anni.[ref]In realtà anche questa volta le previsioni potrebbero essere state ottimistiche: secondo la Applied Geology Research Unit (AGRU) della Brighton University (cfr. Rob Wassel, op. cit.), al tasso di erosione attuale potrebbe essere necessario spostarlo di nuovo entro 34 anni. Le opere eseguite nel 1999 faciliteranno ulteriori spostamenti.[/ref] Mark Roberts, felice, così commentò il successo dell’operazione: «Tutte le nostre bottiglie di vetro erano rimaste perfettamente al loro posto!».[ref]”Bell Toot Lighthouse, Eastbourne.” Solar Navigator. Max Energy Limited Educational Charity., 2006. Web. 20-1-2015.[/ref] Chissà se tra quelle bottiglie ce n’era anche una di amaro, quello che si beve dopo ogni improbabile missione avventurosa che si concluda con la frase: sembrava impossibile, ma ce l’avevamo fatta![ref]Un classico spot televisivo italiano degli anni ’80: cfr. Zacchigna, M. “Amore Montenegro“. Microclismi, 27 Nov. 2011. Web. 21-1-2015.[/ref]

13 – «Sembrava impossibile, ma ce l’avevamo fatta!»
Il faro Belle Tout al tramonto visto da Baily’s Hill (© Simon Carey/Geograph)
Epilogo
I Roberts, già titolari della concessione (leasehold), nel 2002 poterono acquistare dalla municipalità di Eastbourne anche la freehold, la nuda proprietà, diventando così pieni possessori dell’edificio, ma nel 2007 lo rimisero in vendita. Fu fondata un altra charity, la “Belle Toute Lighthouse Preservation Trust”, che promosse una nuova raccolta fondi per acquistare il faro e trasformarlo in una struttura ricettiva, ma nel 2008 fu battuta sul tempo[ref]Mancato lo scopo iniziale, il trust diventò “Belle Toute Lighthouse Information Resource” (op. cit.), un sito web finalizzato alla valorizzazione culturale del faro.[/ref] da David e Barbara Shaw che, dopo una accurata ristrutturazione, vi aprirono nel 2010 un rinomato e suggestivo bed & breakfast. Come da tradizione britannica, nell’edificio si aggirerebbero anche uno o due fantasmi. [endmark]
Note
[references class=”compact” /]Bibliografia e fonti
- Holmes, Edric. Seaward Sussex; the South Downs from End to End. London: R. Scott, 1920.
- Lucas, E.V. Highways & Byways in Sussex. London: MACMILLAN, 1921.
- Wright, Elizabeth “Belle Tout: The Little Lighthouse That Moved“. Timetravel-Britain. 2006. Web. 18-1-2015.
- Wassel, Rob. The Belle Toute Lighthouse Information Resource. Belle Tout Lighthouse Preservation Trust. Web. 18-1-2015.
- Department of Geography. “The moving of Belle Tout Lighthouse” sussex.ac.uk University of Sussex, Web. 18-1-2015.
- Pursell, Sonia. “The Rewards of Life on the Edge.” The Telegraph. Telegraph Media Group, 20 May 2007. Web. 22-1-2015.
- “About Beachy Head” Beachy Head Countryside Centre. Web. 12-1-2015
- Rowlett, Russ “Lighthouses of Southern England” Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill. 11 Giu. 2014, Web. 15-1-2015.
- “Beachy Head“. Trinity House. Corporation of Trinity House. Web 13-01-2015
Immagini
- © Clickos, 14-10-2014 (Depositphotos);
- Frederick Griggs, 1902 [PD] da da E.V. Lucas (op. cit.);
- incisione di Mary M. Viger, 1920 c.a [PD] da Holmes, Edric. Seaward Sussex… (op. cit.);
- Autore sconosciuto, tra 1790-1900 c.a (cfr.)
- 1902 c.a [PD] da Wandering Genealogist;
- © S. Dell’Acqua/Laputa 18-1-2015;
- © David Dixon [CC-BY-SA 2.0] Geograph;
- © Rob Faulkner [CC-BY 2.0] Flickr;
- [PD] da Beach, Chandler Belden, and Frank M. McMurry. The New Student’s Reference Work for Teachers, Students and Families. Chicago: F.E. Compton, 1915.
- © S. Dell’Acqua/Laputa 21-1-2015;
- © Phil Bird 25-7-2014 (Depositphotos);
- © BBC 17-3-1999 (Fair Use) via Youtube.
- © Simon Carey, 20-12-2013 [CC-BY 2.0] Geograph.
1
Se esiste un inferno tra i fari, questo è certamente il primo.[ref name=”paolini”]Paolini, Charles I guardiani dei fari. Sentinelle del mare. Storie e leggendeMilano: Magenes, 2012. Pag. 111.[/ref] Charles Paolini, scrittore
Il capo di Land’s End (“Penn an Wlas” in cornico) è l’estremità della lunga e stretta penisola della Cornovaglia e l’ultimo lembo sud–occidentale[ref]È erroneamente ritenuto l’estremo occidentale della terraferma britannnica, ma in realtà Ardnamurchan Point in Scozia è più a ovest.[/ref] di terraferma prima dell’Oceano; tanto che l’espressione «da Land’s End a John o’ Groats», i due punti estremi della Gran Bretagna,[ref]John o’ Groats, in Scozia, è l’estremo nord–orientale e dista 1400 km da Land’s End[/ref] equivale per i britannici al «coast to coast» statunitense. Qui si trova dal 1908 circa[ref]cfr. History in Pictures[/ref] una storica taverna[ref]Prima di essere una taverna, era una semplice casa con un cartello che recitava «The first and last house» (cfr. History in Pictures)[/ref] chiamata “The First and Last Restoration House in England”, il primo ed ultimo ristoro in Inghilterra (a seconda che veniate dal mare o dalla terraferma).

2 – le scogliere di Land’s End viste da sud (© R. Butterfield/Geograph).

3 – Land’s End: il cartello che segna la “fine della terra” (© L. Clarke/Geograph).

4 – “The First and Last Refreshment House in England”, il primo e l’ultimo punto di ristoro in Inghilterra: si chiama così dal 1908 circa.
Dalla punta del capo guardando verso il mare, si vedono le onde infrangersi contro una striscia di rocce granitiche che emergono a circa un miglio dalla costa. Al tramonto, la sagoma scura di queste rocce ricorda un convoglio di “navi lunghe”, le tipiche imbarcazioni vichinghe, stagliate contro un cielo fiammeggiante: da qui il nome “Longships”, navi lunghe.[ref]Le navi lunghe (longships o longboats) sono la tipologia di navi, tipicamente utilizzate dai vichinghi nordici, cui appartengono i famosi drakkar o drekkar.[/ref] Oggi i turisti giungono sin qui per ammirare la suggestiva scena, ma tanto queste rocce sono scenografiche se viste dalla terraferma, quanto temibili se viste dal mare.

5 – Al tramonto la sagoma delle “Longships” ricorda un convoglio di “navi lunghe”, le tipiche imbarcazioni vichinghe: da qui il nome.
Prima della costruzione del faro doppiare la punta della Cornovaglia significava passare in un canale largo appena ½ miglio tra Land’s End ed i famigerati scogli, in acque che lo scrittore e poeta britannico John Ruskin (1819–1900) descrisse come «…un intero disordine di onde… tutta la superficie del mare diventa un vertiginoso turbine di rapida, contorta, torturata e confusa rabbia».[ref name=”nicholson”]Nicholson (op. cit.)[/ref] Il mare tutt’intorno al capo era disseminato di rocce pericolose[ref]In particolare lo scoglio di “Runnelstone”, vicino alla costa quattro miglia a sud est, e Wolf Rock 8 miglia a sud–ovest, uno scoglio granitico sul quale solo nel 1795 sarebbe stato costruito l’omonimo faro.[/ref] e nessun’altro tratto di costa dell’Inghilterra, si diceva,[ref]In realtà lo si diceva di molte coste, in Inghilterra.[/ref] era altrettanto pericoloso come l’estrema punta della Cornovaglia.[backref name=”nicholson” /] Per affrontare questo essenziale passaggio tra il Canale della Manica e la costa occidentale della Gran Bretagna era necessario che si verificassero condizioni di visibilità sufficiente e mare calmo. Di notte, ma anche di giorno con le frequenti nebbie, il rischio di sfracellarsi sulle scogliere del promontorio o essere trascinati dalle forti correnti tidali[ref]correnti tidali: causate dai moti di marea.[/ref] contro il tagliente granito delle Longships era talmente concreto da far desistere anche i capitani più avventurosi.
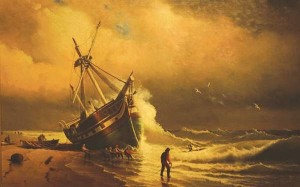
6 – “The Wreckers”, dipinto del 1877 di Robert Swain Gifford.
I mercantili che si sfracellavano sulle rocce erano una vera manna per i wreckers, i pirati di terra che depredavano i relitti del prezioso carico; una pratica tanto comune da coinvolgere intere comunità che vivevano di sciacallaggio:[ref]Nelle comunità costiere della Cornovaglia si insegnava ai bambini a pregare Dio di benedire i genitori e far trovare loro una bella nave sugli scogli ogni mattina: «God bless father’n mither an’ zend a good ship to shore vore mornin’». Cfr. Nicholson, (op. cit.).[/ref] per quanto fosse punito dalla legge e condannato dalla chiesa, il saccheggio dei relitti era una attività redditizia e difficile da contrastare, soprattutto quando costituiva la principale fonte di sussistenza. In mancanza di un faro, alle navi non restava che tentare la sorte. Il primo naufragio documentato in questo punto risale al 1535[ref]Larn, Richard; G. Edwin Mills. Shipwrecks at Land’s End. 1970. p. 34.[/ref] ma si dovette arrivare alla fine del XVIII secolo perché le autorità prendessero finalmente atto della regolarità con cui i vascelli si sfracellavano sul granito intorno a Land’s End. Nel 1790 fu incaricato l’ingegnere John Smeaton, che nel 1759 aveva ultimato con successo l’ardita costruzione del terzo faro di Eddystone al largo di Plymouth, di valutare la costruzione di una luce a Roseveern, nelle vicine Scilly. La conclusione fu però che, vista la distanza di 30 miglia dalla punta della penisola, un faro a Roseveern sarebbe forse stato utile per la navigazione tra le isole (dove peraltro dal 1680 esisteva già un faro, a St. Agnes) ma di nessun effetto sulla navigazione costiera in Cornovaglia. Dietro presentazione di una petizione dei marittimi, per i quali il passaggio di Land’s End costituiva una autentica piaga, il 30 di giugno dell’anno successivo la Corporazione di Trinity House[ref]Trinity House è ancor oggi l’autorità competente per i fari di Inghilterra, Galles, Isole del Canale e Gibilterra.[/ref] ottenne la concessione della Corona per la costruzione di un faro a Wolf Rock, uno scoglio in mare aperto a circa otto miglia a sud–ovest da Land’s End. L’ente non intendeva però assumersi in proprio la responsabilità di un’impresa così ardua e scaricò la “patata bollente” ad un contractor, tale luogotenente Henry Smith [ref]Probabilmente un ufficiale (o ex– tale) della Royal Navy.[/ref] il quale, resosi ben presto conto della difficoltà, rinegoziò la concessione ottenendo la costruzione di un faro in pietra sulle più accessibili Longships (che si distavano solo ½ miglio dalla costa) e due semplici daymark, pali in ferro visibili solo di giorno, sugli scogli di Runnelstone (quattro miglia a sud–est vicino alla costa) e Wolf Rock (che avrebbe visto la costruzione di un faro solo nel 1836).
Il primo faro (1795)
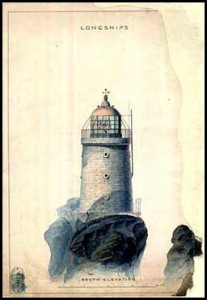
7 – Il primo faro di Samuel Wyatt del 1725 (Trinity House).
Il progetto fu affidato all’architetto Samuel Wyatt, che dal 1766 era consulente di Trinity House e per la Corporazione aveva già all’attivo la costruzione del faro di Dungeness (ultimato nel 1792). La scelta del sito ricadde ovviamente sullo scoglio più grande delle Longships, alto fino a dodici metri sopra il livello di alta marea:[ref]Gli unici tre isolotti a non essere sommersi dall’alta marea sono Tal–y–Maen, Karn Bras e Meinek.[/ref] l’isolotto chiamato Karn Bras, che in cornico significa “grande mucchio di roccia”. Il cantiere fu stabilito a Sennen, sulla costa, dove i blocchi di granito cornico venivano tagliati con gli incastri a coda di rondine che, dopo Eddystone, erano diventati pratica comune nella tecnica costruttiva dei fari in pietra. Imbarcati per attraversare il braccio di mare, venivano messi in posizione sullo scoglio e cementati con calce idraulica in grado di indurire anche sott’acqua. La torre progettata da Wyatt era tozza, alta solo 38 piedi (circa dodici metri) con pareti spesse 4 piedi alla base che si riducevano gradualmente fino a 3 (circa un metro). All’interno era suddivisa in tre locali, il più basso dei quali conteneva la cisterna dell’acqua potabile ed il magazzino. Al piano intermedio si trovava un soggiorno ed all’ultimo la stanza da letto; per passare da una stanza all’altra ci si arrampicava su una scala a pioli. In cima la stanza della lanterna in legno e rame, che ospitava 18 lampade ad olio del tipo “Argand”[ref]La lampada Argand è un tipo di lampada ad olio inventata nel 1783 dal chimico svizzero Aimé Argand (1750 — 1803).[/ref] disposte su due livelli, dotata ciascuna di un riflettore parabolico. L’ottica, che veniva a trovarsi 24 metri sul livello dell’alta marea, era costruita per essere semplice, efficace ed economica: priva di parti in movimento, emetteva una potente luce fissa[ref]La luce fissa era una caratteristica insolita per un faro, anche all’epoca.[/ref] con una portata di 14 miglia nautiche. Per risparmiare combustibile, la luce non era proiettata versa la terraferma e in quella direzione la finestra era sostituita da una lamiera. Ultimato l’edificio, la luce che per la prima volta rompeva l’oscurità delle acque intorno a Land’s End fu accesa il 29 settembre del 1795 e da quel giorno il numero di incidenti diminuì radicalmente. L’ingegnere civile scozzese Robert Stevenson, futuro progettista di fari[ref]La sua più celebre opera sarebbe stata il faro di Bell Rock, nel 1811.[/ref] e nonno del Robert Stevenson autore de L’isola del tesoro e Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde
(per citare i più famosi), visitò il faro nel 1801 e fu molto impressionato dalla potenza della luce, ma anche dalle difficili condizioni di vita dei faristi che dividevano gli esigui spazi dell’edificio, scaldando la cena sulle lampade perché non c’era nemmeno la cucina. La paga era di £ 30 annue e per campare i guardiani dovevano trovarsi un secondo lavoro sulla terraferma nei mesi di riposo.

8 – Land’s End e le Longships , con il faro di Wyatt, in una incisione del 1861 di J. T. Blight.
Nel frattempo Henry Smith, titolare della concessione per 50 anni, si era ritrovato in difficoltà economiche: fu giudicato «incapace di gestire la situazione»[ref]«incapable of managing the concern». Cfr. Trinity House (op. cit.), Nicholson pag. 69 (op. cit.)[/ref] e sollevato dall’incarico, per finire nel 1806 dietro le sbarre della Fleet Prison[ref]Era una prigione per debitori e bancarottieri, chiusa nel 1844.[/ref] di Londra per debiti. La gestione e la manutenzione del faro tornò d’ufficio a Trinity House, ma la Court of Chancery assegnò tutti i profitti derivanti dai pedaggi[ref]I fari erano mantenuti grazie a fees, i pedaggi, tasse riscosse agli armatori in base al tragitto della nave.[/ref] alla famiglia di Smith fino alla scadenza della concessione.[ref]Un caso simile si era verificato al faro delle Skerries nel 1725.[/ref] Non è chiaro il motivo di tanta generosità — apparentemente solo per riconoscenza verso colui che aveva proposto per primo la costruzione del faro[ref name=”th”]Trinity House (op. cit.)[/ref] — ma sicuramente sarebbe costata cara alla Corporazione: per l’esattezza 3017 sterline nel 1831, al netto dei costi di manutenzione pari £1183. Nel 1836 i profitti erano già saliti nel £ 8293[backref name=”th”] e di fronte ad ancora nove anni di pedaggi da versare[ref]La concessione sarebbe scaduta nel 1845.[/ref] Trinity House pensò bene di chiudere la questione e riscattare il faro versando agli eredi la cifra di £ 40 676 in un’unica soluzione. Ma c’era un altro problema: sebbene il faro di Wyatt si fosse dimostrato estremamente efficiente in condizioni ottimali, la furia del mare d’inverno in quel punto era stata invece abbondantemente sottostimata. Durante le tempeste, il faro era esposto a mareggiate di tale violenza che le onde superavano in altezza il faro, oscurandone la luce. L’acqua mandava in frantumi i vetri della lanterna e nel 1815, stando a quanto riporta la Royal Cornwall Gazette del 7 gennaio, l’edificio fu gravemente danneggiato dall’impatto di un’onda e ci vollero diversi giorni per ripararlo; ancora il 7 ottobre del 1857, sette delle 18 lampade furono spente dall’acqua durante una tempesta. L’unica soluzione era una torre più alta.
Il secondo faro (1870)

9 – Il secondo faro di Douglass , in un acquerello del 1891 di Themistokles von Eckenbrecher.
Nel 1869 fu incaricato del progetto l’ingegnere Sir James Nicholas Douglass (1857 — 1913)[ref]Già progettista del faro di Small Island (1861) e supervisore di quello di Wolf Rock (1869), fu in seguito membro (fellow) della Royal Society, ingegnere in capo di Commissioners of Irish Lights (ente per i fari d’Irlanda ed Irlanda del Nord), progettista del terzo faro di Bishop Rock (1877) ed il quarto faro di Eddystone (1877)[/ref] che aveva appena ultimato la costruzione del vicino faro di Wolf Rock, alle Scilly, da dove furono recuperati macchinari, attrezzature ed imbarcazioni. Il granito, in parte cornico ed in parte proveniente dal nord della Francia, veniva tagliato a terra secondo i disegni esecutivi e trasportato alle Longships con speciali barche dotate di rulli per agevolare lo scorrimento dei blocchi, che venivano infine sbarcati e posizionati con una gru. Nel 1870, sotto la capace direzione del supervisore[ref]Quello che oggi chiameremmo site manager, il direttore dei lavori.[/ref] Michael Beazeley che aveva seguito Sir Douglass da Wolf Rock, iniziò la costruzione della nuova torre sullo stesso scoglio di Karn Bras, accanto al vecchio faro di Wyatt che restò attivo per tutto il tempo dei lavori. Nell’inverno del 1872 quindici uomini rimasero bloccati per diverse settimane nei due fari, a causa del mare mosso che impediva l’avvicinamento delle imbarcazioni, ma a parte questo inconveniente i lavori proseguirono senza particolari incidenti ed il nuovo faro fu ultimato nel 1875. La torre di Douglass era alta 35 metri, snella ma solida, a “fusto di quercia” con piccole finestre; in cima la lanterna ospitava una lampada a vapori pressurizzati di kerosene con ottica rotante. Anche nel nuovo edificio le condizioni di vita e di lavoro dei faristi erano tutt’altro che confortevoli: le stanze rotonde non raggiungevano i 2,5 m di diametro inclusa la scala, le provviste consistevano in cibi secchi o salati (non esistevano frigoriferi) ed i turni di permanenza erano di uno o due mesi. Anche il cambio era difficoltoso e non privo di rischi: se il mare non era sufficientemente sicuro (il che significava praticamente piatto), il soggiorno forzato doveva prolungarsi in attesa di condizioni migliori. Nonostante la relativa vicinanza alla costa, Longships era uno dei fari più isolati e meno amati dai faristi.

10 – Il faro delle Longships sull’isolotto di Karn Bras (Depositphotos).
Nonostante i miglioramenti il rischio era sempre in agguato e gli incidenti non cessarono mai del tutto: ad esempio il 9 novembre del 1898 fu il piroscafo britannico SS Blue Jacket a finire inspiegabilmente contro gli scogli in una notte limpida[ref]Noall, C. Cornish Shipwrecks Illustrated. Truro: Tor Mark Press; 1969. p. 21[/ref] ed ancora di recente, nel 2003, la nave da carico tedesca RMS Mülheim naufragò sulle scogliere di Land’s End. Nel 1967 il segnale fu elettrificato e modernizzato: la lampada divenne elettrica e la nuova ottica rotante produceva un fascio isofase;[ref]Isofase: è la caratteristica luminosa in cui la luce ha la stessa durata dell’eclissi; in questo caso ad esempio 5 + 5 secondi.[/ref] di 5 secondi seguito da altri 5 di eclisse, bianco o rosso a seconda della direzione di osservazione e visibile a 19 miglia nautiche. anche il segnale da nebbia, del tipo esplosivo a cartucce di nitrocellulosa,[ref]Un segnale di questo tipo era stato installato anche sul terzo faro a Bishop Rock nel 1877.[/ref] fu sostituito con un più moderno corno ad aria. La realizzazione di una piattaforma sopra alla lanterna per l’atterraggio degli elicotteri alla fine degli anni ’70 rese l’avvicendamento del personale più rapido, ma non meno avventuroso: inevitabile che Longships fosse tra i primi candidati per l’automazione, che avvenne senza interruzione del servizio tra il 1987 e l’inizio del 1988. La cisterna dell’acqua potabile alla base dell’edificio, convertita in serbatoio del gasolio, avrebbe alimentato i nuovi motori diesel per almeno sei mesi. Da allora, il personale vi si reca solo per i rifornimenti e per la manutenzione programmata.

11 – Longships dalla terraferma, a Carn Barra (© B. Jones)
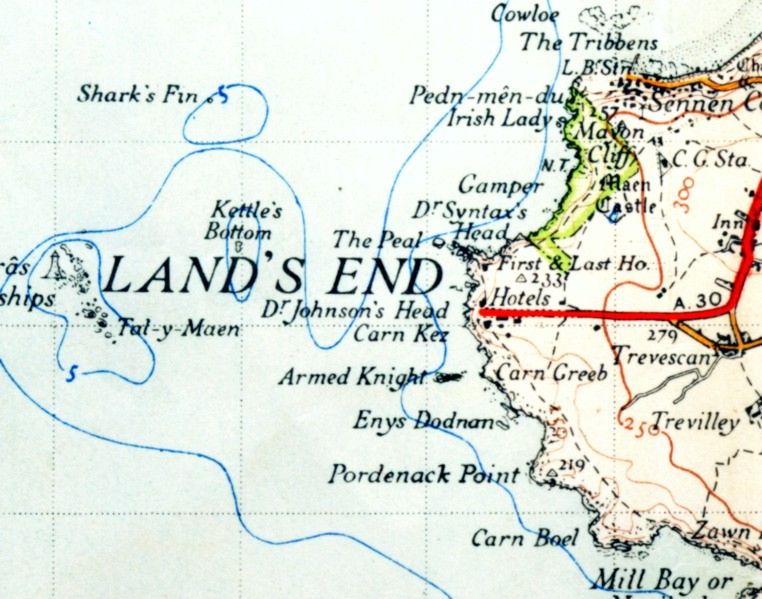
12 – Land’s End in una mappa del 1946: a sinistra è indicato il faro.
Storie e leggende
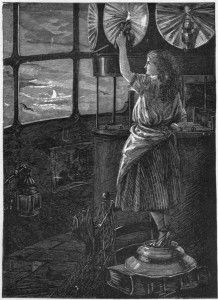
13 – La piccola Mary, in piedi sopra ad una Bibbia, accende le lampade del faro: illustrazione da “The watchers on the Longships. A tale of Cornwall in the last century” di J.F. Cobb (1905, pag. 208.)
Il faro di Longships fu oggetto di racconti e leggende popolari che si confondono con la cronaca. Nel dicembre del 1842 un quotidiano locale riferì che uno dei due guardiani, un uomo di nome Clement, tornò a terra con i capelli completamente grigi dopo essere stato intrappolato al faro con un collega per ben quindici settimane. Nel 1861 si riporta un incidente nel quale avrebbe perso la vita un farista, lasciando il collega a governare il faro fino all’arrivo dei soccorsi. Secondo lo scrittore C. Nicholson[backref name=”nicholson” /] l’autenticità della notizia resta dubbia poiché il fatto sembra ricalcare quanto accaduto invece alle Smalls agli inizi del XIX secolo. Nel 1873 la stampa riferì invece di un guardiano che, recatosi sulla terraferma per acquistare le provviste, sarebbe stato rapito dai wreckers che speravano così di impedire l’accensione del faro. Quella notte, però, la luce entrò in funzione lo stesso per guidare le navi lungo il passaggio: ad accenderlo fu la figlia dello stesso farista che, non vedendo rientrare il padre, si prodigò ad accendere la luce alzandosi in punta di piedi sopra ad una grossa Bibbia per arrivare alle lampade, garantendone il funzionamento per molte notti prima di essere raggiunta dai soccorsi. La storia, non priva di retorica, è abbastanza inverosimile da essere classificata tra le leggende senza tema di smentita (all’epoca i guardiani erano almeno tre e i familiari non soggiornavano al faro) ma piacque a James Francis Cobb che la riprese nel suo romanzo Watchers on the Longships (1878) insieme a quella del farista tornato con i capelli grigi. Secondo lo scrittore, i rumori del vento tra le fessure della roccia ed amplificati dall’acustica dell’edificio avrebbero terrorizzato alla follia «più di un farista» tra i meno esperti. La leggendaria rumorosità del faro di Douglass, citata anche da Charles Paolini in I guardiani dei fari, ha però un fondo di verità: all’interno della torre in pietra, un canale lungo 35 metri e largo poco più di due, ogni urto delle onde risuona «come un corno da caccia.»[backref name=”paolini”/][ref]Secondo Paolini la rumorosità era dovuta anche al fatto che la torre fosse in ferro. A Longships però non è mai esistito un faro metallico, entrambi gli edifici furono costruiti in granito.[/ref] [endmark]

14 – Le Longships (© R. Croft/Geograph)
Note
[references class=”compact” /]
Bibliografia e fonti
- Nicholson, Christopher P. “Longships.” in Rock Lighthouses of Britain: The End of an Era?
Toronto: Dundurn, 1995. 67-74.
- Mariotti, Annamaria Lilla
. “Longships.” Fari
. Vercelli: White Star, 2005. 112-115.
- “Longships.” Trinity House. Corporation of Trinity House and Depford Strond, n.d. Web. 31-5-2014.
- Rowless, Russ “Lighthouses of Southwest England (Devon and Cornwall)“. Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill. 19 giugno 2014, Web 17/12/2014.
Immagini
- © Ian Woolcock: Storm at Lands End Cornwall England. Fotolia.
- © Roger Butterfield, 9-5-2006 [CC-BY-SA 2.0] Geograph.
- © Lewis Clarke, 2-7-2011 [CC-BY-SA 2.0] Geograph.
- © Chris Dorney 18-9-2012. Depositphotos.
- © olliemt1980, 3-7-2014. Depositphotos.
- Robert Swain Gifford, 1877. The Wreckers. [PD] Commons.
- Trinity House [PD] tavola nº 1122 (via Little Dart).
- John Thomas Blight, 1861 [PD] Commons.
- Themistokles von Eckenbrecher, 1891 [PD] Commons.
- © urbanbuzz, 6-8-2014. Depositphotos.
- © Bob Jones, [CC-BY-SA 2.0] Geograph.
- Ordnance Survey Map [PD] Commons.
- 1905, da Cobb, James F. The Watchers on the Longships. A Tale of Cornwall in the Last Century. 25ª ed. London: W. Gardner, Darton, 1905. 208. Internet Archives.
- © Richard Croft [CC-BY-SA 2.0] Geograph.
1914–2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – Agosto 1914: un vagone ferroviario carico di soldati tedeschi in partenza per la Francia «da Monaco via Metz per Parigi» («Von München über Metz nach Paris»). La scritta più piccola a destra nella foto che dice invece «vagone-letto fornito di birra dell’Hofbräuhaus di Monaco» (Bundesarchiv).
Certo è un ottimo sport; ma all’esercito l’aereo non serve a nulla.
Generale Ferdinand Foch
Nell’estate del 1914 i tedeschi erano convinti che sarebbe bastato poco tempo per arrivare vittoriosi a Parigi ma le loro speranze furono presto vanificate. L’immobilità della guerra di trincea indusse le potenze in conflitto a ricorrere a ingegno, astuzia e ad una buona dose di cinismo pur di venir fuori dal pantano della prima guerra mondiale: il risultato il più delle volte, oltre a cambiare il modo di fare la guerra, fu un nuovo orrore. In tutto questo però vi fu anche chi superò le barriere nazionali e di parte fino a diventare leggenda collettiva.
Armi chimiche
Alle ore 17 del 22 aprile del 1915 nel villaggio belga di Ypres risuonarono fragorose le esplosioni delle cannonate e delle granate tedesche ma poco dopo, a fare più danni delle cannonate, arrivò sul fronte franco-inglese una nebbia venefica di un colore tendente al grigio-verde. Quella nebbia altro non era che cloro allo stato gassoso, altamente tossico, che si utilizzava per le tinture chimiche; il suo effetto sull’organismo umano era di causare un versamento di liquidi nei polmoni provocando una morte per annegamento. La convenzione dell’Aja del 1899, firmata anche dalla Germania, vietava l’uso di armi chimiche ma i tedeschi trovarono una scappatoia “formale”: la convenzione infatti proibiva l’uso di gas per mezzo di proiettili di artiglieria e i tedeschi fecero così ricorso a delle bombole di gas posizionate sulle trincee. Il 22 aprile grazie al vento che soffiava nella direzione francese i tedeschi aprirono seimila bombole, dando origine ad una nebbia tossica di cloro larga sei chilometri. Per una beffarda ironia della sorte i tedeschi non approfittarono del profondo varco aperto nelle linee difensive francesi in quanto non si aspettavano un simile “successo” e pertanto non avevano uomini a sufficienza per occupare le posizioni. L’uso del gas da parte tedesca causò un’ondata di indignazione [ref]A questo proposito Basil H. Liddel Hart ha osservato che l’indignazione era soprattutto dovuta al fatto che a utilizzare il gas fosse stato il nemico, perché uccidere dei soldati con il gas non poteva essere considerato più crudele che ucciderli mitragliandoli di colpi.[/ref] ma ben presto anche gli altri contendenti fecero ricorso alle armi chimiche, sviluppando sia nuovi gas sia le relative contromisure (ovvero le maschere antigas). Gli inglesi nel loro primo attacco con armi chimiche ebbero la sfortuna di incappare in un repentino cambio di vento, cosicché il gas tornò sulle trincee inglesi uccidendo centinaia di soldati; i francesi nel dicembre del 1915 invece impiegarono sul campo di battaglia un nuovo gas, il fosgene, che aveva la caratteristica micidiale di essere incolore e pertanto a differenza del cloro, non poteva essere avvistato a distanza. La ricerca di gas sempre più micidiali continuerà fino alla fine della guerra. Nel giugno del 1916 a Verdun i tedeschi violarono definitivamente la convenzione dell’Aja e utilizzarono l’artiglieria per lanciare i gas: in questo caso il gas era il disfogene, variante del fosgene, in grado di distruggere i filtri delle maschere anti-gas. L’attacco a Verdun alla fine fu respinto ma i tedeschi non finirono di creare nuovi gas e nel 1917 lanciarono il più micidiale di tutti i gas sperimentati durante la Grande Guerra: i tedeschi l’avevano nominata “croce gialla” ma è passato alla storia come “iprite”, dal nome del villaggio di Ypres dove era stato utilizzato la prima volta, o “gas mostarda”, per via del colore e dell’odore. Il gas mostarda non era letale ma provocava vesciche sulla pelle consumandola e causando dolori lancinanti. Il gas mostarda pur non essendo letale è diventato il più tristemente famoso dei gas utilizzati per via dell’alto numero di feriti e per l’entità delle ferite inferte. Alla fine della guerra saranno più di una ventina gli agenti chimici utilizzati come arma dalle varie potenze; essi rappresentano il primo impiego di armi di distruzione di massa nella storia.

2 – 1918, soldati del 12th Royal Scots (Reggimenti Scozzesi) in trincea a Méteren (Francia) con le maschere antigas, 1918.
Lanciafiamme
Il 30 luglio del 1915 non lontano da Ypres i tedeschi utilizzarono per la prima volta i lanciafiamme: un muro di fuoco si abbatté sulle trincee inglesi. Le urla strazianti e la vista dei corpi carbonizzati dei commilitoni generarono il panico, inducendo i soldati a fuggire dalle trincee diventando così facili obiettivi per i mitraglieri tedeschi appostati sulle trincee. Gli inglesi erano indignati e infuriati per questa nuova arma e pianificarono un contrattacco che individuò il punto debole dell’arma tedesca: il serbatoio posizionato sulla schiena. I lanciafiamme tedeschi esplosero sotto i colpi dei tiratori scelti inglesi che alla fine recuperarono le posizioni perdute tornando così al punto di partenza del 30 luglio. Dopo l’utilizzo da parte tedesca anche in questo caso inglesi e francesi adottarono i lanciafiamme anche se il contrattacco inglese ne aveva evidenziato il limite. L’Italia una volta entrata in guerra oltre ad adottare un lanciafiamme simile a quello tedesco adottò anche un lanciafiamme statico per scopi difensivi.
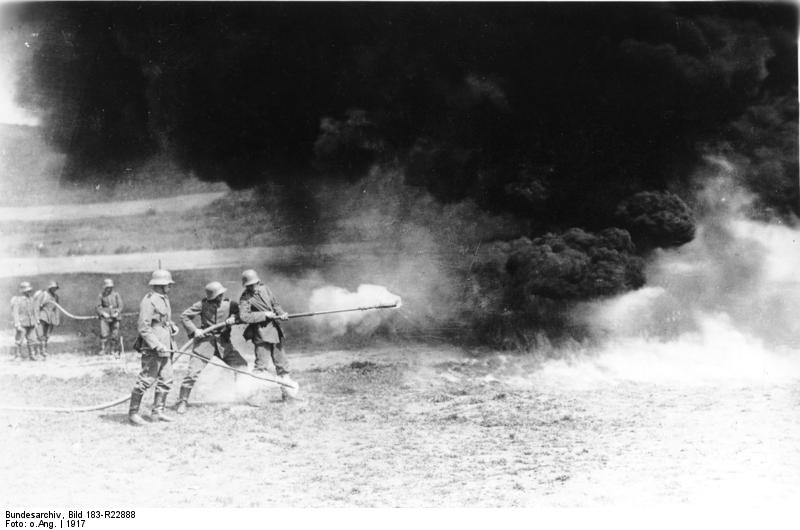
3 – Soldati tedeschi provano un lanciafiamme, 1917.
L’esplosione di Messines
Le alture di Messines, sempre poco distante da Ypres, furono una posizione cruciale in mano ai tedeschi fin dall’inizio della guerra. Gli inglesi per mesi scavarono tunnel, alti un metro e venti e larghi sessanta centimetri, sotto le trincee tedesche posizionando venti “mine”, ovvero tonnellate di tritolo. Dopo quasi due anni di lavori una rete di ventuno tunnel, per quasi 8 chilometri di lunghezza, era pronta con quattrocentocinquanta tonnellate di tritolo posizionate. Il 7 giugno del 1917 le diciannove mine (una era stata individuata e fatta brillare dai tedeschi) esplosero simultaneamente dando vita all’esplosione più grande che la storia avesse mai visto:[ref]Il “record” è stato battuto solo dalle esplosioni nucleari.[/ref] tutti i soldati tedeschi nel raggio di sessanta metri dall’esplosione morirono sul colpo, le esplosioni fecero vibrare le finestre fino a Londra e furono registrate come terremoto in Svizzera. Lo shock per i tedeschi, che videro letteralmente i corpi dei propri compagni piovere dal cielo, fu tremendo e gli inglesi conquistarono Messines. L’operazione di Messines fu un episodio unico e non più ripetibile.
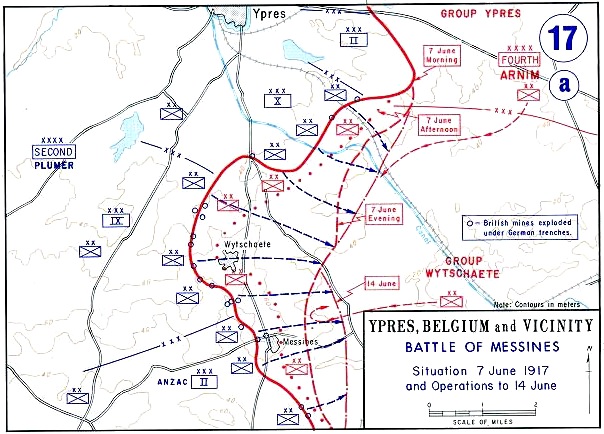
4 – Mappa della battaglia di Messines del 17 giugno 1917 (US Military Academy).
Aviazione
Nei primi mesi di guerra l’unico ruolo affidato all’aereo fu quello della ricognizione. Successivamente e molto lentamente gli aerei furono utilizzati come strumenti di contatto visivo tra i vari reparti di fanteria in modo da indirizzarla durante la battaglia e avvisare di eventuali contrattacchi in essere. Contemporaneamente l’equipaggiamento aereo si arricchiva di armi e vennero messi a punto meccanismi in grado di permettere di utilizzare una mitragliatrice anteriore nonostante le eliche. Pian piano l’aviazione divenne la “cavalleria dell’aria” e della cavalleria, ormai inutilizzabile nella nuova guerra, conservò alcune tradizioni come gli emblemi sugli aerei; quello di un campione italiano, Francesco Baracca, sarà poi donato ad Enzo Ferrari ed è tuttora il simbolo di una delle auto più famose al mondo.

5 – Francesco Baracca con il suo SPAD S.XIII: sulla carlinga il famoso “cavallino rampante” poi simbolo della Ferrari.
Come i cavalieri medievali ben presto un uomo diventerà una leggenda: il barone Manfred Albrecht Von Richthofen meglio noto come il Barone Rosso. Il suo “circo volante” era una delle squadre aeree più famose della Grande Guerra e insieme agli altri team tedeschi, o caroselli, misero in seria difficoltà la supremazia aerea dell’Intesa. In termini assoluti di “duelli” aerei altri piloti hanno superato Von Richthofen ma nessuno ha mai avuto lo stesso impatto sull’immaginario collettivo: al di là di libri e film su di lui, il Barone Rosso infatti pur non apparendo mai è il nemico nemmeno tanto immaginario dello Snoopy aviatore; nella serie Gundam uno dei protagonisti, Char Aznable, essendo un pilota formidabile ha il diritto di colorare i proprio mezzi di rosso e questo viene popolarmente considerato un riferimento al Barone Rosso.

6 – L’Albatros D.V di Manfred Von Richtofen (B.Huber, CC BY-SA 3.0).

7 – Un poster di propaganda britannico della prima guerra mondiale che faceva leva sulla paura suscitata dagli “Zeppelin” tedeschi.
Molto meno cavalleresco fu invece il primo blitz aereo della storia: il 19 gennaio 1915 i dirigibili ideati dal conte Von Zeppelin bombardarono obiettivi militari sulla costa orientale dell’Inghilterra ma la scarsa precisione del bombardamento causò anche sei vittime tra i civili. Il Kaiser aveva approvato con riluttanza l’utilizzo del bombardamento aereo e aveva richiesto che fossero indirizzati solo contro obiettivi militari; successivamente tenuto all’oscuro della scarsa precisione del bombardamento aereo il Kaiser approvò un attacco sul porto di Londra. Pur sapendo di non poter evitare di colpire i civili come ordinato dal Kaiser, l’alto comando tedesco optò per una campagna sempre più aggressiva degli zeppelin contro l’Inghilterra causando il panico tra la popolazione. Alla fine gli inglesi riusciranno a implementare adeguate difese contraeree e ad abbattere i dirigibili, riducendone così l’utilizzo da parte tedesca. Il vaso di Pandora ormai era stato aperto: gli aerei conquisteranno sempre più importanza negli eserciti e nel successivo conflitto mondiale la loro potenza di fuoco sarà in grado di distruggere intere città.
Carro armato
Il 15 settembre 1916 una nuova arma compare sul campo di battaglie delle Somme: il carro armato. Il nuovo mezzo tuttavia non ha avuto una genesi semplice. Denominato tank (la cui traduzione letterale è cisterna) con lo scopo di fuorviare il nemico era in realtà conosciuto nell’ambiente militare inglese con il nome di “nave di terra” o anche “incrociatore di terra” in quanto il progetto era in capo all’Ammiragliato. Infatti inizialmente scartato nel 1915 dall’esercito inglese il progetto fu ripreso e sostenuto da Churchill che diede vita al Comitato per le navi di terra all’interno dell’Ammiragliato. Dopo non poche difficoltà tecniche, dovute ad una mancanza di chiare indicazioni tattiche sull’utilizzo dell’arma e al generale scetticismo, il 2 febbraio del 1916 si ebbe infine il primo collaudo: l’esito della prova del carro, ribattezzato “Big Willie” o anche “Mother”, fu soddisfacente e furono commissionati i primi quaranta esemplari (poi aumentati a centocinquanta)[ref]Paradossalmente i francesi intuirono più degli stessi inglesi le potenzialità del mezzo e la loro prima commissione fu di quattrocento esemplari poi aumentati fino a ottocento.[/ref]. Nell’estate del 1916 mentre i primi equipaggi venivano addestrati il comando inglese sceglieva un nome per i carri che fosse plausibile con i grossi teloni utilizzati per nasconderli da sguardi indiscreti: le opzioni erano tank, cistern e reservoir. Le misure precauzionali funzionarono e quando il tank ebbe il battesimo del fuoco la sorpresa del nemico fu totale. Le cose non andarono però tutte nel verso giusto: non dando ascolto agli uomini del progetto, i militari impiegarono l’arma troppo presto e in malo modo mettendone a repentaglio la sopravvivenza ma soprattutto riportando le posizioni in stallo. Solo con l’offensiva di Cambrai nel novembre del 1917 il carro armato fu impiegato con discernimento e iniziò a risultare determinante per le sorti del conflitto. Vent’anni dopo il timido inizio il carro armato sarà al centro delle vicende belliche sulla terraferma.
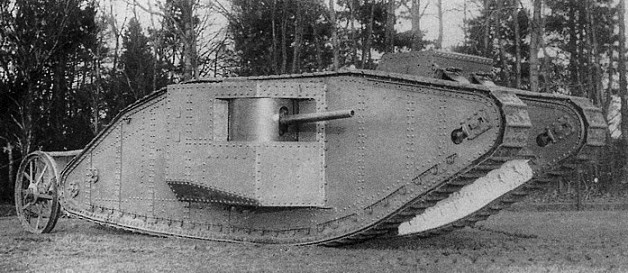
8 – Carro armato britannico British Mark I alla Somme, 1916.
Sommergibili
La Grande Squadra della Marina britannica era un nemico troppo forte per poter essere affrontato in mare aperto dalla Marina tedesca. L’ammiraglio Von Tirpitz ideò quindi una strategia sull’utilizzo indiscriminato dei sommergibili contro navi britanniche al fine di strangolare economicamente la Gran Bretagna; inoltre le mine posizionate e i sommergibili avrebbero logorato lentamente la marina da guerra inglese fin quando non si fosse presentata un’occasione favorevole per un attacco a sorpresa. A seguito delle forti proteste americane, praticamente un ultimatum, per l’affondamento del Lusitania i tedeschi si videro costretti ad interrompere la loro strategia nell’aprile del 1916 per poi riprenderla lentamente nell’autunno dello stesso anno. Gli U-boot tedeschi erano micidiali e a gennaio del 1917 metà del naviglio mercantile britannico era stato affondato. L’utilizzo crescente da parte inglese delle “navi-Q”, ovvero di navi mercantili dotate di equipaggiamento militare e con a bordo militari addestrati ad hoc, tolse ai tedeschi le ultime remore e il 1 febbraio del 1917 la Germania proclamò la guerra sottomarina “indiscriminata”: tutte le navi sarebbe state affondate senza preavviso quale che fosse il loro utilizzo. Su questa decisione che comportava di fatto l’entrata in guerra degli Stati Uniti (unita al fatto che la Germania tentò di influenzare il Messico al fine di far loro dichiarare guerra agli USA) pesò non poco il timore tedesco sulla propria tenuta economica e si optò quindi per utilizzare i sommergibili per indurre l’Intesa al crollo economico. Durante la seconda guerra mondiale i nazisti misero di nuovo in atto con successo la strategia di Von Tirpitz.
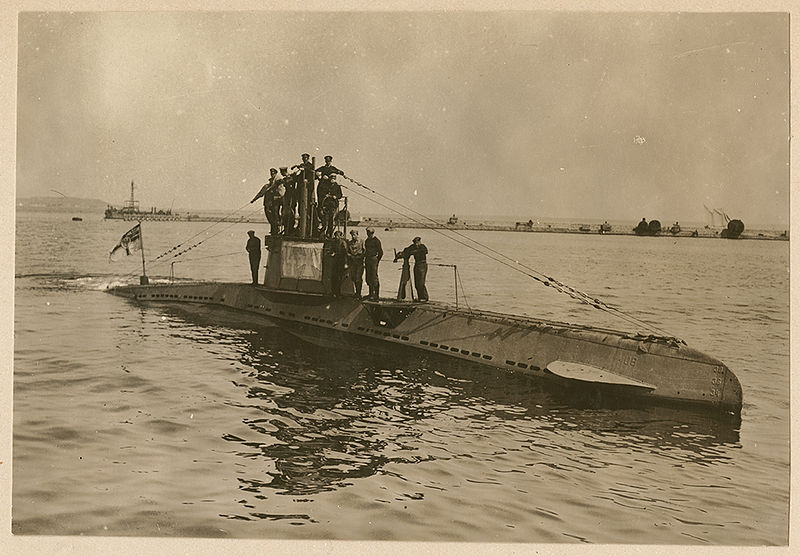
9 – U-boat tedesco UB14 nel Mar Nero, primavera 1918
Spionaggio
A differenza degli assi dell’aviazione le spie sono vecchie come il mondo e hanno sempre lavorato dietro le quinte dei conflitti rimanendo anonime. Con la Grande Guerra e i moderni mezzi di comunicazione lo spionaggio diventa un vero e proprio fronte di guerra trasversale in cui è fondamentale sia conoscere le intenzioni dell’avversario sia tenere compatta l’opinione pubblica interna. Le spie una volta scoperte solitamente finiscono davanti un plotone d’esecuzione e poi dimenticate eppure la Grange Guerra ne ha consegnato una alla leggenda: Mata Hari. Nata a Leeuwardenin Olanda il 7 agosto del 1876 Margaretha Geertruida Zelle si sposò con un ufficiale coloniale olandese e lo seguì in Indonesia dove rimase fino al 1902. Tornata in Europa si stabilì poi a Parigi dove divenne una famosa interprete di danze orientali. Divorziata dal marito ebbe un’intensa attività mondana e non pochi facoltosi amanti. Donna di grande fascino, cultura e intelligenza nel 1914 divenne una delle più abili spie tedesche con il nome in codice “H21”. Mata Hari però confidò troppo in sé stessa e sulle sue protezioni e iniziò a fare il doppio gioco servendo anche lo spionaggio francese. Una volta intuitolo, i servizi segreti tedeschi fecero in modo da indirizzare il controspionaggio francese sulle tracce dell’agente H21 e Mata Hari fu così arrestata il 13 febbraio del 1917, processata e infine fucilata il 15 ottobre 1917. L’alone di leggenda che circonda la figura di Mata Hari tuttavia resiste a cent’anni di distanza. L’informazione è potere e in guerra può essere cruciale; da Mata Hari in poi le spie risulteranno determinanti per la riuscita delle grandi operazioni militari.
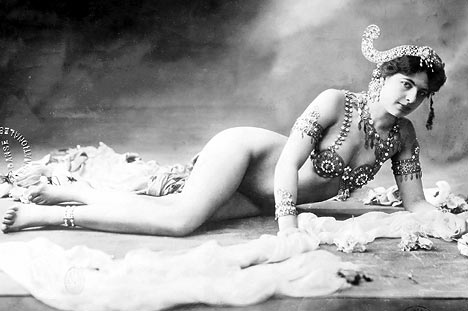
10 – Mata Hari nel 1906, quando era una danzatrice.
Nello stallo dovuto alla guerra di trincea si iniziò quindi a far uso di qualsiasi arma a disposizione senza più porsi alcun problema di ordine morale. La Grande Guerra ebbe però anche una parentesi di spontanea umanità: la tregua di Natale del 1914.
Note
[references class=”compact”/]
Bibliografia e fonti
- Liddell Hart, sir Basil Henry La prima guerra mondiale. 1914-1918
Milano: RCS Libri, 1999.
- WWI: la prima guerra moderna, History Channel
- I lanciafiamme. Itinerari della Grande Guerra. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- Un’affascinante spia: Mata Hari. Rai Storia.
Immagini
- Oscar Tellgmann (1857–1936). Monaco, agosto 1914 [PD] Bundesarchiv Bild 146-1994-022-19A;
- John Warwick Brooke, Méteren 25-6-1918 [PD] Imperial War Museum Q-6775;
- Westfront 1917 [PD] Bundesarchiv Bild 183-R22888;
- United States Military Academy – West Point, 1938 [PD] Commons;
- 1917-1918 c.a [PD] Commons;
- Björn Huber, 9-9-2011 [CC BY-SA 3.0] Commons;
- Franks Valli, 1915–18 c.a [PD] Commons;
- 1916 [PD] Commons;
- 1918 [PD] Commons;
- 1906 [PD] Commons;
1914-2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – 1915, sbarco della 3ª brigata di fanteria australiana del contingente Australiano-Neozelandese (ANZAC). Dipinto di George Washington Lambert (1873–1930), Imperial War Museum.
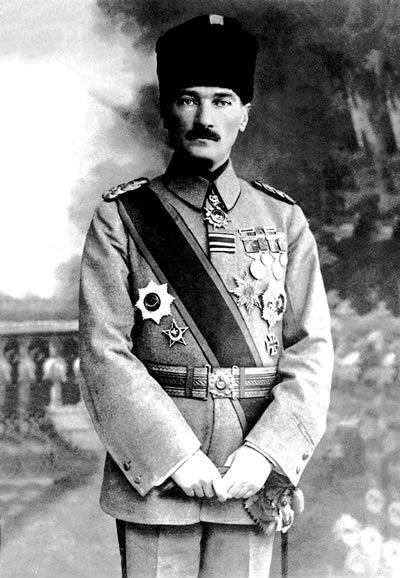
2 – Mustafa Kemal Atatürk, comandante dell’esercito ottomano.
– Abbiamo cartucce a palla?
– Si.
– Bene. Avanti.Dialogo tra Mustafa Kemal Atatürk e un soldato
alla notizia dell’arrivo degli inglesi.
Nell’estate del 1914 mentre il piano tedesco d’invasione della Francia s’impantanava e il tanto temuto rullo compressore russo si sbriciolava a Tannenberg, un altro impero era ad un bivio. Il grande malato d’Europa, com’era stato ribattezzato l’Impero Ottomano in evidente parabola discendente, era incerto sul da farsi diviso com’era dalla tradizionale alleanza con la Gran Bretagna e il timor panico di un’invasione russa per la conquista dello stretto dei Dardanelli. In tutto questo i tedeschi grazie alle abili mosse del loro ambasciatore, il barone Marschall Von Bieberstein, strinsero il 2 agosto 1914 un’alleanza segreta con il Gran Visir in funzione anti-russa. Il giorno dopo le prime mine anti-nave venivano posate nello stretto dei Dardanelli e iniziava la mobilitazione delle forze turche. L’entrata in guerra della Gran Bretagna contro la Germania però mise a forte repentaglio l’accordo tra tedeschi e turchi. La cosa ebbe un impatto talmente forte che l’Impero Ottomano, accantonando decenni di aggressioni al proprio territorio, arrivò al punto di offrire alla Russia un’alleanza: un’occasione d’oro per i russi di assicurarsi i rifornimenti dagli alleati.
[mapsmarker marker=”122″ basemapDefault=”googleTerrain” width=”100″ widthUnit=”%” height=”360″ panel=”false”] La penisola di Gallipoli e lo stretto dei Dardanelli
L’Impero dello Zar però ambiva da troppo tempo all’annessione dello stretto dei Dardanelli, e quindi al tanto agognato accesso al Mediterraneo, che rifiutò l’offerta senza neppure preoccuparsi di avvisare gli alleati francesi e britannici. Alla fine, complice l’iniziativa inglese di bloccare la consegna di due nuove corazzate alla Turchia (il che mandò su tutte le furie la popolazione, la quale aveva sottoscritto l’acquisto contribuendo anche privatamente) e la mossa tedesca di riparare le navi Goeben e Breslau presso i Dardanelli, la situazione iniziò a inclinarsi verso l’inevitabile. Tuttavia inglesi e turchi tentarono ancora diverse volte di conciliare la situazione[ref]Tanto che per timore di offendere i turchi gli inglesi non nominarono l’ammiraglio Limpus a capo della divisione inglese nei Dardanelli: Limpus era l’unico ammiraglio inglese ad avere una conoscenza approfondita della Turchia e dello Stretto.[/ref] ma alla fine i tedeschi forzarono la mano e insieme ad una squadra turca attaccarono la Russia varcando così il “Rubicone” diplomatico. Alla fine di Ottobre la guerra tra Triplice Intesa e Impero Ottomano (che entrava così nella Triplice Alleanza) fu ufficialmente dichiarata.
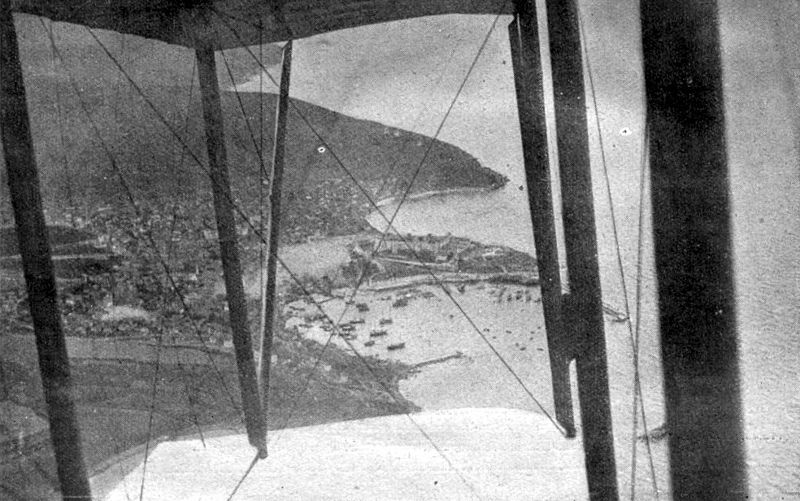
 3 e 4 – Il villaggio di Çanakkale, sulla sponda meridionale dello stretto dei Dardanelli, fotografato durante una ricognizione aerea francese nel 1915. Da The War Illustrated del 14 agosto 1915.
3 e 4 – Il villaggio di Çanakkale, sulla sponda meridionale dello stretto dei Dardanelli, fotografato durante una ricognizione aerea francese nel 1915. Da The War Illustrated del 14 agosto 1915.
Al momento della dichiarazione di guerra le difese turche nello Stretto erano antiquate e incomplete e un attacco immediato e congiunto di Russia e Gran Bretagna avrebbe avuto non poche possibilità di successo. I britannici tuttavia si limitarono ad un paio di incursioni e i turchi incredibilmente se la presero talmente comoda che solo a febbraio del 1915 fu dislocata una divisione nella penisola di Gallipoli, mentre a marzo del 1915 venivano completati i lavori di rafforzamento difensivo. Negli archivi dello Stato maggiore turco viene ammesso molto candidamente che «fino al 25 febbraio sarebbe stato possibile effettuare con successo uno sbarco in un punto qualsiasi della penisola, e la conquista dello Stretto da parte di forze terrestri sarebbe stata relativamente facile». L’ironia della sorte volle che la Triplice Intesa ebbe anche un’occasione nell’agosto del 1914 di occupare i Dardanelli senza inviare proprie truppe: la Grecia infatti aveva offerto tutte le proprie forze mettendole a disposizione dell’Intesa. Gli inglesi tuttavia ancora convinti di poter recuperare il rapporto coi turchi declinarono l’offerta per non offendere l’Impero Ottomano, che nei confronti della Grecia covava un odio insanabile. Solo un uomo in Inghilterra capì l’importanza di assicurarsi il controllo dello Stretto dei Dardanelli e provò in tutti i modi ad attirare l’attenzione sul problema: quell’uomo era il Primo Lord dell’Ammiragliato e si chiamava Winston Churchill. La tesi di Churchill viene avvalorata in un rapporto del 29 dicembre 1914 in cui il segretario del Consiglio di guerra inglese, tenente colonnello Maurice Hankey, sottolineava tutti i vantaggi di un attacco alla Turchia. C’era un problema però: la Francia era totalmente impegnata nel fronteggiare i tedeschi sul fronte occidentale, la Russia tentennava, Grecia e Romania si erano ritirate in disparte, l’Italia era indecisa e infine anche all’interno del comando inglese non vi era unità d’intenti. Il comandante del settore francese Sir John French si oppose a qualsiasi tentativo di distogliere truppe dal fronte occidentale e alla fine gli inglesi finirono col partorire un piano di solo attacco navale per la conquista dei Dardanelli e di Istanbul: come delle navi potessero conquistare da sole un pezzo di terra ferma rimane un mistero. Churchill, l’unico che sembrava avere davvero compreso l’importanza strategica dell’obiettivo, contattò i russi per convincerli ad appoggiare l’operazione. E qui i russi presero una decisione che equivalse ad un suicidio: temendo infatti che gli alleati potessero conquistare i Dardanelli, sottraendoli alla Russia, negarono ogni supporto alla coalizione franco-britannica. I russi preferirono rimanere isolati e senza possibilità di rifornimenti piuttosto che rinunciare all’antica ambizione sullo Stretto e gli inglesi quindi dovettero fare tutto da soli. Il piano inglese però ebbe dei problemi: Churchill lo considerava troppo limitato, altri temevano fosse troppo impegnativo; alla fine il piano approvato fu un compromesso tra le due visioni.
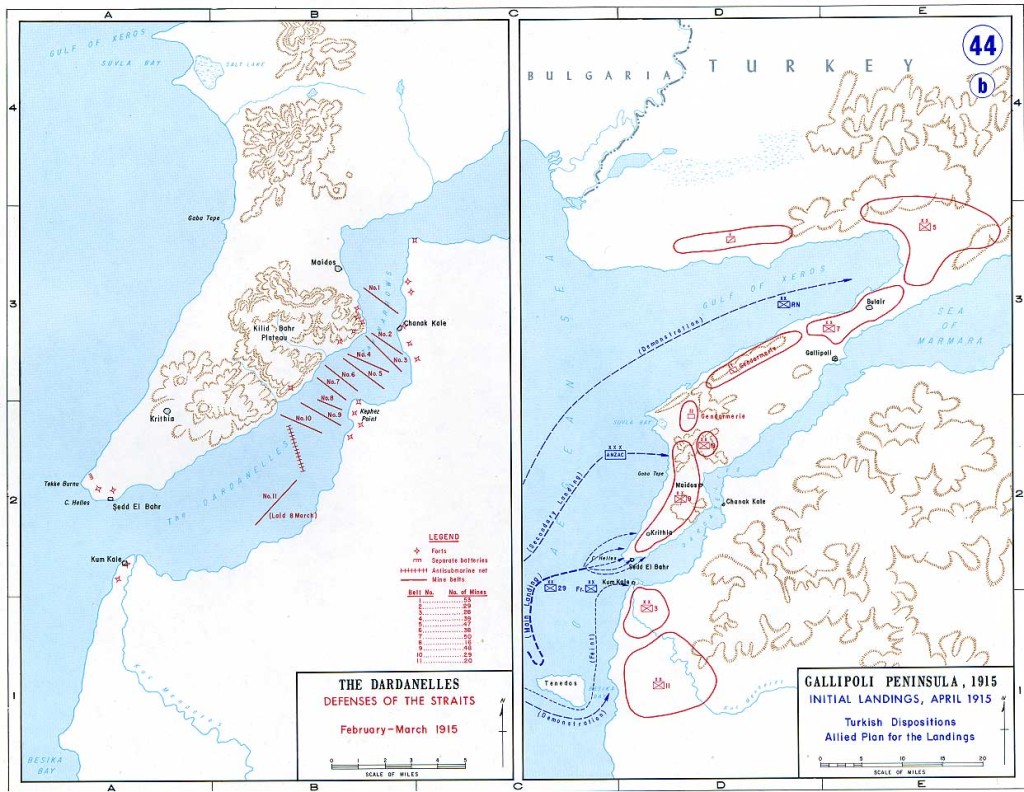
5 – Battaglia di Gallipoli: a sinistra lo schema delle difese ottomane, a destra il piano di attacco alleato (United States Military Academy – West Point).

6 – Ammiraglio Sin John De Robeck
Il 19 febbraio 1915 l’attacco navale ebbe inizio. L’offensiva ebbe abbastanza successo ma poiché degli sbarramenti di mine provocarono affondamenti, nella flotta britannica subito si diffuse il pessimismo tanto che l’ammiraglio De Robeck ordinò una ritirata immediata e non continuò nell’attacco. De Robeck ignorava però che il nemico fosse ancora più demoralizzato e che difficilmente avrebbe resistito ad una nuova offensiva navale se solo fosse stata tentata. Il 23 marzo De Robeck inviò un telegramma per informare l’Ammiragliato che senza forze terrestri era impossibile forzare il passaggio navale dei Dardanelli. Churchill si oppose a questa tesi ma rimase isolato. La marina britannica, di fatto riparandosi dietro l’opinione di De Robeck, scaricava il peso delle operazioni e delle responsabilità sull’esercito. Per conto dell’esercito in Turchia fu inviato Ian Hamilton[ref]Lo stesso che assistette al famoso “schiaffo” tra i generali russi.[/ref] come capo delle operazioni.
Appena arrivato vedendo l’inadeguatezza del fronte inglese non poté fare altro che decidere di riorganizzare il tutto nel porto di Alessandria d’Egitto; le operazioni tuttavia si svolsero in modo del tutto disorganizzato e caotico. Anziché preparare lo sbarco in maniera meticolosa e in stretta collaborazione tra esercito e marina, gli inglesi lasciarono il campo alla confusione strategica e alla diversità di vedute dei vari militari; a nulla valse il memorandum di Maurice Hankey, presentato al governo britannico, che poneva l’attenzione su come fosse fondamentale valutare attentamente ogni dettaglio dell’operazione per scongiurare un grave disastro. Eppure quando il 25 aprile 1915 lo sbarco iniziò gli inglesi avevano ancora possibilità di vittoria più per demerito degli avversari che per meriti propri, considerando infatti che le forze in campo equivalevano a 75.000 uomini contro 84.000 ottomani.

7 – Sbarco del 4º Battaglione 1ª Brigata ANZAC (Australia-Nuova Zelanda) alle 8 di mattina del 25 aprile 1915 sulla spiaggia che prese il nome di Anzac Cove.
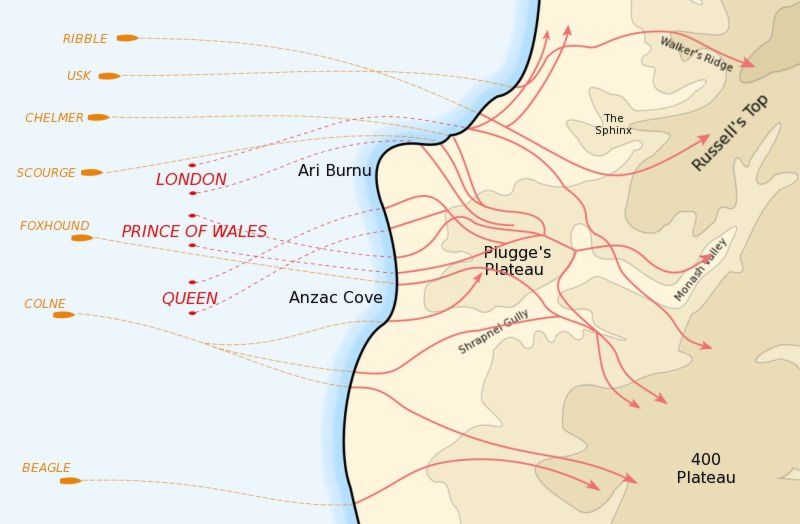
8 – Sbarco delle forze di copertura (3ª Brigata, 1ª Divisione ANZAC) a nord di Gaba Tebe, il 25 aprile 1915.
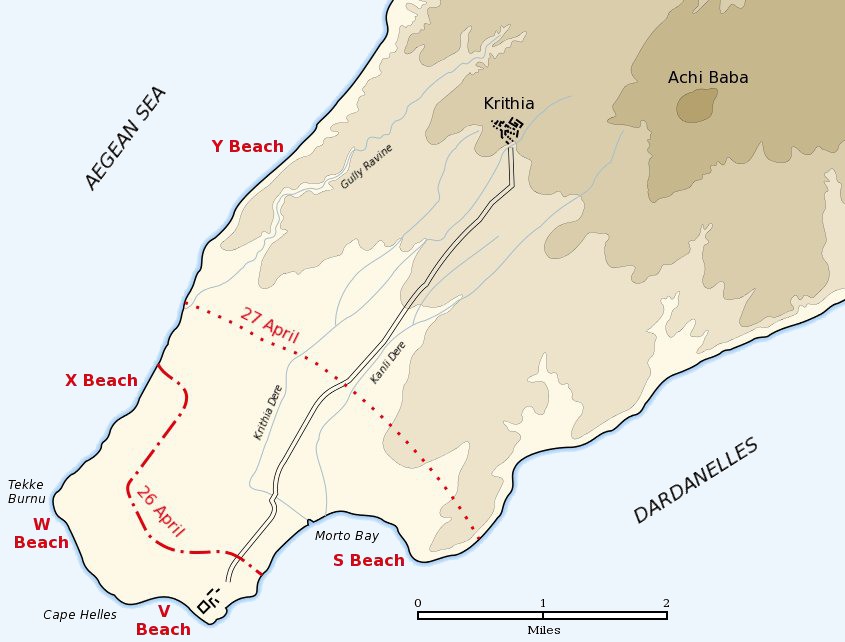
9 – Schema della sbarco della 29ª Divisione britannica a Capo Helles, l’estrema punta della Penisola di Gallipoli, il 25 aprile 1915 con la suddivisione delle spiagge (S, V, W, X, Y) e le posizioni raggiunte al 26 e 27 aprile.
In estrema sintesi ecco cosa accadde durante quello che è passato alla storia come il famigerato Sbarco di Gallipoli:
- la riorganizzazione palese delle forze britanniche in Egitto annullò qualsiasi effetto “sorpresa”.
- il 25 marzo Liman Von Sanders, a capo della delegazione militare tedesca presso i turchi, vedendo lo stato delle difese si augurava che i britannici lo lasciassero in pace per almeno otto giorni… questi, bontà loro, gli concessero quattro settimane di pausa.
- il principale attacco britannico fu concentrato sulle spiagge V e W in cui i turchi grazie alla conformazione del terreno organizzarono una vera e propria sanguinosa trappola; le altre spiagge come la X e la S colsero invece totalmente di sorpresa i difensori. Nel caso della spiaggia S gli inglesi sbarcarono facilmente ma poiché gli ordini erano di aspettare l’avanzata dalle altre spiagge rimasero lì inerti. Le forze inglesi sbarcate su X e S erano quattro volte superiori ai difensori turchi delle spiagge V e W.
- fallito il tentativo di sbarcare sulla spiaggia V gli inglesi spostarono due battaglioni sulla spiaggia W riuscendo finalmente a impadronirsene del tutto. Anche in questo caso però occupata la spiaggia i britannici si fermarono. In quel momento avevano una superiorità numerica di sei contro uno sui turchi.
- sulla spiaggia Y i britannici sbarcarono senza il minimo incidente e senza incontrare resistenza. Per ben 11 ore il nemico li lasciò indisturbati ma gli inglesi non si preoccuparono di sfruttare l’occasione rimanendo in attesa di ulteriori ordini.
- proprio sulla spiaggia Y alla fine i turchi tentarono una seria di contrattacchi notturni puntualmente respinti. Tuttavia queste azioni seminarono il panico tanto che furono mandati messaggi allarmistici e molti soldati si precipitarono sulle barche di soccorso dei feriti. Alla fine la confusione fece sì che l’intero contingente si reimbarcò senza motivo.
- sulle spiagge di Gaba Tepe dove sbarcò il corpo di spedizione australiano e neozelandese (ANZAC) l’occasione favorevole fu vanificata dalla coraggiosa iniziativa dell’allora sconosciuto Mustafà Kemal (foto 2), che in seguito guidò la nascita della Turchia dalle ceneri del’Impero Ottomano ed è tuttora considerato l’eroe nazionale turco.
- disorientati dai molteplici punti di sbarco i turchi non avevano ancora compreso dove gli inglesi intendessero attaccare in forze. Alla fine i turchi caddero nel bluff concentrando gli sforzo a Bulair proprio come Hamilton voleva far loro credere. I britannici tuttavia, in preda al pessimismo e alla stanchezza, non sfruttarono l’occasione.
- ai primi di maggio i turchi lanciarono massicci attacchi frontali inutilmente. I britannici pensarono bene, tre giorni dopo, di ricambiare il favore lanciandosi a loro volta in un sanguinoso e inutile attacco frontale, riuscendo a perdere un terzo degli effettivi.
- per sbloccare una situazione che era andata in stallo a luglio le forze di Sua Maestà inviarono altre cinque divisioni, in aggiunta alle sette già presenti, ma ormai anche i turchi avevano dispiegato 15 divisioni sul fronte; Hamilton ancora una volta prese di sorpresa i turchi con un attacco il 6 agosto, sia a Gaba Tepe sia nella baia di Suvla, ma l’inesperienza delle truppe e sempre l’inerzia e l’incapacità dei comandanti fecero svanire l’ennesima occasione favorevole.

10 – Soldati della fanteria di marina britannica (British Royal Naval Division) escono dalle trincee a Capo Helles.

11 – Il Generale Sir Ian Hamilton
Ian Hamilton ebbe un compito arduo e arrivò molto vicino al successo nonostante le risorse e i mezzi di cui disponeva. Hamilton si pronunciò a favore della continuazione dell’offensiva ma fu sostituito da Sir Charles Monro che in una sola mattinata visitò le teste di ponte senza spingersi oltre la spiaggia, mentre il suo capo di stato maggiore a bordo di una nave stilò il rapporto in cui Monro raccomandava una completa evacuazione. Churchill a tal proposito commentò lapidario: «Venne, vide, capitolò». Il governo britannico aveva ormai deciso per l’evacuazione e per una strana ironia fu la marina che tentò di impedirla. L’ammiraglio De Robeck era stato infatti sostituito dall’ammiraglio Wemyss, che non solo era contrario allo sgombero ma si offrì di appoggiare l’offensiva con rinnovato vigore; ma la sua offerta giunse ormai troppo tardi. Iniziata il 18 dicembre 1915, l’evacuazione terminò l’8 gennaio 1916 con perfetta organizzazione e cooperazione, in totale antitesi con quanto accaduto durante l’offensiva. Pur non avendo nulla a che fare con l’organizzazione dell’evacuazione, Monro e il suo capo di stato maggiore grazie al successo dell’operazione furono insigniti di decorazioni.
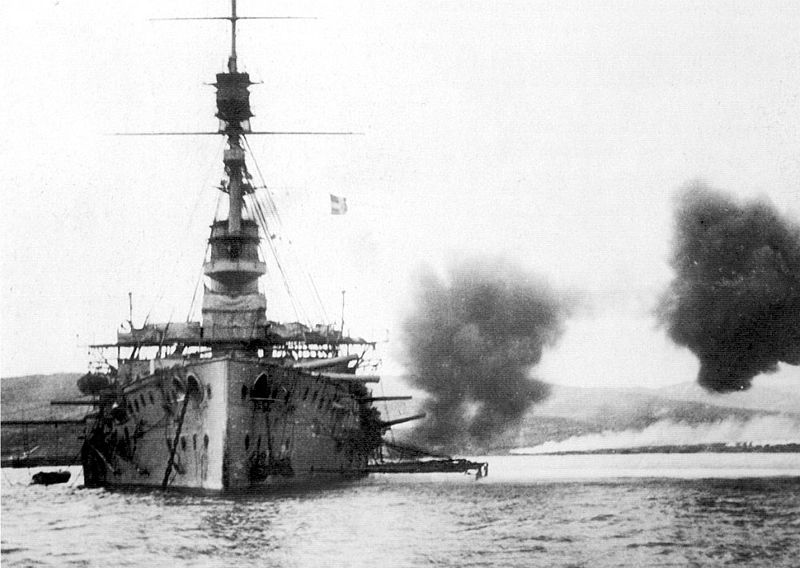
12 – La corazzata britannica HMS Cornwall apre il fuoco contro i turchi a Suvla per coprire l’evacuazione delle truppe nel dicembre 1915.
Fu così che per una serie di errori e di contrasti interni un piano lungimirante e di notevole rilevanza strategica fu vanificato. Il suo ideatore Winston Churchill fu additato in un primo momento come unico responsabile del fallimento ed estromesso dal governo; Churchill decise quindi di andare a combattere in Francia come maggiore nell’esercito per poi essere richiamato al governo come Ministro delle munizioni. Durante la seconda guerra mondiale, mentre Churchill cercava di convincere l’alleato americano della necessità di uno sbarco in Sicilia, non pochi generali americani erano in disaccordo ricordando come egli fosse l’uomo del fallimento di Gallipoli. Churchill non contribuì alla Grande Guerra solo con il piano dello sbarco nei Dardanelli; fu infatti il principale sostenitore del carro armato, che insieme a tanti altre armi fece il suo debutto proprio nel primo conflitto mondiale. Oltre al carro armato infatti presero parte alla battaglia l’aviazione, le armi chimiche, i sottomarini, le spie e la propaganda.
La Grande Guerra si era ormai estesa non solo geograficamente tra le nazioni ma anche ad ogni aspetto della vita. Lo sforzo bellico raggiunse una tale intensità che ogni risorsa o opportunità offerta dalle circostanze veniva impiegata dalle forze belligeranti senza più molti scrupoli facendo proprio il famoso proverbio francese: «à la guerre comme à la guerre».[ref]Stando alla Treccani il detto vuole significare che ogni situazione va accettata per ciò che essa è, e che bisogna contentarsi delle risorse che sono offerte dalle circostanze[/ref] [endmark]
Note
[references class=”compact” /]
Bibliografia
- Liddell Hart, sir Basil Henry La prima guerra mondiale. 1914-1918
Milano: RCS Libri, 1999.
- Rocca, Gianni. L’Italia invasa (1943-1945)
. 1ª ed. Milano: Mondadori, 1999.
Immagini
- George Washington Lambert, olio su tela 1920–1922. [PD] IWM/Commons;
- [PD] Presidency of Republick of Turkey/Commons;
- [PD] da The War Illustrated del 14 agosto 1915. Commons;
- [PD] da The War Illustrated del 14 agosto 1915. Commons;
- United States Military Academy West Point [PD] USMA/Commons;
- American Press Association 1915 [PD] da The New York Times Current History: The European War (April–June 1915). Volume 3. p. 488. Commons;
- Anzac Cove, 25 aprile 1915 [PD] Australian War Memorial/Commons;
- [PD] Commons – mappa basata su “Volume I – The Story of ANZAC from the outbreak of war to the end of the first phase of the Gallipoli Campaign, May 4, 1915” in Bean, C. E. W., Henry Gullett, Arthur W. Jose, F. M. Cutlack, S. S. Mackenzie, Ernest Scott. Official history of Australia in the war of 1914-18.
1920. 11ª edizione. Sydney: Angus & Robertson, 1941. Pag. 256. Consultabile online su Australian War Memorial;
- [PD] Commons;
- Ernest Brooks, 25 aprile 1915 [PD] da The War Illustrated del 15 luglio 1915. Imperial War Museum/Commons.
- Bain News Service, 1910-1915 c.a [PD] Commons/Library of Congress (LC-DIG-ggbain-18025);
- Ernest Brooks, dicembre 1915 [PD] Imperial War Museum (Q 13682)/Commons;
Passa, come un malaugurato uccello notturno, sulla città e sulla campagna, e i vetri tremano al suo rombo sinistro, e gli uomini chiusi nelle case o nelle fattorie lo seguono con il pensiero mentre si avvicina, vola sopra la casa, si allontana… Il Popolo Vicentino, 23 febbraio 1945, pagina 2.
Il Pippo è esistito perché molti l’han sentito. Io l’ho sentito a Milano e a Novara. Nessuno l’ha visto perché viaggiava di notte, ma sentire l’han sentito.[ref name=”333″]Archivio Cesare Bermani, nastro 333: testimonianza orale di Mario Bermani, ingegnere, nato a Novara nel 1908, registrata a Novara il 17 settembre 1998. Da Bermani (op. cit.)[/ref] M. Bermani, ingegnere
Come se non bastasse la seconda guerra mondiale, con il suo carico di povertà, terrore e morte, dal 1943 fino alla liberazione l’Italia settentrionale (in particolare la “Po Valley”, come gli Alleati chiamavano la Pianura Padana) fu insidiata da un oscuro fantasma. Era conosciuto come Pippo (ma anche “Peppino” a Genova, “Tito” nel Veneto, “il notturno” in Toscana, “l’orfanello” in Umbria[ref name=”colombara”]Colombara, F. in Patria (op. cit.)[/ref]), i piloti americani di stanza in Italia lo chiamavano “Bed-Cheeck Charlie”[backref name=”colombara” /] e le sue apparizioni si spinsero talvolta fino al centro Italia, dove si registrano testimonianze del suo passaggio. Apparizioni per modo di dire, perché -si racconta- nessuno l’ha mai visto: Pippo si manifestava dopo il calar del sole e l’unico segno della sua presenza era il sinistro ronzio di un motore d’aeroplano nel buio. Del resto, che Pippo fosse un velivolo in metallo e rivetti, nessuno lo metteva in dubbio, né tantomeno egli stesso si fece mancare di ricordare alla gente la propria natura fisica e tangibile, sganciando di tanto in tanto il proprio carico di bombe qualora la popolazione avesse dato segno di sottovalutarne il pericolo. Spesso invece si limitava a far sentire la propria incombente presenza nel silenzio del coprifuoco notturno e questo “tacere” delle armi non faceva che alimentare l’alone di mistero circa la natura ed i reali scopi dell’oscura entità. Si diceva che sparasse alla vista di ogni benché piccola luce, e così al primo accenno di un rumore in lontananza si correva a chiudere tutte le porte e le finestre, si metteva la lucerna sotto al tavolo:[ref name=”angelo”]Racconti di mio padre Angelo Dell’Acqua, classe 1936, che ha trascorso l’infanzia nella zona di Bereguardo (PV). All’epoca di Pippo aveva tra i 7 ed i 9 anni.[/ref] mai uscire di casa, perché il tenue spiraglio di luce che fuoriusciva dalla porta socchiusa sarebbe bastato a provocare le ire del Pippo.
«Tutti lo conoscevano come Pippo; quando si sentiva Pippo tutti dicevano: “Niente luci, niente luci!” Sì, proprio, che è rimasto molto impresso questo Pippo, perché tutti avevano paura. Per esempio, c’erano tutte le tende chiuse e tutto perché non filtrasse ma se, fatalità, dovevi aprire la porta per uscire, faceva il fascio di luce e magari lui passava, sganciava!»
Ines M. di Venezia[ref]Ines Montemazzani di Venezia, riportato da Colombara, F. in “Patria”, 10-2012 pag.27 (op. cit.)[/ref]
Addirittura non si fumava perché, si diceva allora, Pippo era dotato di speciali lenti che gli consentivano di cogliere anche il bagliore della sigaretta.[backref name=”angelo” /] Se andava bene, si rischiava una mitragliata, se andava male, una bomba:
«Ma se lui vedeva un fiammifero o una candela accesa buttava una bomba. Dalle nostre parti c’era una famiglia che di notte è andata con una candela nel pollaio. Stavano ritornando in casa con una candela accesa e lui ha buttato una bomba. Ha ammazzato un padre e un figlio, complessivamente quattro o cinque. Serviva a tenere sotto spavento le persone, a tenerle con i nervi tesi, il Pippo».
Luigi G. di Curtatone (Mantova)[ref]Luigi Gavioli di Curtatone, riportato in Bermani, pp. 244-245 (op. cit.)[/ref]
«Passava sempre alla solita ora, otto e mezzo o nove di sera, e se vedeva la luce, anche solo una sigaretta, o qualcosa di bianco, lui buttava giù gli spezzoni»[ref name=”spezzoni”]Gli “spezzoni” erano un tipo di bomba incendiaria a basso costo e di facile produzione, costituita da un pezzo di tubo metallico riempito di esplosivo e materiale infiammabile[/ref]
Anna T. di Serravale Po (Mantova)[ref name=”colombara-27″]Anna Tamassia di Serravalle Po, riportata da Colombara, F. in Patria pag. 27 (op. cit.)[/ref]
Che un aereo in volo potesse effettivamente scorgere la luce di una candela o di una sigaretta a terra appare quantomeno improbabile, ma riflette lo stato di terrore della popolazione al passaggio del misterioso aeroplano e le proporzioni leggendarie assunte dalla figura di quest’ultimo. Certo è che fosse tutt’altro che innocuo, come sperimentò chi ebbe l’imprudenza di lasciare le luci accese: sebbene alcune testimonianze riferiscano di “bombette” dimostrative[ref name=”quaroni”]geom. Luigi Quaroni di Pavia 15/04/2013. Testimonianza orale raccolta dall’autore.[/ref][ref name=borrini]Archivio Cesare Bermani, nastro 338, testimonianza orale di Geo Borrini, ingegnere, nato a Novara nel 1911, registrata a Stresa il 03/10/1998. Bermani, p. 236 (op. cit.)[/ref] o “spezzoni” incendiari,[backref name=”spezzoni” /] città come Milano hanno vissuto una realtà ben più tragica:
«E quindi noi quando abbiamo scoperto questo Pippo, che veniva a mitragliare dentro le case, attraverso le finestre… perché ha mitragliato in diverse case […] Quindi quando arrivava questo Pippo, con l’idea di mitragliare e lo faceva, io mi mettevo contro la culla, con le braccia a croce, in modo che dico: se Pippo mitraglia, mitraglia me e non il bambino.»
Maria S. di Milano[ref]Maria Salvi di Milano, archivo Bermani, nastro 204. Dalla trasmissione radiofonica La notte dei misteri, RAI Radio 3 del 11/01/1997[/ref]

2 – Soldati tedeschi in marcia presso Milano, 1944.
Ovviamente tutto questo era una spina nel fianco della Repubblica Sociale Italiana[ref name=”rsi”]La repubblica Sociale Italiana, detta anche informalmente “Repubblica di Salò”, era lo stato-fantoccio fascista che controllava l’Italia centro-settentrionale sotto l’egida della Germania nazista dopo che il Regno d’Italia aveva concluso il 3 settembre 1943 l’armistizio di Cassibile con le forze anglo-americane.[/ref] e degli stessi nazisti, dato che le sue incursioni tenevano sotto pressione le forze dell’Asse ed innervosivano la popolazione minando il già esiguo consenso nei confronti degli occupanti. La stampa fascista, pertanto, non ne parlava volentieri e se proprio era necessario si riferiva a Pippo come ad un singolo aereo sfuggito alla fitta maglia della contraerea, passando periodicamente notizie del suo abbattimento: «Campane a morto per Pippo! La fine del molestatore volante!» titola ad esempio Il Piccolo di Trieste del 16 settembre 1944. Ma ogni volta che la propaganda repubblichina ne annunciava con orgoglio l’abbattimento, vero o falso che fosse, Pippo ricompariva beffardo e puntuale la sera stessa, riuscendo ad essere anche in più posti contemporaneamente:
«…puntuale come ogni sera ci veniva a trovare un aereo chiamato Pippo ed era un mistero perché era da ogni parte, non si è mai capito questo mistero, so solo che dove vedeva una lucina sganciava bombe.»
Irene P. di Reggio Emilia.[ref]Irene Perlini di Reggio Emilia, riportata da Colombara, F. in Patria pag.27 (op. cit.)[/ref]
Evidentemente la possibilità che potessero essere più d’uno non veniva nemmeno presa in considerazione, come se l’aura mitica che lo avvolgeva non lasciasse spazio ad un secondo o un terzo Pippo. Tant’è vero che quando raramente si verificava un secondo passaggio nella stessa notte, il secondo era “Pierino”[backref name=”colombara” /][ref]Bermani, pp. 250-251 (op. cit.)[/ref] perché per la gente Pippo era uno solo e passava una sola volta. Il silenzio delle autorità di Salò e l’assoluta mancanza di informazioni dall’altra Italia, quella del Sud già controllata dagli Alleati, lasciava alle congetture stabilire da quale parte provenisse Pippo. Ma per i più restava un mistero, un identità indefinita: chi era Pippo secondo la gente, un aereo americano, inglese, tedesco? O addirittura italiano? «Era Pippo»[backref name=”quaroni”] è la risposta più comune:[ref]C. Bermani (op. cit.)[/ref]
«Nessuno ha mai capito se era un aereo nemico o un aereo che andava in ricognizione, se era un aereo tedesco o americano o italiano. Era Pippo. Non lo si vedeva perché era di notte, ma lo si sentiva […] Però questo Pippo non si è mai saputo chi fosse.»
Flavia T. di Novara[ref]Testimonianza orale di Flavia Tosi, nata a Novara nel 1922, già ostetrica ed ex partigiana matteottina, registrata ad Orta S.Giulio, 16/07/1995. Archivio Cesare Bermani, nastro 834. Da Bermani p.235 (op. cit.)[/ref]
«Chissà, forse era mandato in giro per vedere se c’erano le luci accese, però qualcuno dice che se c’erano le luci accese mitragliava. Ma cosa venisse a fare non si è mai saputo, e neanche di che nazionalità fosse. Poteva essere inglese ma anche tedesco.»
M. Bermani, ingegnere[backref name=”333″]
«Quando passava Pippo, questo aeroplano non si sa se tedesco, italiano o alleato, tutti si chiudevano dentro casa e spegnevano le luci»
Martino D. di Signoressa di Trevignano (TV)[ref]Martino De Lazzari di Signoressa di Trevignano, ricerca di Luigi di Noia e Rossana Cillo. Da Bermani, p. 251 (op. cit.)[/ref]
Potrebbe sembrare logico attribuire a Pippo provenienza angloamericana, dato che conduceva i propri attacchi in un territorio di fatto controllato dai nazisti, come in effetti conclusero molti testimoni[backref name=”colombara” /] «con un’ambivalenza di sentimenti, perché gli americani che bombardavano non piacevano a nessuno, non erano tanto amici.»[ref]Archivio Cesare Bermani, nastro 180: testimonianza di Vanni Oliva, nato a Milano nel 1932 (insegnante di lettere), raccolta a Suna il 27/05/1996. Da Bermani, p. 236 (op. cit.)[/ref] Ma all’epoca, tale ipotesi era tutt’altro che scontata: per molti altri infatti era inaccettabile che gli Alleati, i “liberatori”, potessero sparare sulla gente inerme. Per molti di coloro che vivevano il dramma dell’occupazione sulla propria pelle era meno difficile credere i nazifascisti responsabili di simili nefandezze, anche se contrario alla logica. Del resto la sua apparente ossessione per le luci poteva suggerire che il suo scopo fosse il controllo del coprifuoco, e ciò avvalorava la tesi di un velivolo tedesco:
«Guai la luce. Buttava giù la bomba per fare spavento. Era un aereo tedesco»
Lucia di Casalbuttano (Cremona)[backref name=”colombara-27″ /]
I più arguti arrivarono ad ipotizzare che le incursioni di Pippo fossero un piano dell’Asse per terrorizzare la popolazione e riversare la colpa sugli angloamericani.[ref]Padre Martino Marosci, monaco benedettino presso il Monastero di San Giovanni Evangelista (Parma) in «Bombe di Pippo su San Giovanni», Gazzetta di Parma, 5 giugno 2000. Riportato in Bermani, p. 240 (op. cit.)[/ref] Sicuramente la propaganda fascista non si lasciò scappare questa opportunità di infangare il nemico; la stampa di regime attribuiva infatti a Pippo paternità badogliana:[ref]Coccarde Tricolori, supplemento del Giornale dell’Aviatore. Da Bermani (op. cit.).[/ref] niente di peggio di un aereo italiano pilotato da italiani passati con il nemico, traditori quindi capaci di indicibili bassezze come lanciare penne stilografiche esplosive, dolciumi avvelenati, palloncini all’iprite ed altri subdoli ordigni per colpire i bambini (si vedano articoli come «Il barbaro nemico» in La Domenica del Corriere del 16 maggio 1943, p. 3 e «Pippo» in Il Popolo Vicentino del 23 febbraio 1945, p.2).[ref]Bermani, pp. 231-232 (op. cit.)[/ref] Ma tale campagna di terrorismo psicologico contrastava con le testimonianze di chi, anziché palloncini all’iprite, si vide lanciare invece viveri e denaro,[ref]Bermani, p. 252 (op. cit.)[/ref] probabilmente destinati a supportare i partigiani ma che alimentarono l’idea che Pippo fosse un aereo “amico”.[ref]A sganciare viveri e denaro non era il “Pippo” propriamente detto, quello che bombardava, ma un aereo preposto a tale scopo (v. Bermani, op. cit. p. 257). Per la gente, però, tutti gli aerei solitari erano “Pippo”.[/ref] Le “voci di popolo” dicevano che si trattasse di «un soldato italiano passato con gli alleati»,[ref]Archivio Cesare Bermani, nastro 337: testimonianza orale di Franco Pareschi, nato a Galliera nel 1928, registrata a Galliera il 30/09/1998. Bermani, p. 236 (cit.)[/ref] a Forlì si diceva che fosse un romagnolo, forse addirittura un forlivese.[ref]Mambelli, Antonio. Diario degli avvenimenti di Forlì ed in parte di Romagna dal 1939 al 1945, diario inedito conservato presso la Biblioteca Comunale di Forlì, vol.III p. 10, cit. in Perry, Alan R. “Era il nostro terrore: Indagine sul mito di Pippo” in Italia Contemporanea n°225, dicembre 2001, p. 554. Bermani, p.242 (op. cit.)[/ref] A poco a poco si fece strada un’ipotesi ancor più fantastica, quella dell’aviatore solitario, né tedesco né angloamericano, che portava avanti chissà quale personale missione:
«Dicevano che fosse un tipo un po’ strano antitedesco e antifascista che voleva fare del casino. […] Lo si sentiva ronzare e ronzare, ed era un aereo che faceva sì e no centoventi-centocinquanta chilometri all’ora. Quindi non poteva essere un caccia ma poteva essere un Piper, cioè un aereo da piccolo turismo che poteva servire anche da ricognizione. […] Comunque Pippo è sempre stato un mistero»
G. Borrini di Novara, ingegnere[backref name=”borrini” /]
Ad una figura che sembra richiamare al mito futurista delle incursioni dannunziane (1917-1918) tanto esaltate durante il ventennio, si adatta meglio l’immagine di un velivolo piccolo e sfuggente, forse un Piper,[ref]Piper L-4 “Grasshopper”: era la versione militare, da ricognizione e collegamento, del famoso velivolo leggero.[/ref] uno Storch[ref name=”storch”]Il Fieseler Fi 156 “Storch” (“cigogna”).[/ref] o addirittura un poetico biplano dalla cabina aperta alla Antoine de Saint-Exupéry:
«Pippo dai racconti di mia madre, lo immagino come un pilota che vola su un aereo di quelli aperti, quindi con la testa fuori, gli occhiali, casco e la sciarpetta svolazzante. È un amico, è buono. Naturalmente si deve spegnere la luce e fare tutto quello che si deve fare per non essere bombardati. Ma fatto questo, si può uscire senza pericolo dal rifugio antiaereo a vedere questo aereo solitario che passa di notte. È insomma come se Pippo avvertisse dei pericoli. Non ha mai bombardato.»
Margherita P. di Novara[ref]Margerita Podestà, nata a Novara nel 1954, registrata ad Orta S.Giulio il 19/07/1995 da Bermani, p. 236 (op. cit.)[/ref]

3 – Alcuni testimoni identificarono Pippo nel Fieseler Fi 156 “Storch”(foto), secondo altri poteva trattarsi invece di un Piper L-4 “Grasshoppher”.
Soprattutto nelle zone rurali, più raramente colpite dalle bombe notturne, Pippo divenne così un’istituzione, una presenza benevola per quanto nessuno si azzardasse a sfidarla accendendo una lanterna. Pippo fu annunciatore di pericoli, un aereo “buono” che cercava di limitare le vittime dei bombardamenti dando la possibilità di mettersi al riparo, guadagnandosi così il soprannome di “Pippetto l’Annunciatore” (in Toscana[ref name=”bermani256″]Bermani, p. 256 (op. cit.)[/ref]) immagine forse suggerita da occasionali testimonianze dell’arrivo di “veri” bombardieri dopo il suo passaggio.[backref name=”bermani256″ /] Una figura che si prestava a rielaborazioni fantastiche, come nel racconto di un testimone di Guastalla a cui l’aviatore, dall’abitacolo aperto dell’aereo, avrebbe urlato di correre a nascondersi, naturalmente nel dialetto locale: «state logheti!»[backref name=”colombara” /] – nascondetevi! Quello emiliano non fu un caso isolato, e racconti simili (sebbene non frequenti) si udirono anche in altri luoghi, ad esempio nei racconti di una donna di Matera che non vide il pilota ma udì gli avvertimenti dell’aeroplano: «Nascondetevi, nascondetevi che qui si bombarda, nascondetevi, nascondetevi che si muore, si muore».[backref name=”colombara” /] In altre testimonianze la “voce” di Pippo si manifestava nella forma di lanci di volantini[ref]Ancora, forse, una reminescenza dannunziana?[/ref] che avvisavano la popolazione di un imminente bombardamento.[ref name=”bermani238″]Bermani, p. 238 (op. cit.)[/ref] Pippo era entrato di diritto nel folklore: pilota e macchina finirono per fondersi in una creatura mitica, un centauro metà uomo metà aeroplano. Alla gente piaceva immaginarlo così e lo stesso nomignolo, “Pippo”, aiutava ad esorcizzare la paura della guerra, così come il rito scaramantico di nascondere ogni luce per non “attirare” le bombe. La sua presenza oscura e misteriosa, spaventosa ma in fondo simpatica, finì per sostituirsi in tempo di guerra a quella del “babau” o dell’uomo nero, mostro indefinito invocato per spaventare i bambini e convincerli, se non a dormire, perlomeno ad acquietarsi. La frase di rito diventava così «guarda che se non spegni la luce arriva Pippo!»[backref name=”colombara” /] ed all’aereo furono dedicate anche numerose filastrocche:
A mezzanotte in punto passava un aeroplano
e sotto c’era scritto “Pirulin Pirulin stai zitto!”[ref]Bermani, p.247 (op. cit.)[/ref]
La memoria del fantasma notturno sopravvisse nel nome di un prodotto per la pulizia della della casa, i cui spot pubblicitari[ref]Spot della scopa “Pippo”, anni ’90, con l’attrice Monica Scattini: video. Promozione durante il programma TV “Luna di Miele”: video.[/ref] divennero un’icona della cultura televisiva italiana degli anni ’80 e ’90: “Pippo la scopa”, così chiamata da Filippo Salviato, fondatore dell’azienda veneta che la produceva, in ricordo «dell’aereo incursore tedesco (sic) che in tempo di guerra sorvolava l’alta Italia».[ref]Focus Storia (op. cit.)[/ref]
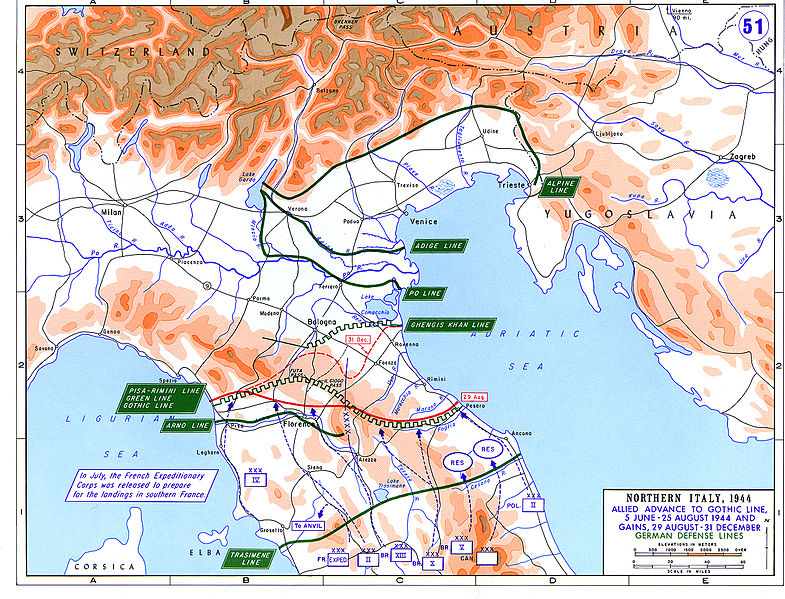
4 – L’italia settentrionale nel 1944 (West Point U.S. Military Academy).
Chi (o cosa) era davvero Pippo
Finita la guerra, Pippo scomparve, rimanendo un mistero nella memoria di molti di coloro che la notte ne ascoltavano con apprensione il passaggio: chi sopravvisse al conflitto aveva ben altri fantasmi con cui imparare a convivere e del misterioso aeroplano sembrano essere rimasti solo aneddoti folkloristici di scarso interesse per un paese che ormai pensava alla ricostruzione. Pippo sarebbe rimasto un mistero, a poco a poco dimenticato o confuso con la leggenda e forse si sarebbe anche dubitato della sua esistenza; sennonché la burocrazia militare è un setaccio troppo fine anche per un fantasma, che vi aveva infatti lasciato chiare tracce: Pippo è esistito, ed era britannico. Il nome ufficiale dell’operazione era “night intruder” (intruso notturno) e la responsabilità delle missioni era del Bomber Command della Royal Air Force, che disponeva di tre squadriglie ad hoc: la 225ª, 226ª e 600ª. Nell’ottica di uno sforzo militare congiunto, anche l’aviazione statunitense mise a disposizione tre squadroni, il 414º, 415º e 416º sicché la missione era britannica ma il velivolo poteva essere americano. Lo scopo era di effettuare continue azioni notturne di disturbo oltre le linee nemiche: una strategia messa in atto anche sul fronte dell’Europa nordoccidentale (dove furono impiegati anche aerei canadesi -vedi f.1).

5 – Monte Maggio, 26 agosto 1945: il primo ministro britannico Winston Churchill, al centro, discute la situazione bellica in Italia con il comandante dell’ottava armata, il generale di corpo d’armata Sir Oliver Leese (a sinistra) ed il Supremo Comandante Alleato per il Mediterraneo, il generale Sir Harold Alexander.
Qualcuno lo vide anche, il “Pippo”, dato che iniziava i propri sorvoli all’imbrunire quando c’era ancora abbastanza luce, ma alla maggior parte delle persone bastava il rumore del motore per correre a nascondersi. Tra i pochi che lo videro, non molti avevano le conoscenze necessarie a formulare ipotesi sul tipo di aereo anche se qualcuno, magari un po’ più esperto, ipotizzò che fosse un monomotore, come lo Storch.[backref name=”innamorati” /][backref name=”storch” /] Volare per ore in notturna sopra il territorio nemico trasportando bombe non era però un compito assolvibile da un piccolo ricognitore. Nel ruolo del “Pippo” furono invece impiegati aerei ben più pesanti: uno dei primi fu il caccia pesante Bristol Type 156 Beaufighter -detto “il Beau”- presto affiancato dal più moderno De Havilland DH-98 Mosquito, un efficiente caccia bombardiere multiruolo dalla struttura in legno; caratteristica questa che gli fruttò il poco rispettoso soprannome di “Termite’s Dream”, il sogno delle termiti.[ref]Goebels, Greg. “[2.0] Mosquito In Service / Foreign Users.” AirVectors. Web. 07-7-2013.[/ref]

6 – Un caccia pesante Bristol Type 156 “Beaufighter” della Royal Air Forces: uno dei primi “Pippo”.

7 – Un caccia bombardiere de Havilland Mosquito B.XVI della Royal Air Force.
Oltre a questi due, è riportato l’impiego in missioni “Night Intruder” di almeno altri quattro modelli di aereo:[ref name=”consandolo”]Secondo la rivista Aerei nella storia, come riportato da Chiarini, G. in “Pippo“, Consandolo. Associazione Ricerche Storiche Consandolo, Argenta (FE). Consultato il 26-3-2014.[/ref] il Douglas A-20 “Havoc”,[ref]L’impiego del Douglas A-20 in operazioni Night Intruder nell’Europa nordoccidentale è riportato anche dal Imperial War Museum di Londra.[/ref] comunemente noto come “Boston”, il Douglas A-26 “Invader”, il Northrop P-61 “Black Widow” ed il Martin 187 “Baltimore”, noto anche come “A-30”.

8 – Douglas A-20 Havoc/Boston, bombardiere leggero e caccia notturno (USAF).

9 – Douglas A-26 Invader, bombardiere medio (USAF).

10 – Northrop P-61 Black Widow (vedova nera), caccia notturno (USAF).

11 – Martin 187 Baltimore IV/V (A-30A), bombardiere (RAF).
Com’era possibile che questi aerei volassero apparentemente indisturbati sopra una vastissima area (tutto il Norditalia) occupata dal nemico? La contraerea italiana era scarsa e concentrata intorno agli obiettivi strategici (città, stabilimenti), sicché gran parte del percorso di “Pippo” era relativamente sicuro. Inoltre, il radar dava ai britannici una schiacciante superiorità nel volo notturno: negli ultimi due anni di guerra, grazie a questo dispositivo, gli aerosiluranti della Royal Air Force stavano conducendo una vera “pesca miracolosa” di U-Boot tedeschi nell’Oceano Atlantico. Non che le forze dell’Asse non conoscessero la radiolocalizzazione, ma la padronanza della tecnologia raggiunta dagli alleati era decisamente superiore,[ref name=”lembo”]Lembo, D (op. cit.)[/ref] anche a causa delle diffidenza dei piloti italiani che non riposero mai molta fiducia nei rudimentali “attaccapanni”,[backref name=”lembo” /] i radar avioportati di fabbricazione tedesca.

12 – Un caccia multiruolo tedesco Messerschmitt Me 110G-4 equipaggiato con gli “attaccapanni”, le vistose antenne del radar FuG 220 e -sulla punta della fusoliera- l’antenna più piccola del radar a corto raggio FuG 202. Questo esemplare porta insegne britanniche (si nota la coccarda sotto la semiala) perché catturato e riutilizzato dalla Royal Air Force.
Proprio per questo motivo, infine, l’aeronautica repubblichina non disponeva quasi del tutto di caccia in grado di volare di notte,[ref name=”bermani257″]Bermani, p.257 (op. cit.)[/ref] se non con la luna piena, e che potessero quindi contrastare le incursioni dei “Pippo”. Nonostante ciò le missioni night intruder non erano esattamente delle passeggiate: gli aerei, da tre a cinque per notte (fino ad una dozzina[ref name=”bermani263″]Bermani, p.263 (op. cit.)[/ref]), decollavano da Falconara o Foggia, percorrevano centinaia di chilometri in volo strumentale con ogni condizione meteorologica per raggiungere ciascuno un’area assegnata, un quadrato di 50[ref name=”bermani260″]Bermani, p.260 (op. cit.)[/ref]-70[backref name=”bermani257″ /] km di lato di cui venivano fornite le coordinate del punto centrale. Qui l’aereo iniziava il pattugliamento seguendo un tragitto a spirale quadrata, mantenendo una quota di 3000-3500 metri[backref name=”bermani257″ /] ed una velocità di circa 300 km/h, prima verso l’esterno e poi di nuovo verso il punto centrale, per poi rientrare. Per aumentare l’autonomia di volo gli aerei erano armati con bombe leggere,[ref name=”bermani259-260″]Bermani, p.259-260 (op. cit.)[/ref] da cui le “bombette” o “spezzoni” ricordate dai testimoni.[ref]La questione era anche tattica: non avendo di notte bersagli chiari, si utilizzavano munizioni a grappolo (cluster) che massimizzavano l’area di impatto, anche a costo di danni minori. Proprio per tale caratteristica, oltretutto, erano particolarmente adatte a danneggiare autocolonne, aviosuperfici e scali ferroviari.[/ref]

13 – Foggia, 6 novembre 1944: un de Havilland Mosquito NF Mark XIII del 256º Squadrone della Royal Air Force decolla per una missione “night intruder” sull’Italia settentrionale: è Pippo. Foto: (Sgt) W.A. Jones, RAF.
Sulla reale strategia che stava dietro alle missioni, ci sono tutt’ora opinioni divergenti: la tesi comunemente accettata vede “Pippo” strumento di una guerra psicologica finalizzata a fiaccare il nemico, facendo perdere il sonno alla maestranze, minando la sicurezza delle truppe e la fiducia della popolazione nella neonata Repubblica Sociale Italiana,[backref name=”rsi” /] che si dimostrava incapace di garantire la sicurezza del territorio. Tuttavia, secondo Allan R. Perry,[backref name=”bermani259-260″ /] docente di letteratura italiana alla Pennsylvania State University che servì come capitano della sanità militare alleata a Vicenza, questo sarebbe invece stato un obiettivo secondario o addirittura collaterale: dai documenti della Mediterranean Allied Air Forces non risulta alcuna direttiva ufficiale che comandava ai bombardieri notturni di colpire la popolazione civile. Piuttosto, sostiene Perry, i bersagli primari erano le colonne di automezzi, le vie di comunicazione, ponti, strade, scali ferroviari, piste di decollo. Le missioni “night intruder” sarebbero state quindi strumentali all’operazione “Strangle”, con la quale gli Alleati tentavano di tagliare le vie di rifornimento dietro le linee nemiche.[backref name=”bermani259-260″ /] Questo spiegherebbe oltretutto la differente percezione del pericolo da parte dei testimoni: chi abitava nei dintorni delle città, dove spesso erano concentrati gli obiettivi di interesse strategico, aveva maggiori probabilità di essere colpito, anche accidentalmente. Al contrario gli abitanti delle aree rurali o di scarso interesse, quindi più raramente bombardate, ricorderebbero “Pippo” come un ricognitore notturno che non bombardava quasi mai. Verso l’epilogo della guerra, quando ormai non restava quasi più nulla da colpire, allora l’effetto divenne più psicologico in quanto il “Pippo” si limitava per lo più a fare presenza.[backref name=”bermani257″ /] Non è tuttavia da escludere che in alcuni casi la direttiva di bombardare le luci fosse stata impartita in maniera ufficiosa da qualche superiore senza che ne fosse rimasta traccia documentale, o più probabilmente che la comparsa fugace della luce di una porta aperta -nel buio completo delle campagne italiane del ’43-’45- potesse essere scambiata per quella dei fari di un veicolo, suggerendo la presenza di una autocolonna. «Gli autisti avevano preso l’abitudine, proprio per non essere individuati, di viaggiare a fari spenti ma occasionalmente erano costretti ad accenderli» spiega Giovanni Melappioni, scrittore e storico «per colpire obiettivi a terra si andava solo ed esclusivamente a vista, quindi spegnere le luci era anche una questione strettamente pratica, per i militari come per gli abitanti delle campagne.»

14 – Italia, 1943: un autocarro OM Ursus italiano con i fanali oscurati per ridurre la probabilità di avvistamento dagli aerei in volo. Foto: Bundesarchiv.
Va poi detto che, per estensione, la gente iniziò a chiamare “Pippo” ogni aereo solitario: dai monomotori Westland Lysander che volavano di notte -senza bombardare- per portare i rifornimenti ai partigiani,[backref name=”bermani257″ /] ai micidiali P-38 “Lightning” che mitragliavano le ferrovie in pieno giorno (detti al Sud “Ciccio ‘o Ferroviere”) e che nulla avevano a che vedere con le missioni “Night Intruder”. Come si spiegano però testimonianze inverosimili come quella secondo cui il pilota avrebbe urlato alla gente di nascondersi in dialetto emiliano? Risponde il professor Armando De Vincentiis, psicologo: «La spiegazione più ovvia è che nel tempo i ricordi vengano rielaborati sulla base del proprio credo personale». In altre parole, se una persona amava ricordare Pippo come annunciatore di pericoli, amico della popolazione, avrà inserito senza alcun problema nella ricostruzione mnemonica oggetti ed elementi che appartengono all’immaginario o alla leggenda. Un po’ come succede oggi con i fantomatici “dischi volanti”, insomma.
Note
[references class=”compact” /]
Bibliografia e fonti
- Colombara, Filippo. “E “Pippo” controllava sparava e bombardava.” Patria ott. 2012: pp. 27-32. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI)
- Bermani, Cesare. “L’immaginario collettivo di guerra: il mito di Pippo.” in L’aeronautica italiana. Una storia del Novecento
. Milano: Franco Angeli Edizioni, 2004. pp. 229-265.
- Toselli, Paolo. “La minaccia fantasma.” Focus Storia. Mar. 2011: pag. 11.
- Toselli, Paolo. Storie di ordinaria falsità.
Milano: Rizzoli, 2004.
- Colombo, Mauro. “Bombardamenti aerei su Milano.” Storia di Milano. 6 mag. 2003. Web. 1 apr. 2013.
- Sacchi, Pietro. “Alessandria sotto le bombe.” La Provincia di Alessandria, Anno XXXIII, 279/2 ISRAL. Web. 7-4-2013.
- Lembo, Daniele. “Il radar italiano nella seconda guerra mondiale.” Daniele Lembo. N.p., n.d. Web. 15-4-2014.
- (EN) Teller, Frederick. “An Informal Narrative History of the 47th Bombers (Prepared for the Bomb Group Reunion at Dayton, Ohio 1979).” 47th Bombardment Group. 47thbombgroup.org, 2009. Web. 1-5-2014.
- (EN) “47th Bombardment Group Light: A-20s of World War II.” 47th Bombardment Group. 47bg.com, n.d. Web. 1-5-2014.
Ringrazio, per la stesura del presente articolo, mio padre Angelo Dell’Acqua di Bereguardo, il geom. Luigi Quaroni e la sig.ra Angela Bertoni di Pavia per i racconti e le testimonianze; nonché l’amico Giovanni Melappioni, scrittore e storico, ed il prof. Armando De Vincentiis per le consulenze storiche e tecniche.
Immagini
- Un Douglas A-20 “Havoc” Mark III del 418º Squadrone RCAF a Bradwell Bay, nell’Essex, pronto a decollare per una missione “night intruder” sull’Europa nordoccidentale tra 1939 ed il 1945). Royal Air Force,1939-1945: [PD] Imperial War Museum (CH7211).
- Freytag, 1944 [CC-BY-SA 3.0] Bundesarchiv, Bild 101I-477-2106-07.
- da Cooper, H.J, O.G. Thetford, D.A. Russell. Aircraft of the Fighting Powers
Vol. II. Leicester, England: Harborough Publishing Co, 1941. [PD] Commons.
- West Point United States Military Academy [PD] Commons.
- Cap. Tanner, 26-8-2945 [PD] Imperial War Museum/Commons.
- Royal Air Force, 1939-45: Beaufighter del 272° Squadrone RAF in volo sopra Malta. [PD] Imperial War Museum (CM 5105).
- Royal Air Force, 30-9-1944: de Havilland Mosquito B.XVI (numero ML963) del “571 Squadron” in volo appena dopo la riparazione ad Hatfield [PD] Commons.
- US Air Force: Douglas A-20G-20-DO No.57 (S/N 42-86657) [PD] USAF Museum.
- US Air Force: Douglas A-26 Invader [PD] Commons.
- US Air Force: Northrop P-61A del 419th Night Fighter Squadron [PD] Commons.
- US Air Force: Martin 187 Baltimore IV/V della Royal Air Force [PD] USAF Museum (051122-F-1234P-023).
- Royal Air Force: Messerschmitt Me 110G-4 [PD] Commons.
- (Sgt) W.A. Jones, Royal Air Force, 6-11-1944 [PD] Imperial War Museum/Commons.
- Funke, 1943 [CC-BY-SA-3.0] Bundesarchiv, Bild 101I-305-0654-32/Commons.

1 – “S 14th Avenue” e “E 61st Street” a Minneapolis (© Ed Kohler – The Deets).
Street o Road, Avenue, Drive, Boulevard: le denominazioni stradali generiche sono quei termini che identificano una tipologia di spazio pubblico e vanno a comporre, accanto al nome proprio, il toponimo stradale. Se la lingua italiana è particolarmente ricca di questi termini (sono i nostri via, viale, piazza…), anche l’odonomastica in lingua inglese ce ne offre una sorprendente varietà, a testimonianza della storia dei luoghi e delle diverse contaminazioni linguistiche. Rispetto all’italiano ed alle lingue latine in genere, le denominazioni generiche in inglese presentano qualche differenza nell’uso e nel significato. La prima che si nota, anche solo osservando una targa stradale, è sintattica: nella composizione del toponimo, salvo casi particolari, la denominazione generica è un suffisso, e non un prefisso come in italiano, va cioè posta dopo il nome ufficiale (foto 3) della strada e non prima,. Per questo è detta street suffix, ma anche road (o street) type designation o semplicemente road (o street) designation.
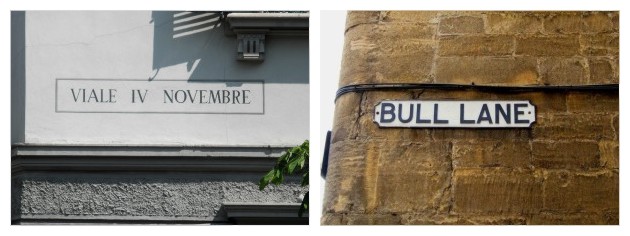
2 – Confronto tra la sintassi latina (italiano), a sinistra, e quella germanica (a destra): nel primo caso la denominazione generica (“viale”) è prima del nome, nella seconda è invece un suffisso (“lane”).
Inoltre, soprattutto nel Nordamerica, l’uso di queste denominazioni appare spesso scorrelato dalla tipologia di strada o dalla morfologia del terreno evocata dal termine. non è affatto detto, ad esempio, che una strada definita rise (salita) sia effettivamente in pendenza o che una Avenue sia diversa da una Street. Molte delle denominazioni qui elencate sono di fatto applicate a qualunque tipo di strada, in un modo che può sembrare -e forse lo è- del tutto casuale. È altresì possibile imbattersi in zone residenziali dove le strade hanno lo stesso nome e si distinguono solo per la denominazione generica;[ref]Esempio: quartieri residenziali a San Antonio, Texas. È un po’ come se chiamassimo “Roma” tutte le vie di un quartiere e per distinguerle cambiassimo la denominazione generica (via Roma, viale Roma, vicolo Roma, salita Roma ecc…)[/ref] non è infrequente, infine, che le strade siano prive di denominazione generica ed abbiano solo il nome proprio: ad esempio “Broadway”, “The Corso” per citare i più comuni. Ci sarebbe anche molto da scrivere anche sui differenti modelli urbanistici[ref]Le città europee sono diverse, dal punto di vista urbanistico, da quelle americane e ciò comporta necessariamente delle differenza nell’uso della toponomastica. Alcune città australiane possono essere considerate una “via di mezzo” tra i due modelli.[/ref] e sulle usanze locali, ma sarebbe un argomento troppo vasto e dispersivo per quello che vuol essere un semplice, seppur approfondito, glossario.
- Acres
- Alley
- Annex
- Approach
- Arcade
- Avenue
- Bank
- Bay
- Bend
- Boardwalk
- Boulevard
- Bow
- Brae
- Broadway
- Brow
- Causeway
- Canyon
- Chase
- Circle
- Circuit
- Circus
- Cliff
- Cliffe
- Close
- Common
- Common Road
- Concession
- Corner
- Cottages
- Court
- Courtyard
- Cove
- Crescent
- Crest
- Croft
- Curve
- Dale
- Dene
- Drive
- Drung
- End
- Esplanade
- Estate
- Extension
- Frontage Road
- Garden
- Gardens
- Garth
- Gate
- Green
- Grove
- Heights
- Hill
- Island
- Key
- Lane
- Landing
- Lea
- Leigh
- Line
- Manor
- Mead
- Meadow
- Mews
- Mimms
- Mount
- Orchard
- Parade
- Park
- Parkway
- Pass
- Path
- Pike
- Place
- Plain
- Plaza
- Point
- Private
- Quay
- Ridge
- Rise
- Road
- Row
- Royd
- Run
- Shores
- Side
- Sideline
- Sideroad
- Spring
- Spur
- Square
- Stravenue
- Street
- Terrace
- Trail
- Vale
- Vennel
- View
- Walk
- Way
- Wood
- Woods
- Wynd
- Acres: acri, fondo, tenuta (l’acro è una unità di misura di superficie), generalmente una strada residenziale suburbana, sia isole brit. che USA (es. “Lynn Acres“, Moundsville, WV).
![© M. Garratt [CC-BY-SA-2.0] Bakers_Alley_-_geograph.org.uk_-_615428](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/02/Bakers_Alley_-_geograph.org_.uk_-_615428-200x300.jpg)
3 – “Bakers Alley” a Thirsk, Inghilterra (© M. Garratt).
- Alley (Aly.): vicolo (→), passaggio tra due edifici. Nelle isole britanniche è il suffisso per i vicoli, intesi come vie strette ma con accessi o negozi. I passaggi di servizio sul retro degli edifici spesso non hanno nome e sono definiti genericamente alleyway (isole britanniche) o alley (Stati Uniti). Gli alleway che separano il retro delle rowhouse (case a schiera) sono tipici delle città con una storia industriale, come Manchester.
- Annex (Anx.): collegamento, estensione; estensione, (prolungamento o diramazione) di una strada principale.
- Approach (App.): accesso, avvicinamento; specialmente in Inghilterra, strada che conduce a un particolare luogo da cui prende il nome (es. “Church App.”, “Foundry App.” a Leeds).
- Arcade (Arc.): portico, colonnato; una strada pedonale coperta con negozi ai lati, equivale all’italiano galleria (→). Le prime strutture di questo tipo furono i passage parigini (→) nel XIX secolo.
- Avenue (Av. o Ave.): viale (→), corso (→) strada principale di una città [ref]”Avenue.” Treccani, il portale del sapere. Web. 21 -3-2013.[/ref] (dal francese avenue, participio passato di avenir, “arrivare”). È una strada alberata (viale) o comunque più importante della →Street, anche se spesso i due termini sono usati come sinonimo. A Manhattan (New York) le “Avenue” sono le direttrici nord-sud, più larghe ed importante delle perpendicolari “Street”. Da ciò deriva l’usanza -in molte città nordamericane- di chiamare “Avenue” le strade che vanno da nord a sud e “Street” quelle che vanno da est a ovest, anche quando in pratica non vi è nessuna rilevante differenza tra di esse, come a Chicago o Tucson.

4 – La “Fifth Avenue” (Quinta Strada) di New York, una delle arterie di Manhattan e simbolo della città.
- Bank: si trova in Gran Bretagna in due diverse accezioni.
- sponda, riva; una strada che costeggia o si trova nelle vicinanze di un fiume o lago: es. “Lake Bank” è il “lungolago” (→) di Littleborough, Inghilterra.
- fila, serie; una strada costeggiata da una fila di case (v. →Row): es. “Chowdene Bank” a Gateshead.
- Bay: baia, insenatura. In Canada è una breve strada residenziale a fondo chiuso che termina in un un piccolo spiazzo circolare allo scopo di agevolare l’inversione di marcia dei veicoli (es. “Elm Bay“). Negli USA strade di questo tipo sono invece dette →Court o →Cove.
- Bend (Bnd.): curva; negli USA una strada residenziale curva, a fondo chiuso (es. “Horsesoe Bend“, “Pine Bend“).
- Bluff (Blf.): scogliera; (in Texas) strada residenziale.
- Boardwalk: passerella; sulla costa orientale degli Stati Uniti è una passeggiata lungo il mare (→Esplanade) pavimentata in legno e riservata ai pedoni. La prima Boardwalk fu costruita ad Atlantic City nel 1870.[ref]Maffi, Mario, Cinzia Scarpino et al. “Boardwalk (Atlantic City)” in Americana: Storie E Culture Degli Stati Uniti Dalla A Alla Z. Milano: Il Saggiatore, 2012. 84-85.[/ref]

5 – La “Boardwalk” di Atlantic City (New Jersey): notare la pavimentazione in legno. “Boardwalk” significa infatti anche “passerella”.
- Boulevard (Bvd. o Blvd.): dal francese boulevard, termine utilizzato in Francia dal XV secolo, come l’italiano baluardo (→) deriva dal germanico bolwerk ed indicava originariamente una strada posta dove esistevano delle mura difensive. Dal XIX (sempre in Francia) indica i grandi viali che circondano il centro, le circonvallazioni. Traducibile come viale (→). Nel Regno Unito un esempio è Nottingham, il cui centro è circondato dai boulevard. Negli Stati Uniti ed Australia (dove esiste anche la forma epitetica “Boulevarde”, con la “e” finale) il termine indica un’arteria, non un boulevard nel senso originario del termine, che nell’urbanistica delle città americane non esiste.
![© J. Sutton/Geograph [CC-BY-SA-2.0] 2361001_60bb2904](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/02/2361001_60bb2904-300x225.jpg)
6 – “Lenton Boulevard” a Nottingham (UK): è uno dei viali che circondano il centro.

7 – “Queen Boulevard” a New York, è una delle arterie principali della città.
- Bow: arco, curva; strada curva (es. “Upper Bow” e “West Bow” a Edimburgo, Scozia).
- Brae: termine di origine scozzese, significa pendio di collina.
- Branch (Br.): ramo, diramazione; in USA è una strada locale.
- Broadway (Bdway o Bdwy.): letteralmente via larga, è la via principale in alcune importanti città statunitensi (New York City, Baltimora, Chicago, Los Angeles, Miami, Minot ND, Tampa FL, Kansas City). Il termine deriva dal neerlandese Breede weg e risale all’originario insediamento di New Amsterdam, il nucleo originario di New York. “Broadway” è in genere il nome completo della strada (che non ha quindi ulteriori denominazioni) a parte alcune eccezioni come a New York dove, oltre alla “Broadway” che costituisce la direttrice nord–sud, ci sono anche “Est Broadway”, “West —” e “Old —”.

8 – La storica “Broadway” di New York nel 1834.
- Brow: ciglio, fronte, dosso;[ref]Bacchelli, Gabriella. Collins English-Italian, Italian-English dictionary. Glasgow: HarperCollins, 1995. (cfr. Wordreference)[/ref] (ing. britannico) strada in pendenza o che costeggia un pendio (es. “Chapel Brow“, Tintwistle, Inghilterra).
- Canyon: valle stretta o dalle pareti ripide, gola (dallo spagnolo cañón); in genere si tratta di piccole strade residenziali a fondo chiuso, come le →Court.
- Causeway (Cswy. o Caus.): (dal medio inglese caucewaye, “strada rialzata” a sua volta dal latino medievale via calciata: selciata, pavimentata) una strada rialzata mediante un terrapieno, che attraversa l’acqua o una palude. A Miami le Causeway sono le arterie che attraversano la baia e raggiungono le isole di Miami Beach e Kay Biscayne: un misto di terrapieni, isolette, tratti sopraelevati e ponti levatoi.
![foto: M. Averette [CC-BY-SA-3.0/GNU-GFDL] Venetian Causeway](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/03/Venetian_Causeway_South_Beach.jpg)
9 – “Venetian Causeway” a Sout (Beach Miami): ultimata nel 1925, attraversa la baia e le Venetian Islands per arrivare a Miami Beach. Comprende due ponti levatoi ed è iscritta al National Register of Historic Places.
- Chase (Ch.): terreno di caccia; in Gran Bretagna, strada residenziale a fondo chiuso (“Poets Chase“, “Squirrel —“).
- Circle (Cir.): cerchio, circolo, può avere diversi significati:
- (USA) traffic circle, ampia rotatoria stradale all’interno della quale si trova un parco o giardino. Celebri esempi sono “Dupont Circle” a Washington D.C, che contiene l’omonimo parco e dà il nome all’intero distretto storico; “Monument —” a Indianapolis, “Lee —” a New Orleans e “Columbus —” a New York City (foto 10).

10 – “Columbus Circle” a New York
- (UK) cerchio; a Londra “Inner Circle” è una strada circolare che racchiude il Queen Mary’s Garden.
- (USA) strada locale (residenziale) a fondo chiuso che termina con uno slargo circolare: nel Minnesota, il termine è sinonimo di →Court (es. “Thomas Circle“, Burnsville).
- (USA) specialmente in Illinois e Tennessee, può essere una diramazione che si ricollega alla strada di origine, stabilendo così un percorso grossomodo circolare (es. “Coventry Cir.” a Glendale Heights IL: “Woodside —” a Nashville TN; “Liegh Anna —” a Lafayette TN).
- (USA) traffic circle, ampia rotatoria stradale all’interno della quale si trova un parco o giardino. Celebri esempi sono “Dupont Circle” a Washington D.C, che contiene l’omonimo parco e dà il nome all’intero distretto storico; “Monument —” a Indianapolis, “Lee —” a New Orleans e “Columbus —” a New York City (foto 10).
- Circuit (Cct.): circuito, pista, giro; in Australia è una strada residenziale che segue un percorso chiuso (es. “Botanical Circuit“, Banora Point NSW; “Elmwood —” Blakeview SA).
- Circus (Crcs.): termine britannico che indica una piazza o una rotatoria in cui convergono altre strade. Piccadilly Circus è una celebre piazza di Londra, così denominata in riferimento all’originario incrocio circolare (“circus”) modificato nel 1886 con la costruzione di Shaftesbury Avenue.

11 – “Piccadilly Circus” a Londra (J.Cormack/Commons).
- Close (Cl.): strada residenziale chiusa, cul–de–sac (specie nelle isole britanniche).
- Common (Cmmn.): parco, negli USA una strada residenziale (es. “Wolcott —” a Freemont, California).
- Common Road: strada comune, nelle isole britanniche è solitamente una strada extraurbana. Un manuale di ingegneria britannico del 1855[ref]Law, Henry, and Samuel Hughes. “The exploration of roads.” Rudiments of the art of constructing and repairing common roads. London: J. Weale, 1855. p. 47.[/ref] definisce la common road una ramificazione di un’arteria principale, descrizione applicabile però ad un’ampia varietà di strade.
- Concession: in Canada (soprattutto nell’Ontario) indica una Concession Road, ovvero una strada realizzata dal governo coloniale per dareaccesso ai lotti di terreno destinati ai nuovi coloni. Questi erano dati in concessione (da qui il termine concession) dalla Corona Britannica a chi ne faceva richiesta, in cambio di una tassa in denaro e dell’impegno ad erigere una casa e coltivare il terreno. Le concession road erano parallele tra loro e formavano, insieme alle perpendicolari dette →line o →sideline, un reticolo di lotti rettangolari da 100 acri, ognuno dei quali conteneva dieci fattorie.[ref name= “concession”]”Concession Line.” The Canadian Encyclopedia. Historica Canada, Web.[/ref] Le concession road sono di solito numeate, ad esempio “Concession 10th”.
- Corner: strada locale a fondo chiuso (Inghilterra).
- Cottages: nelle isole britanniche è una strada che serve un gruppo di cottage, tipiche case rurali.
- Court (Ct.): corte, cortile, strada a fondo chiuso. in Nordamerica tipicamente termina in una piazzola circolare; detta anche →Circle, →Cove nel Minnesota e →Bay in Canada.

12 – Una tipica court nordamericana, strada residenziale che termina con una piazzola circolare: “Dumfries Ct.” a Sacramento, California (H. W. Schmitt/Commons).
- Courtyard: cortile, strada locale residenziale (es. “March Courtyard“, “September —” a Gateshead, Inghilterra).
- Cove (Cv.): piccola baia o rientranza, caverna; si trova nel Tennessee (Memphis, Nashville) come sinonimo di →Court.
- Creek (Crk.): ruscello, torrente; negli USA è una strada locale.
-

13 – Londra: Wilton Crescent, nel distretto di Belgravia (N.Cox/Geograph).
Crescent (Cres.): crescente, mezzaluna. In architettura il termine crescent si riferisce ad una serie di edifici disposti a formare un semicerchio;[ref]Pevsner, Nikolaus e John Fleming. Dizionario di architettura
. Torino: Einaudi, 1992.[/ref] nell’odonomastica britannica il termine si riferisce ad una strada curva che segue la facciata di tali edifici; tuttavia si è diffuso anche alle diramazioni locali che si ricongiungono con la strada principale (come →Common)
- Crest: vetta, dorso di collina; strada che segue il dorso di un colle (es. Irlanda e Nordamerica).
- Croft: piccola fattoria, appezzamento; in Inghilterra è una strada locale (es. “Well Croft“, “Oak —“).
- Curve: in USA strada residenziale, in riferimento all’andamento curvo (es: “Brockton Curve“, “4th —“).
- Dale (Dl.): dal norreno, valletta, avvallamento; in Inghilterra è una strada locale (es: Wellspring Dale a Nottingham).
- Dene: terreno sabbioso, duna (dal medio inglese, secoli XI–XVI) oppure valle stretta e boscosa (dall’inglese antico denu, valle); strada locale in Inghilterra (es. “Milton Dene“, “Oak —“).
![D. Delso [CC-BY-SA-3.0] Rodeo_Drive-Los_Angeles-California](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/03/Rodeo_Drive-Los_Angeles-California-300x225.jpg)
14 – “Rodeo Drive” a Los Angels (D.Delso/Commons).
- Drive (Dr.): strada destinata al traffico veicolare (da drive, “guida”). In USA molte celebri strade hanno questa denominazione: “Ocean Drive” a Miami, “Rodeo Drive” a Beverly Hills o ancora la “Mulholland Drive” di Hollywood, che ha dato il nome ad un film di D. Lynch
del 2001. Tuttavia il suffisso Drive è abbastanza comune per qualunque tipo di strada, dalle arterie ai viottoli residenziali.
- Drung: si trova solo nell’isola di Newfoundland (Canada). Nel dialetto locale (il Newfoundland English o newfinese) il termine drung significa «stradina, o passaggio tra case, recinzioni dei giardini, ecc…»[ref]Widdowson, J. D. A. Dictionary of Newfoundland English
. 2a ed. Toronto: University of Toronto Press, 1990. Pag. 156.[/ref] Sull’isola esistono alcune strade con questa denominazione (“Cotters Drung“, “Roman’s Drung“, “Long drung“, ecc…).
- End: fine, termine, strada a fondo chiuso.
- Esplanade (Esp.): spianata. Ampio viale che costeggia il mare o un corpo d’acqua, in genere adibito al passeggio, equivalente all’italiano lungomare (→) e simili o passeggiata (→). Il termine deriva dal francese esplanade (XV sec.), a sua volta dallo spagnolo[ref name=”dh”]Douglas Harper.[/ref] o italiano antico,[ref]Esplanade. Dictionary.com[/ref] indicava in origine l’ampio spazio lasciato intorno alle fortificazioni allo scopo di esporre eventuali attaccanti al fuoco dell’artiglieria difensiva. Spesso è utilizzato come sinonimo di →Promenade.
- Estate: tenuta, proprietà fondiaria. In Inghilterra, strada locale nell’ambito di un complesso omogeneo: un housing estate (complesso residenziale, es. “Peabody Estate“) o un industrial estate (area industriale, es. “Addison Industrial Estate“).
- Extension (Ext. o Extn.): estensione di una strada preesistente, della quale mantiene il nome completo di suffisso. Es. “Robinson Street Ext.” (Pittsburg, PA) è un’estensione di “Robinson Street”.
- Frontage Road: in Nordamerica, una strada che costeggia una highway (es. “East Frontage Rd.”).
- Gardens (Gdns.) o Garden (Gdn.): giardini o giardino; in Inghilterra è una strada locale fiancheggiata dai giardini privati delle rowhouse (o terraced house) o villini in genere, come →Row o →Terrace.
- Garth: giardino o terreno recintato (dall’antico norreno garthr, fattoria). In Inghilterra, strada locale tra abitazioni con giardino (es. “Oakwood Garth“, “Bartons —“).
- Gate: cancello, porta; breve strada di collegamento tra due strade più importanti, oppure la strada che accede ad un centro abitato (es. Slant Gate a Kirkburton, UK).
- Green (Gn.): in Inghilterra, strada locale che costeggia un prato (es: alcune “green” a Dudley, UK).
- Grove (Gr.): boschetto (dall’inglese antico grāf). Strada residenziale, come →Gardens. Usato in Australia (es. a Caulfield North) e isole britanniche.
- Heights (Hts.): altezza, altitudine, sommità. In Nordamerica, strada locale.
- Hill (Hl.): collina; strada locale in corrispondenza di un rilievo altimetrico, nelle isole britanniche (es. “Gipsy Hill“, a Londra; “Laurel —” a Newry, Irlanda del Nord) e Nordamerica (es. “Wabash River —“).
- Island (is.): isola; a Newry (Irlanda del Nord) “Sugar Island” è la strada principale che attraversa l’omonima isola fluviale.
- Key (Ky.): secca, isola bassa, scogliera (dallo spagnolo cayo) oppure banchina (portuale) dal francese antico kay, cay (1690-1700)[ref name=”quay”]Quay, Dictionary.com[/ref] da cui anche l’inglese →Quay (molo, banchina), dalla pronuncia pressoché identica. A Broadbeach Waters (Queensland, Australia) sono così chiamate alcune strade residenziali a fondo chiuso (in particolare le traverse di “T. E. Peters Dr.” e “Merrimac Blvd.”), intercalate dai canali realizzati a partire dagli anni 1960 in seguito alla bonifica degli acquitrini costieri della Golden Coast.
Le “key” ed i canali di Broadbeach Waters
- Landing (Lndg. o Ldg.): approdo. In Nordamerica, una strada a fondo chiuso in prossimità di un corso d’acqua (es. “West Landing” a Williamsburg, USA; “Picnic —” a Darmouth, Canada).
- Lane (Ln.): corsia; comune, indica una strada locale (spec. residenziale) adibita al transito dei veicoli.
- Lea: prato, prateria. Termine in uso prima del ‘900, dal medio inglese leie (XI–XVI secolo). In Inghilterra è una strada locale residenziale (es. “Close Lea“, “Ridge —“).
- Leigh: in Inghilterra è una strada residenziale tra case a schiera (rowhouse), in Inghilterra (es. “Oak Leigh” e “Ivy —” a Liverpool); come →Terrace.
- Line: in Canada indica una Concession Road (vedi →Concession).
- Loop: anello, circuito. In Nordamerica è in genere una strada che segue un percorso chiuso (es. “Choctaw Loop“, “Lake —“); “City Centre Loop” a Leeds, Inghilterra è invece una rotatoria.
- Manor: tenuta, maniero, dal francese antico manoir, dimora; strada residenziale in Irlanda (es. “Oakwood Manor“, “Rahanine —“) e Texas.
- Mead: vocabolo dall’inglese antico equivalente all’odierno →Meadow, prateria, pascolo in genere paludoso e situato vicino ad un fiume; nell’odonomastica dell’Inghilterra allude ad un luogo dedicato al pascolo (es. “Castle Mead“, “Crane —“).
- Meadow: prateria, pascolo paludoso (da →Mead), in Inghilterra allude ad un luogo dedicato al pascolo (es. “Castle Meadow” a Norfolk, che circonda il castello).
- Mews: tipicamente britannico, indica una via che fiancheggia i mews, tipici fabbricati a schiera londinesi del XVII e XVIII secolo caratterizzati dalle rimesse al piano terreno e dagli appartamenti ai piani superiori (da mew, che nella falconeria, è la voliera per gli uccelli predatori[ref]”mews.” Britannica Online Encyclopedia. Encyclopædia Britannica, Inc. Web. 24-3-2013.[/ref]). Oggi il termine indica più genericamente una strada su cui si affacciano edifici a schiera a due piani (es. “Wansbeck Mews“); anche in Australia (es: “Orion —” a Melbourne).
![Ivan Moskalev [CC-BY-SA-3.0] Horbury_Mews](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/03/Horbury_Mews.jpg)
15 – Tipici mews britannici: “Horbury Mews” a Londra (I.Moskalev/Commons)
- Mimms: via a fondo chiuso; solo a Hemel Hempstead, Inghilterra (“Little Mimms”, “Long —“, “East —”).
- Mount (Mt.): montagna o collina, probabilmente dal medio inglese (secoli XI-XVI) mont. In Inghilterra è una strada residenziale (es. “St. Nicholas Mount“, “Beech —“).
- Orchard (Orch.): frutteto. In Inghilterra, piccola strada residenziale fiancheggiata da giardini di rowhouse o villini, come →Gardens (“Cherry Orchard“, “Knights Orchard“).
- Parade (Pde.): parata, fila di negozi; strada su cui si affacciano negozi o altre attività (es. “Bank Parade” a Burnley, UK); Isole britanniche e Australia.
![© Simon Carey/Geograph [CC-BY-SA-2.0]](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/03/kings-parade.jpg)
16 – “Kings Parade” a Findon, West Sussex (S. Carey/Geograph).
- Park: parco pubblico urbano; da Hyde Park di Londra al Central Park di New York, per citarne due tra i più celebri. In Inghilterra è anche sinonimo di →Garden (es. “Elm Park” a Londra), ovvero via fiancheggiata da giardini privati.
- Parkway (Pky. o Pkwy.): negli Stati Uniti il termine può avere diversi significati:
-

17 – “Eastern Parkway” a Brooklyn, New York.
viale, (→) strada piantumata, originariamente riservata al passeggio ed alla circolazione di biciclette, cavalli o veicoli a trazione animale. Le parkway furono concepite nel secolo XIX dagli urbanisti Frederick Law Olmsted (1822–1903) e Beatrix Farrand (1872–1959): la prima strada di questo tipo fu Eastern Parkway a Brooklyn (New York) [ref]”Eastern Parkway.” Highlights: NYC Parks. New York City Department of Parks & Recreation. Web. 20-3-2013. [/ref] Il temine fu coniato dallo stesso Olmsted e dall’urbanista Calvert Vaux (1824-1895) che proposero di collegare le città ed i parchi suburbani con delle «pleasure roads». Tra il 1868 ed il 1876 Olmsted e Vaux realizzarono numerose parkway a Buffalo (NY) nel contesto di un sistema di parchi cittadini (Delaware Park–Front Park System).
- strada a grande scorrimento a carattere scenico, dalla quale sono esclusi i veicoli pesanti →Parkway (2).
-
- Pass: passo, passaggio. Strade secondarie e residenziali, nel Regno Unito e Stati Uniti.
- Path: sentiero, cammino; percorso in contesto naturale o strada residenziale.
- Pike: barriera, originariamente con il significato di strada a pedaggio. È diffuso nella zona centro e nord-occidentale degli Stati Uniti come suffisso stradale per strade principali, non a pedaggio (es. “Otsego Pike“, Ohio). Da turnpike, barriera (cfr. →Turnpike).
- Place (Pl.): normalmente è una via secondaria, residenziale o commerciale; spesso a fondo chiuso (ma non necessariamente). Denominazione diffusa ovunque; celebre ad esempio Melrose Pl. a West Hollywood (California), da cui prende il nome una serie televisiva degli anni ’90.
- Plain (Pln.): piano. Indica un largo, (→) ovvero uno spazio ampio dove si intersecano più strade. (“Bank Plain “a Norwich, UK).
- Plaza (Plz. o Plza.): piazza (→), dallo spagnolo plaza (→), spazio ampio e pavimentato.
- Point (Pt. o Pnt.): punta. In Nordamerica, vialetto residenziale a fondo chiuso che termina con una piazzola circolare: come →Court o →Cove. Es. “Mersey Point” a Eagan (Minnesota, USA) o “Elm Point” a St Albert (Alberta, Canada). A Edimburgo, “Main —” è un largo in cui si incontrano tre strade principali.
- Private: strada privata, come suffisso a sé stante si trova solo ad Ottawa, Canada (es. “Osnabrook Private“).
- Promenade (Prom.): passeggiata, dal francese promener (1560-70), “uscire (per una passeggiata)”.[ref]”Promenade“, Dictionary.com[/ref] Indica un viale destinato al passeggio, ma è spesso usato come sinonimo di →Esplanade.
- Quay (qy.): molo, banchina, dal francese antico kay, cay (1690-1700)[backref name=”quay”] da cui anche →Key (Australia) ed il francese moderno →Quai. Indica una strada che costeggia un fiume, un canale o un lago; si incontra in Inghilterra (Bridgwater), Irlanda del Nord (Belfast, lungo il fiume Lagan o a Newry and Mourne, lungo il canale Newry), Canada (“Queen’s —” in Toronto) e Singapore.

18 – “West Quay” sul fiume Parret a Bridgwater, Inghilterra: è equivalente di un “lungofiume”.
- Ridge (Rdg. o Rdge.): cresta, dorsale, crinale; strada locale residenziale in presenza di una collina o una pendenza del terreno; negli Stati Uniti ed Inghilterra
- Rise: salita, strada locale (non necessariamente in pendenza); in Inghilterra (es. “Trinity Rise“) ed Irlanda (o “Newcastle Wood —“).
- Road (Rd.): strada, è il termine più generico. Nella toponomastica indicherebbe la strada extraurbana o di transito, contrapponendosi a →Street che è invece la strada cittadina. In pratica però i termini sono spesso utilizzati come sinonimi.
- Row: fila, schiera; nelle isole britanniche è una strada di rowhouse o altri edifici a schiera (es. “Elm Row“, una strada principale di Edimburgo, Scozia).
- Royd: termine di origine teutonica che indica uno “spazio liberato dagli alberi”;[ref]”Etymology Of British Place-names.” Bartholomew’s Gazetteer of the British Isle, c.a 1900. Ancestry.com. Web. 16-2-2014.[/ref] nello Yorkshire è usato per alcune strade locali (es. “Oak Royd“, “Arnold —“).
- Run: pista, corsa; strada locale dall’andamento curvo, serpeggiante, soprattutto nel Michigan. Anche alcune strade storiche di Philadelphia avevano in precedenza questa denominazione (“Gunner’s Run”, “Pegg’s —”).[ref]”Late and Former Names of Streets of the Old Districts…” ushistory.org. Independence Hall Association, n.d. Web. 12-2-2014.[/ref]
- Side, Sideline o Sideroad: in Canada, sono strade rurali minori, perpendicolari alle →Concession Road e che delimitano i lotti agricoli. Sono contraddistinte da un numero, posto dopo la denominazione (es. “Sideline 22”).
- Shores (Shrs.): rive, sponde; strada lungo la riva di un lago o di un corso d’acqua, es. “Chanticleer Shores“.
- Spring (Spg.): fonte; piccole strade residenziali a villini, sia in Inghilterra (es: “Pierian Spring“) che negli Stati Uniti (es: alcune “Spring” a San Antonio, Texas).
- Spur: sperone. In USA indica una diramazione, che si ricongiunge o meno con la strada principale (Branch Spur, Stake Spur).
- Square: piazza (letteralmente rettangolo); si intende uno spazio pubblico racchiuso all’interno di un centro abitato, più largo delle strade che vi convergono. Negli Stati Uniti le piazze propriamente dette sono più rare e limitate alle città storiche; nelle urbanistiche più recenti lo square è un largo (→) di forma irregolare formato dall’intersezione di più strade, con prevalenza di servizi commerciali (come il celebre “Time Square” di New York, formato dall’incrocio tra la “Broadway” e la “7th Avenue”), oppure è un parco cittadino che occupa lo spazio di un isolato (es. “Union —” o “Madison —” a New York) con i tratti di strada che lo delimitano. Nelle isole britanniche è talvolta usato anche per le vie (es. “Leichester Square” a Bristol). Negli Stati Uniti le piazze sono chiamate anche →Plaza.
- Stravenue (Stra.): portmanteau di →Street e →Avenue, questo termine è tipico di Tucson (Arizona) e indica una strada che interseca diagonalmente il reticolo urbano della città, costituito quasi interamente dalle Street (orientate sull’asse est–ovest) e dalle Avenue (da nord a sud). Le “Stravenue” nacquero nelle zone circostanti la ferrovia, che taglia la città in da nordovest a sudest, intorno alla quale i costruttori iniziarono a realizzare piccole lottizzazioni seguendone l’andamento diagonale. Sembra che il termine sia stato coniato dall’imprenditore e benefattore Roy Drachman nel 1948, mentre pianificava il quartiere di Pueblo Gardens. [mapsmarker marker=”87″] Le “Stravenue” di Tucson.
- Street (Str.): dal latino via strata, strada lastricata. È la denominazione più comune in lingua inglese ed indica una strada urbana pavimentata: è equiparabile all’italiano via (→). A differenza della →Road, strada extraurbana -la cui funzione prevalente è quindi il transito- la street è invece la strada urbana costeggiata da edifici, quella dove si svolge la vita sociale di una città. In realtà però, i termini sono spesso utilizzati come sinonimi.

19 – “Main Street” a Salt Lake City, 1890.
- Terrace (Tce. o Ter.): terrazza, patio; nel Regno Unito è una strada di terrace house o terraced, ovvero le case a schiera, dette anche rowhouse. Negli Stati Uniti ed in Australia è più genericamente una strada residenziale (a parte qualche eccezione, es. “St.Paul Terrace” a Brisbane che è un’arteria urbana a quattro corsie).
- Trail (Trl.): sentiero; appunto un viottolo sterrato o una pista ciclopedonale; negli Stati Uniti l’uso del termine spazia anche dalla strada residenziale (es. alcune “Trail” a Newtown, CT) a quella extraurbana (es. Lake Trail, Indiana).
- Vale: valle; nelle isole britanniche, probabilmente in presenza di un avvallamento (“Elm Vale” a Liverpool).
![© D. Harper [CC-BY-SA-2.0] strynd vennel](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/03/strynd-vennel-200x300.jpg)
20 – Un vennel a Cullros, in Scozia
(© D. Harper). - Vennel: vena, dal francese antico venelle, a sua volta dal latino vēna. È un vicolo, un passaggio tra due edifici, sinonimo di →Alley o →Lane; si trova in Scozia e nel nord est dell’Inghilterra.
- View: vista, veduta; nelle isole britanniche, una strada in posizione rialzata che offre una qualche vista (es. “Tyne View“, a Newcastle upon Tyne, da cui si vede il fiume Tyne).
- Walk: camminata; strada secondaria, non necessariamente pedonale, in Inghilterra ed Australia.
- Way: via, percorso; molto diffuso, si applica a qualunque tipo di strada. Deriva dall’inglese antico weg, “strada”, “percorso”,[backref name=”dh” /] da cui anche il latino viae.
- Wood o Woods: bosco; nelle isole britanniche, strada residenziale a villini (come →Gardens).
- Wynd: vicolo, viuzza, in Scozia ed Inghilterra settentrionale; deriva dall’antico norreno venda, “svoltare”, con riferimento al fatto che vi si accede svoltando da una via principale (e non all’andamento curvo).[ref]Harris, S. The Place Names of Edinburgh. London: Steve Savage, 1996. p. 28. ISBN 1-904246-06-0[/ref] Negli USA si trova solo nel villaggio di Bald Head Island, nel North Carolina, dove indica invece le strade principali.
Reti stradali ed autostrade
Esistono una serie di termini per designare le reti di strade o le autostrade, che non sono però utilizzati come denominatori stradali propriamente detti ma che è comunque interessante conoscere. Le prime, dette Numbered Highways in USA, sono strade importanti identificate da una numerazione nazionale, ma che possono avere una denominazione locale. Le seconde sono strade a grande scorrimento, possono essere a corsie separate e prive di incroci a raso ed accessi privati; l’accesso può essere a pedaggio o gratuito, controllato da barriere (controlled–access highway) oppure semplicemente limitato ad alcune categorie di veicoli (limited–access highway). Non sempre esiste una distinzione precisa tra i vari termini con cui vengono definite, la cui scelta è dovuta più all’uso locale della lingua che a reali differenze tecniche tra le infrastrutture.
- Byway: negli Stati Uniti, il termine indica una delle circa 150 “National Scenic Byway” e “All-American Road”, strade principali riconosciute di particolare interesse archeologico, culturale, storico, naturale, ricreativo o scenico.
- Corridor: corridoio; negli Stati Uniti sono così denominate le highway del “Appalachian Development Highway System”, il sistema viario della regione dei monti Appalachi.
- Expressway: (Expy.) è una controlled–access highway (autostrada) o una limited–access highway (superstrada), a carreggiate separate e senza incroci a raso; può essere a pedaggio o meno.[ref name=”britannica-expressway”]”expressway” Britannica Online Encyclopedia. Encyclopædia Britannica, Inc. Web. 20 Mar. 2013.[/ref]
- Freeway: (Fwy.) strada libera, sinonimo di →Expressway.[backref name=”britannica-expressway” /] L’I.T.E. (Institute of Transportation Engineers) definisce Freeway le strade ad accesso controllato e carreggiate separate, sia a pedaggio che gratuite; distingue inoltre il tipo “A”, ovvero, quelle situate nelle aree metropolitane, con pattern complessi (ad esempio diramazioni e raccordi) che potremmo paragonare alle tangenziali, e tipo “B” tutte le altre. Nell’uso comune, il termine “Freeway” si riferisce però alle superstrade ad accesso gratuito.
- Highway (Hwy.): in inglese britannico è un termine tecnico–legale che si applica a qualunque tipo di strada pubblica, ma nel linguaggio comune si riferisce solitamente alle strade principali. In America ed Australia si intende per highway una strada principale di rilevanza nazionale, che può essere una controlled–access highway o una limited–access highway, o anche una strada lunga, che offre un collegamento relativamente veloce tra due luoghi, ma che non ha necessariamente caratteristiche di autostrada (ad esempio le U.S. Routes).
- Interstate: negli Stati Uniti, sono le controlled–access highway (autostrade a pedaggio) della rete del “Interstate Highway System”.
- Motorway (Mwy): sinonimo di →Expressway,[backref name=”britannica-expressway”/] nel Regno Unito indica una controlled-access highway (autostrada).
- Parkway (Pkwy): negli Stati Uniti e Canada, si applica ad una categoria di strade a grande scorrimento a carattere scenico, in genere analoghe alle →Freeway, rispetto alle quali presentano però alcune differenze: ad esempio hanno spesso percorsi più tortuosi, per adattarsi all’orografia del terreno, sono interdette al traffico di autocarri e simili (nello Stato di New York ed a Cincinnati) a causa dell’altezza limitata di alcuni sottopassi. Celebri ad esempio sono la “Natchez Trace Parkway”[backref name=”natchez” /] e la “Blue Ridge Parkway”:[ref]”Blue Ridge Parkway” Britannica Online Encyclopedia. Encyclopædia Britannica, Inc. Web. 20 Mar. 2013.[/ref] la prima percorre 715 km da Nantchez (Missisipi) fino a Nashville (Tenessee), passando per l’Alabama e per il parco nazionale di Tombigbee (TN), la seconda percorre 755 km attraversando la catena montuosa degli Appalachi dal parco nazionale di Shenandoa a quello delle Great Smoky Mountains. A Minneapolis le parkway sono strade urbane principali, con incroci a raso e passaggi pedonali. Parkway è anche utilizzato per definire un viale alberato destinato al passeggio, vedi →Parkway (1).
- Route: negli U.S.A. è una strada del reticolo nazionale delle “U.S. Numbered Highways”. Non sono necessariamente a carreggiate separate. Celebre è “Route 66” da Chicago a Santa Monica (California), via principale delle migrazioni verso ovest nel XX secolo (ora “Historic Route 66”). La più lunga è la U.S. Route 20 da Newport (Oregon) a Boston (Massachussets) con 5 209 km.
- Thruway: è una autostrada a pedaggio della rete autostradale dello stato di New York (New York State Thruway).
- Turnpike: barriera, negli U.S.A. è una controlled-acces highway sempre a pedaggio (es: “Massachusetts Turnpike”, abbreviata “MassPike”, e “Pennsylvania —”).

21 – La celeberrima “Route 66” (ora “Historic Route 66”) all’altezza di Holbrook, in Arizona.
Note
Sono state prese in considerazione le denominazioni che compaiono nei toponimi di almeno due strade che hanno accessi privati (con numeri civici o equivalenti) e quindi possono costituire un indirizzo postale. In mancanza di indicazioni si intende che la denominazione è utilizzata nelle tre aree principali di lingua inglese: isole britanniche, Nordamerica e Oceania. Dove indicato “Nordamerica” si intende Stati Uniti e Canada, per “isole britanniche” si intende Regno Unito ed Irlanda. Se volete aiutarci mantenere aggiornato questo elenco, contattateci.
[references class=”compact”/]
Bibliografia e fonti
- “Official USPS Abbreviations.” U.S. Postal Service. Web. 1-3-2013.
- “Address Standards” IP Australia. Australia Government. 24-2-2014
- “Etymology Of British Place-names.” Bartholomew’s Gazetteer of the British Isle c.a 1900: Rootsweb. Web. 13 Mar. 2014.
- “Street, Road, etc.” The Word Detective.” The Word Detective. Web. 2 Mar. 2013.
- “Street Suffix Abbreviations.” Mbiz. University of Michigan, n.d. Web. 15-3-014.
- “Street designation and suffixes“, Knox County TN
- Online Etymology Dictionary Douglas Harper, Web.
- Word Reference <wordreference.com>
- Dictionary and Thesaurus – The Free Dictionary. Farlex. Web. 1-3-2013.
- Southworth, M e E. Ben–Joseph “Reconsidering the cul–de–sac” in Acces 24, nº24 spring 2004. University of California.
Immagini
- © Ed Kohler – The Deets (courtesy of Ed Kohler) – Flickr.
- sinistra: Friedrichstrasse [CC-BY-SA-3.0 / GFDL] – Commons; destra: L Chadwick [CC-BY-SA-2.0] – Commons.
- © Mick Garratt [CC-BY-SA-2.0] – Geograph.
- Y. Shinyama, 2002, New York [PD] – Commons.
- 2007, Atlantic City [PD] – Commons.
- David Lally, 2007, Nottingham [PD] – Geograph.
- Nuttmeger, 2006, New York [PD] – Commons.
- 1834, da una cartolina dell’epoca [PD] – Commons.
- M. Averette, 2008 [CC-BY-SA-3.0 / GNU-GFDL] – Commons.
- TarHeel4793, New York 25 agosto 2015 [CC-BY-SA 4.0] Commons.
- J. Cormack, 2005, London [CC-BY-SA-2.0] – Commons.
- H. W. Schmitt, 2007 – Commons.
- Nigel Cox, 2008 [CC-BY-SA-2.0] – Geograph.
- Diego Delso, 2006 [CC-BY-SA-3.0] – Commons.
- Ivan Moskalev, 2010 [CC-BY-SA-3.0] – Commons.
- Simon Carey, 2013 [CC-BY-SA-2.0] – Geograph.
- Nutmegger, 31-12-2006 [PD] – Commons.
- Kicior99, 20-5-2008 [PD] – Commons.
- Charles Roscoe Savage, 1890 c.a [PD] – Church History Library, via Commons.
- © Derek Harper, Cullross 17-9-2008 [CC-BY-SA-2.0] – Geograph.
- © Nikater, 1998 [PD] Commons.
Opera tutelata dal plagio su www.patamu.com con numero deposito 21334.
Ultimo aggiornamento: 09-10-2021 — Ultima revisione completa: 7-1-2017

1 – Il faro di Bishop Rock (© J. Rostron).
Autunno del 1707. La flotta della Royal Navy al comando dell’ammiraglio Cloudesley Shovell, di ritorno verso casa dopo aver fornito supporto militare al Principe Eugenio di Savoia nella infruttuosa battaglia per il porto di francese di Tolone,[ref]Battaglia di Tolone del 1707, nell’ambito della guerra di successione spagnola. Eugenio di Savoia (Impero austriaco) tentò di prendere il porto francese di Tolone, con il supporto degli alleati Ducato di Savoia, Repubblica delle Sette Province Unite (più o meno gli attuali Pesi Bassi) e Gran Bretagna, ma gli alleati furono respinti dalle forze franco-spagnole.[/ref] imboccava il Canale della Manica diretta a Londra. Gli ufficiali di rotta ritenevano di essere al sicuro ad ovest dell’isola francese di Ouessant, al largo di Finisterra, ma a causa dei venti del mar Cantabrico che li avevano condotti fuori rotta, della fitta nebbia che li aveva accolti e dell’impossibilità, all’epoca, di calcolare con precisione la longitudine[ref]La determinazione della longitudine è sempre stato uno dei grandi problemi della navigazione, risolto solo tra il XVIII ed il XIX secolo con la determinazione accurata delle effemeridi e la diffusione degli orologi “da marina” (strumento inventato da John Harrison nel 1759) che garantiva una sufficiente precisione anche con in presenza dei movimenti di rollio e beccheggio della nave. Cfr: “La travagliata storia della determinazione della longitudine.” Torino Scienza. (Provincia di Torino) e Murara, Marco “Il problema della longitudine (Prima parte).” Notiziario nº11, inverno 1998, “Il problema della longitudine (Seconda parte).” Notiziario nº12, primavera 1999 (Associazione Astrofili Trentini. Web. 15-12-2013.)[/ref] le navi si trovavano invece sulla rotta per le Scilly. Prima che potessero rendersi conto dell’errore, la flotta andò incontro ad uno dei più grandi disastri navali della storia: quattro navi si sfracellarono sugli scogli ed affondarono, portando con sé forse duemila vite tra cui lo stesso Shovell (che si trovava sulla HMS Association) e l’intero equipaggio di quattrocento uomini della fregata Romney.
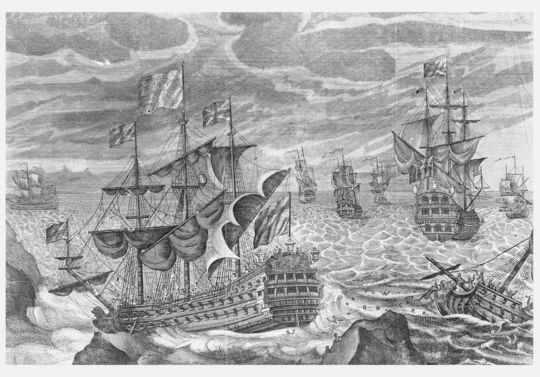
2 – Disastro delle Scilly del 1707: la HMS Association si schianta sugli scogli.
Le Scilly sono un arcipelago all’imbocco occidentale della Manica, ventisette miglia al largo della punta sud-occidentale della Cornovaglia, che viene chiamata Land’s End, fine della terra, proprio come i francesi chiamano Finistère (dal latino Finis terrae, cioè “fine della terra”) l’estrema punta occidentale della Bretagna, sul lato opposto del canale. Ne fanno parte sei isole principali (cinque delle quali abitate) circondate da una costellazione oltre di duecento tra isolotti disabitati e scogli, molti dei quali sommersi con l’alta marea,[ref](PDF) NCA 158: Isles of Scilly Key Facts & Data. Natural England. Pag. 2.[/ref] causa tra l’altro di pericolosi vortici che spingono le imbarcazioni verso le rocce granitiche. All’insidia dei flutti si aggiunga quella delle mappe: sino al 1750 infatti la cartografia riportava le Scilly dieci miglia più a nord,[ref name=”nicholson”]Nicholson, p.113 (op. cit.)[/ref] un errore — perpetuato per secoli dall’usanza di copiare mappe precedenti — che costò molte vite e molte navi. L’arcipelago godeva di una fama sinistra e leggendaria tra i marinai per il numero di incidenti che non ha eguali in nessun’altro punto del Canale. Se il primo naufragio documentato in su quelle rocce risale al 1305,[ref name=”lloyd”]Dai registri Lloyd’s, (cfr.).[/ref] ne seguirono molti altri nei secoli successivi,[backref name=”lloyd” /] in continuo aumento con l’intensificarsi del traffico navale. Si dovette attendere il 1680 perché a St. Agnes — l’isola abitata più ad ovest — venisse costruito un faro a carbone (tuttora esistente seppure inattivo), insufficiente però a coprire l’intero arcipelago: non sarebbe infatti bastato a scongiurare il terribile disastro navale delle Scilly del 1707. La flotta di Shovell si era infatti imbattuta nelle Western Rock, la parte più occidentale e pericolosa dell’arcipelago; una distesa di scogli «terribili a vedersi» — come riporta un libro di idrografia dell’epoca[backref name=”nicholson” /] — nota tra i marinai con l’evocativo nomignolo di «cane delle Scilly»,[backref name=”nicholson” /] una belva pronta ad azzannare le navi di passaggio con i suoi denti di duro granito. L’idea di costruire un faro in quel punto non sarebbe stata presa in considerazione ancora per oltre un secolo, finché, dopo il tragico naufragio della goletta Douro che nel 1843 finì sullo scoglio di Crebawethan trascinando sul fondo del mare tutto il suo equipaggio, la Corporazione di Trinity House, ente britannico per i fari di Inghilterra e Galles, decise che era giunto il momento di illuminare quegli scogli tormentati dal vento e dal mare. Come fare, sarebbe stato un problema dello scozzese sir James Walker (1781 — 1862), ingegnere in capo della Corporazione, membro della prestigiosa Royal Society e già presidente della Institution of Civil Engineers.
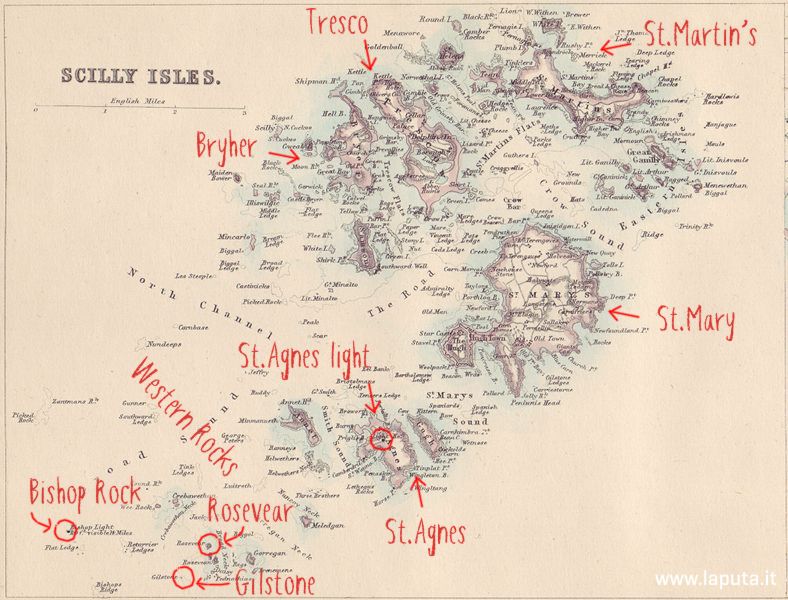
3 – Mappa delle Scilly realizzata nel 1874 da John Bartholomew, sulla quale abbiamo evidenziato le isole principali e i luoghi salienti della storia di Bishop Rock (mappa originale ad alta risoluzione).
Non era un compito facile: la luce sarebbe stata tanto più efficace quanto più vicina al pericolo, così la scelta ricadde su Bishop Rock, uno scoglio di granito rosa lungo quarantasei metri e largo sedici all’estremo occidentale delle Western Rocks, che aveva la fama di aver spedito sul fondo numerose navi. L’origine del nome è incerta: si ritiene che sia stato battezzato così tra il XV ed il XVI secolo dai pescatori delle Scilly, per la forma della roccia ed il colore rosa scuro che ricorderebbero una “mitra”, tipico copricapo da vescovo (bishop, appunto). Una leggenda racconta invece che nel XVII secolo un’intera flotta di navi mercantili sarebbe naufragata sulle rocce.[ref]In effetti dai registri LLoyd’s risulta il naufragio di tre navi il 22 dicembre del 1667 (cfr).[/ref] I soccorsi avrebbero trovato solo due superstiti su due diversi scogli, di seguito battezzati con i cognomi dei naufraghi: Bishop e Clerk.
Il primo faro (1849)
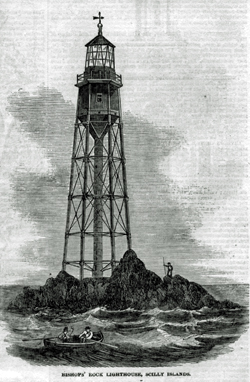
4 – Il primo faro in ghisa, spazzato via dopo pochi mesi (da “Illustrated London News”, 1847).
Si stimava all’epoca che sulle Western Rock si abbattessero almeno trenta tempeste all’anno e Walker calcolò che la spinta del vento sulla muratura avrebbe potuto raggiungere le settemila libbre per piede quadrato (oltre 34 tonnellate per metro quadrato). L’ingegnere ritenne che lo scoglio era troppo piccolo e le forze in gioco troppo grandi per un faro in muratura e che la soluzione migliore fosse quindi una torre a struttura aperta (skeletal tower), che offrisse minore resistenza all’aria, come quella che aveva visto sugli scogli detti “Small”, al largo del Galles (proprio dove sarebbe stato poi chiamato a progettare un nuovo faro nel 1859). Il progetto di Walker prevedeva che la lanterna, con l’alloggio dei guardiani ed il deposito, fosse sostenuta da una colonna prefabbricata in ghisa del diametro di appena sei piedi e tre pollici (poco più di un metro) all’interno della quale una scala a pioli avrebbe consentito di raggiungere i locali. La struttura sarebbe stata sorretta da sei gambe metalliche ancorate alla roccia, legate tra di loro ed alla colonna centrale da tiranti. La supervisione dei lavori fu affidata ad un altro grande ingegnere costruttore di fari, Sir Nicholas Douglass ed a suo figlio James Nicholas (1826-1898) che avrebbe in seguito firmato l’attuale faro di Eddystone (1882). I lavori iniziarono nel 1847 e la torre fu terminata nel 1849 al costo di dodicimila sterline, ma la luce non fu mai accesa: quando i lavori furono sospesi per l’inverno, il gruppo ottico, progettato per una portata di trenta miglia, non era ancora stato installato. Lo si sarebbe fatto la primavera successiva se il 5 febbraio del 1850 una forte tempesta non avesse spazzato via l’intera struttura.
James Walker, per nulla scoraggiato, si rimise al lavoro. Questa volta però abbandonò l’idea della struttura metallica in favore della tradizionale torre in granito, ispirandosi ad un altro faro: quello di Eddystone, progettato da John Smeaton[ref]Il terzo faro costruito in quel punto. Nel 1870 è stato smontato e trasportato a terra, a Plymouth, dove è tuttora conservato come edificio storico (noto come “Smeaton Tower”). Il faro attuale è il quarto, progettato da Douglass.[/ref] quasi un secolo prima (1759). L’anno successivo Walker e Douglass tornarono a Bishop Rock per un sopralluogo e individuarono un punto che avrebbe consentito una base di appoggio di una decina di metri di diametro. Lì sarebbe sorta la nuova torre.
Rosevear Island

5 – Rovine di un cottage del villaggio di Rosevear, abbandonato nel 1858 al termine dei lavori.
Come già si fece per la costruzione del primo faro, fu allestito un insediamento con alloggi per i lavoratori, officina e deposito per i materiali: non sullo scoglio, dove lo spazio era a malapena sufficiente per il cantiere, ma sulla vicina isola di Rosevear,[ref]L’isola deve il nome ad un grande promontorio roccioso che protende verso ovest: Ros Veur, “grande promontorio” in lingua cornica.[/ref] appena due miglia a est di Bishop Rock. Da qui era possibile vedere le condizioni del mare intorno allo scoglio e sfruttare così ogni momento di bonaccia per approdarvi e continuare i lavori. Ancora oggi sull’isola sono presenti i resti delle case in muratura a secco e di una fucina, che fungeva probabilmente da attrezzeria per il cantiere. Se da una parte alloggiare in un cottage su un isolotto disabitato di non più di un ettaro era sempre meglio che in baracche galleggianti come toccava agli operai impegnati in altri fari offshore,[ref]I fari offshore (fuori costa) sono quelli circondati dall’acqua, ad esempio costruiti su uno scoglio o una secca.[/ref] non si può certo dire che stare a Rosevear fosse una villeggiatura: le frequenti mareggiate impedivano ai rifornimenti di raggiungere l’isola, costringendo i lavoratori a nutrirsi di pesca, uova di gabbiano e patelle crude raccolte sulle rocce. Come se non bastasse la natura e l’isolamento, ci si metteva anche un fantasma a tormentare l’isola.[ref]T. Stevens, E. Cummings (in bibliografia)[/ref]
Ann Cargill ed il naufragio del Nancy

6 – Ritratto di Ann Brown nel ruolo di Miranda: dipinto di J. Zoffany, c.a 1770.
Ann Brown, nata nel 1760, era una cantante d’opera molto celebre, giovane e bellissima, le cui numerose fughe amorose scandalizzarono la società londinese del diciassettesimo secolo. Debuttò a soli undici anni ed a ventuno era già al culmine della propria fama con il nome coniugale di Ann Cargill. Nel 1783 fuggì in India per raggiungere il suo nuovo amante, tale John Haldane,[ref]Noto tra i colleghi come “il più sfortunato comandante della Compagnia”: tra le altre cose, la sua nuova nave prese fuoco poco dopo l’arrivo della sua amata. In seguito avrebbe perso la vita nel tragico naufragio del Nancy.[/ref] capitano della Compagnia britannica delle Indie Orientali. A Bombay e Calcutta divenne una vera star, oggi paragonata ad una «Britney Spears del XVII secolo»,[ref name=”BBC”]BBC (in bibliografia)[/ref] ma alla fine di quello stesso anno ne fu ordinato il rimpatrio nientemeno che dal primo ministro britannico William Pitt il Giovane (1759-1806), secondo il quale «un’attrice non doveva contaminare le pure coste dell’India».[backref name=”BBC” /] O almeno così giustificò la propria decisione di fronte al parlamento. Ad ogni modo, Ann non sarebbe mai arrivata in Inghilterra.

7 – Le coste rocciose dell’isola di Rosevear.
Si imbarcò con il figlio di appena quindici mesi sulla nave postale Nancy, diretta a Londra al comando dello stesso Haldane, fidanzato dell’attrice e padre del bambino. Dopo tre mesi di viaggio, la notte del 4 marzo del 1784, il Nancy era ormai giunto all’altezza delle Scilly quando fu colto da una violenta tempesta. Il faro di Bishop Rock non esisteva ancora ed il maltempo impedì all’equipaggio di avvistare quello di St. Agnes. Lo scafo urtò lo scoglio di Gilstone, lo stesso che aveva affondato la HMS Association dell’ammiraglio Shovel nel 1707 (mappa), e fu inghiottito dal mare. Non ci furono superstiti tra le quarantanove persone che si trovavano a bordo: alcuni riuscirono a lasciare la nave con una scialuppa, ma non sopravvissero all’ulteriore naufragio di questa, sbattuta violentemente contro le rocce di Rosevear, dove furono rinvenuti i corpi di diciassette naufraghi.

8 – Il naufragio del Nancy, in un dipinto di James Gilray 1784 (via Scilly Divers).
La stampa dell’epoca riportò una commovente descrizione da tragedia elisabettiana del ritrovamento dell’attrice, morta, con il figlioletto ancora stretto tra le braccia.[backref name=”BBC” /] In realtà però, i primi soccorritori giunti sul posto ignoravano l’identità delle vittime e si limitarono a seppellirle sull’isola disabitata. Solo in seguito alla diffusione della notizia dell’incidente che aveva consegnato Ann Cargill alla leggenda ne furono riesumati i resti, insieme a quelli del capitano Haldane e del figlio, per essere sepolti definitivamente sull’Isola di St. Mary, probabilmente presso la chiesa di Old Town.[ref]T. Stevens, Scillypedia (bibliografia)[/ref] Tutto questo accadde oltre mezzo secolo prima che a Rosevear si insediassero gli operai che avrebbero dovuto costruire il faro di Bishop Rock, tra i quali si sarebbe presto sparsa la voce che sull’isola si aggirasse ancora il fantasma della giovane: molti giurarono di aver udito, tra il rumore del vento e delle onde, la voce di Ann cantare una disperata “ninna nanna” al proprio bambino.[ref]Effetto probabilmente della suggestione e della pareidolia acustica.[/ref]
…the Blacksmith, who was working alone on the island, heard strains of beautiful music and looked for the boats which he first thought must be bringing his comrades back, but none were visible. Whence he knew that the music was not of this world.[ref]Da Stevens, Todd. “The Nancy Packet“. Scillydivers.[/ref]Dal diario di un operaio di Bishop Rock, 1852.
Il cantiere
Il “fantasma” non era certo il problema più grosso: il frequente maltempo rendeva spesso inaccessibile il sito e le improvvise mareggiate potevano cogliere di sorpresa gli operai. Della direzione dei lavori furono incaricati gli ingegneri Nicholas e James Douglass, padre e figlio. Fu quest’ultimo, più giovane e disposto all’adattamento, a garantire una presenza costante in cantiere ed una stretta vigilanza sui lavori. Ma non solo: James viveva a Rosevear con gli operai, condividendone l’isolamento, il cibo scarso ed i miseri alloggi. Non esitò nemmeno a lanciarsi nelle gelide acque dell’Atlantico insieme ai “suoi” uomini per soccorrere un compagno finito in mare, guadagnandosi così la stima ed il rispetto dei lavoratori.
La prima fase dei lavori fu la più complessa, lo scoglio era continuamente spazzato dalle onde e le prime pietre dovevano essere posate circa un piede sotto il livello minimo di marea; per consentire agli operai di lavorare all’asciutto fu quindi costruito un massiccio argine circolare intorno al basamento, dall’interno del quale fu poi tolta l’acqua. I blocchi grezzi di granito della cornovaglia, provenienti dalle cave di Lamorna e Carnsew, giungevano via mare sull’isola di St.Mary’s dove venivano lavorati, quindi nuovamente imbarcati alla volta dell’isolotto di Rosevear su un buoy tender,[ref]Buoy Tender: un tipo di nave utilizzato per l’installazione e la manutenzione di fari, boe e segnali marittimi in genere.[/ref] il Billow, o su convogli di chiatte trainate da un rimorchiatore a vapore ribattezzato per l’occasione Bishop. Qui i blocchi, del peso variabile tra una e due tonnellate, venivano rifiniti e numerati per essere infine inviati allo scoglio dove venivano assemblati con incastri a coda di rondine su tutti i lati, conferendo alla torre una compattezza monolitica.
Il secondo faro (1858)
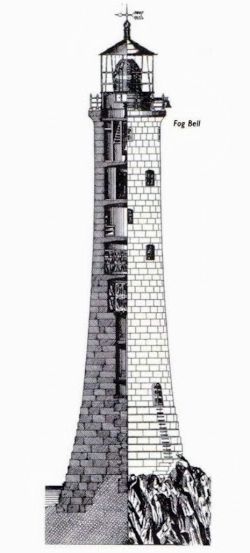
10 – Il secondo faro, ultimato nel 1858.
Malgrado superstizioni, carenza di cibo e tempeste i lavori proseguirono quanto più regolarmente fosse possibile, ma ci vollero sei anni di lavoro e duemilacinquecento tonnellate di granito per completare l’opera. Era una costruzione massiccia ma elegante, a “fusto di quercia”, come il faro costruito un secolo prima a Eddystone da John Smeaton ma più grande, alta complessivamente trentacinque metri.[ref]Inclusa la “lanterna”, il locale finestrato che alloggia tutto l’apparato ottico del faro, alta 28 piedi (circa 8,5 m) e del diametro di 14 (oltre 4 metri).[/ref] Finalmente, il primo di settembre del 1858 una luce bianca fissa, visibile a 14 miglia di distanza, fu accesa per la prima volta in cima al faro di Bishop Rock. L’impresa fu salutata come una grande conquista dell’ingegneria britannica: i Commissari Reali che visitarono il faro l’otto di settembre lo definirono «magnifico, e forse il più esposto al mondo». Anche il principe consorte Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, marito della Regina Vittoria, scrisse alla Corte degli Elder Brethren (il consiglio direttivo di Trinity House) che la torre sarebbe stata considerata «un trionfo di abilità tecnica e perseveranza».
Nonostante le lodi e la indiscussa solidità, il faro non ebbe sin da subito vita facile: il 30 gennaio del 1860, poco più di un anno dopo l’inaugurazione, la torre dovette affrontare una delle più violente tempeste nella storia dell’arcipelago. La forza dell’acqua fu tale da crepare i blocchi di granito pochi metri sopra il livello dell’alta marea; la scala a pioli in metallo, imbullonata all’esterno della torre, fu spazzata via e mai più ritrovata. Il fatto più inquietante fu però che le onde riuscirono a strappare la campana del segnale da nebbia del peso 550 libbre,[ref]250 chilogrammi circa.[/ref] sospesa appena sotto la lanterna ad una trentina di metri di altezza.[ref]La campana finì in pezzi sulle rocce sottostanti, uno dei frammenti fu ritrovato ed è conservato al museo di Trinity House.[/ref]
Ma quello era solo l’inizio. Il 20 aprile del 1874 un’altra violenta tempesta si abbatté sulle Scilly, onde alte fino a trentacinque metri colpivano il faro facendolo ondeggiare pericolosamente; i guardiani, che vedevano le onde superare le finestre della cucina a venti metri di altezza, temettero il disastro. Al termine della tempesta le vetrate della lanterna erano rotte, le lenti di Fresnel erano spaccate in trenta pezzi, la sabbia del fondale fu ritrovata sulla “galleria” (la balconata) e nuove crepe erano comparse sul basamento dell’edificio. La struttura era ormai compromessa: la malta che legava i blocchi era stata erosa dal continuo impatto delle onde e l’acqua salata penetrava le fessure. L’edificio fu rinforzato con pesanti tiranti in ferro che correvano internamente da cima a fondo ma nel 1881 una mareggiata causò il distacco di una grossa scheggia di granito, mettendo in discussione l’efficacia del consolidamento. Nello stesso anno Sir James Douglass effettuò una approfondita ispezione dell’edificio, rilevando gravi danni strutturali ed individuando il punto debole nel basamento: era necessario un intervento radicale, e il padre Nicholas Douglass suggerì di ricostruire il faro, inglobando però l’esistente in una nuova torre più alta e più larga.
Il terzo faro (1877)
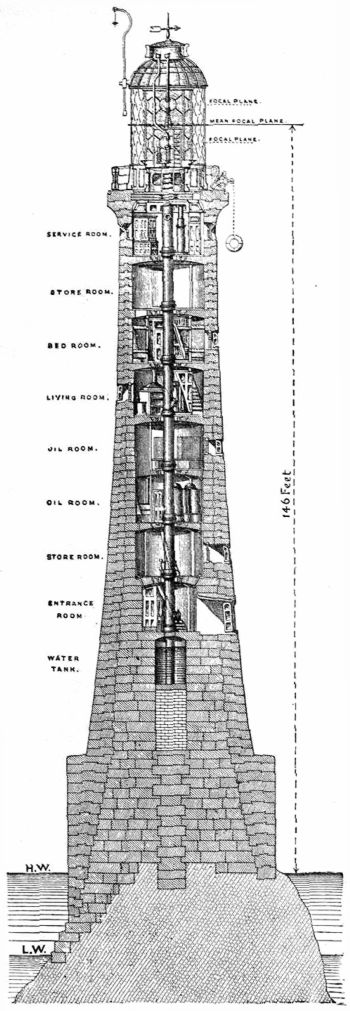
11 – Sezione del terzo faro del 1887 (da Encyclopaedia Britannica, 1910-11)
La supervisione dei lavori fu affidata all’ingegnere William Tregarthen Douglass (1857–1913), nipote di Nicholas Douglass, figlio di James ed ingegnere in capo di Commissioners of Irish Light, l’ente per i fari d’Irlanda. Questa volta gli uomini non avrebbero più dovuto soffrire l’isolamento di Rosevear: il campo base fu infatti allestito sull’isola abitata di St. Mary, la più estesa dell’arcipelago, dove furono trasferiti gli equipaggiamenti utilizzati dal padre James per la costruzione del quarto faro di Eddystone (completato nel 1882), compreso il rimorchiatore a vapore Hercules. Qui i blocchi di granito cornico, provenienti dalle storiche cave De Lank vicino a St. Breward[ref]Stainer, Peter. “The De Lank Granite Quarry.” Mining History: the bulletin of Peak District Mines Historical Society, Vol.13 n°2, Winter 1996: pag. 42-46. Web. 1-2-2014.[/ref] sarebbero stati lavorati e sagomati prima di essere imbarcati sull’Hercules per il viaggio di sette miglia verso Bishop Rock.
Il 25 maggio del 1883 iniziarono i lavori per la nuova torre durante i quali, a rendere tutto ancor più complesso, la luce doveva restare accesa. Fu costruito un enorme basamento cilindrico su cui le onde si sarebbero infrante, dissipando parte della propria forza, prima di colpire il faro. Questo fu rivestito con un nuovo strato di blocchi di granito, sagomati in modo da incastrarsi l’un l’altro e con le scanalature accuratamente incise sulla superficie della torre esistente, a formare una massa inamovibile. Il cantiere diretto da William Douglass rappresentò per l’epoca un notevole progresso in termini di sicurezza: pur non essendoci lo spazio per una vera impalcatura, gli operai lavoravano su pedane in legno sorrette da staffe ed assicurati mediante corde ad una robusta catena disposta intorno alla torre[ref]Un sistema analogo a quello che oggi, in edilizia, viene definito linea vita.[/ref] Ad ulteriore assicurazione, tutt’intorno fu predisposta una rete di manilla[ref]La manilla o “canapa di Manila” è una fibra tessile particolarmente resistente all’acqua salata, e per questo motivo utilizzata per la fabbricazione di funi ad uso nautico e reti da pesca. Si ottiene dalle foglie di abacà (Musa textilis).[/ref] che avrebbe impedito agli uomini di cadere sulle rocce o in acqua, eventualità quest’ultima non meno pericolosa della prima. Queste misure, oltre a ridurre il rischio di incidenti, ebbero l’effetto di migliorare la produttività del cantiere: gli operai infatti, più sicuri e meno preoccupati di essere trascinati in mare da ondate improvvise, lavoravano meglio e più in fretta. Ci sarebbero comunque voluti tre anni, nonostante il mare fosse stato particolarmente clemente nell’estate del 1884, perché i nuovi blocchi arrivassero all’altezza della galleria inglobando così completamente la vecchia torre.
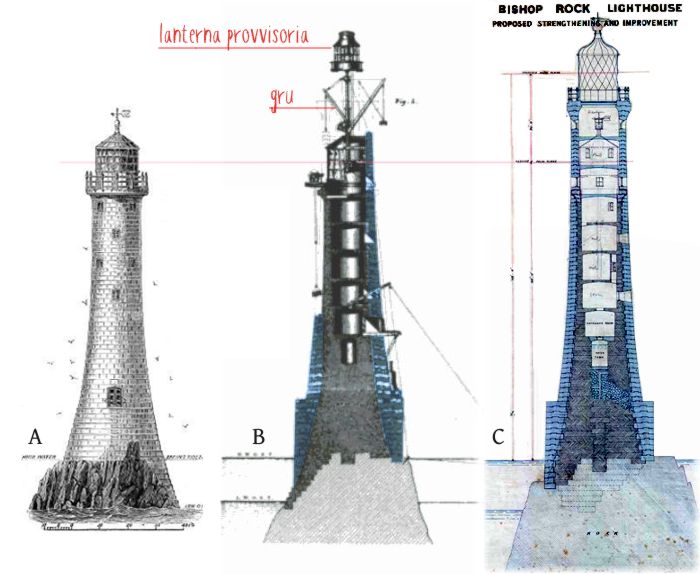
12 – Fasi della trasformazione del faro di Bishop Rock: A) faro originario ultimato nel 1858 (stampa del XIX secolo); B) cantiere: si noti la lanterna provvisoria in cima alla gru (Institution of Civil Engineers); C) Il nuovo faro ultimato nel 1887 (in azzurro le parti nuove, dai disegni originali di James Douglass, 1881).
![© David Lally [CC-BY-SA-2.0] Bishop Rock](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2014/02/3658745_f2a20cef-198x300.jpg)
13 – Il faro di Bishop Rock oggi
(© D.Lally).
Da questo punto in poi iniziava la parte in elevazione ed il lavoro sarebbe stato più semplice e più spedito, senonché l’innalzamento della torre avrebbe oscurato la lanterna. Questa fu quindi smontata nel maggio del 1886 ed al suo posto fu eretta una gru a colonna in ferro battuto alta quaranta piedi (circa 12 m), in cima alla quale fu installata una lanterna provvisoria (immagine 12-B) del tipo utilizzato sulle navi faro di Trinity House, garantendo così la continuità del segnale.[ref]La lampada aveva 6 bruciatori con un potenza complessiva di sedicimila candele.[/ref] La gru, con tutto l’apparato luminoso, veniva sollevata mano a mano che i lavori progredivano: una tecnica analoga a quella utilizzata nella costruzione dei moderni grattacieli[ref]La gru in grado di “crescere” con l’edificio è detta rising crane o climbing crane (gru rampante).[/ref] e che consentì di ultimare la torre entro la fine di agosto, posando le ultime 28 ricorse di muratura in poco più di due mesi. In tre anni e mezzo erano stati posati 3220 tonnellate di granito, più del peso della torre originaria, la quale era diventata parte collaborante della struttura per una massa complessiva di 5700 tonnellate.
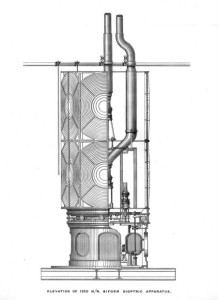
14 – Progetto della doppia ottica Fresnel di Bishop Rock realizzata dalla Chance Brothers di Birmingham. La fila superiore di lenti è stata rimossa nel 1992.
Restava da completare la lanterna: Trinity House volle coronare il successo di un’impresa tanto ardita con il più avanzato e potente apparato luminoso che fosse all’epoca disponibile. Grazie alla nuova doppia lampada da duecentotrentamila candele,[ref]20 bruciatori a olio compustibile di tipo “Douglass” disposti su due livelli.[/ref] alla pesante ottica Fresnel su due livelli azionata da un motore elettrico[ref]All’epoca per fare ruotare l’ottica dei fari venivano utilizzati motori ad orologeria, come quelli dei campanili. Il peso della nuova ottica era tale che fu necessario ricorrere ad un motore elettrico da 1/2 HP.[/ref] ed all’innalzamento a 144 piedi del piano focale, il caratteristico segnale — due lampi bianchi ripetuti ogni 29 secondi — era visibile fino ad una distanza di ventinove miglia nautiche. La campana da nebbia fu sostituita da un nuovo tipo di segnale sviluppato da Trinity House, un corno esplosivo a cartucce di nitrocellulosa.[ref]”Fog Horn Mk I”. Il segnale esplosivo è stato in seguito sostituito con un corno tradizionale, dismesso nel 2007.[/ref] Questi miglioramenti, insieme al consolidamento della torre, secondo Trinity House avrebbero portato Bishop Rock «al più alto rango dei fari in pietra». Ci volle un altro anno per completare i lavori e la nuova luce fu finalmente accesa il 25 ottobre del 1887. Il faro da allora è rimasto attivo e sostanzialmente immutato: l’unica modifica visibile è l’elisuperficie sopra alla lanterna, realizzata nel 1977, che consente l’accesso all’edificio tramite elicottero. Solo la lampada elettrica ha sostituito, nel 1973, i bruciatori ad olio combustibile mentre l’ottica è ancora quella realizzata alla fine del XIX secolo dalla vetreria Chance Brothers di Birmingham, cui sono state rimosse le lenti superiori nel 1992.[ref]Tag, Thomas. “The Lens at the Bishop Rock, England.” Hyper-radial Lenses. 30 gen. 2010. Web. 3-2-2014.[/ref] Da quell’anno il faro è automatizzato e non richiede più il presidio del personale, che può più confortevolmente soggiornare a terra. William Threatened Douglass aveva vinto una lunga sfida con il mare, iniziata quarant’anni prima dal nonno Nicholas e dal padre James: il suo faro oggi è ancora lì, a presidiare con il suo fascio di luce uno dei tratti di mare più pericolosi al mondo. [endmark]
![© John Davey [CC-BY-SA-2.0] Bishop_Rock_from_Periglis_Bay_-_geograph.org.uk_-_355576](https://www.laputa.it/wp-content/uploads/2013/03/Bishop_Rock_from_Periglis_Bay_-_geograph.org_.uk_-_355576.jpg)
15 – Il faro di Bishop Rock in lontananza e le Western Rocks, dalla baia di Periglis, sull’isola di St. Agnes.
(© John Davey)
Blue Riband

16 – Il faro di Ambrose, nella baia di New York. Smantellato nel 2008 e sostituito da una boa, era il punto di arrivo del trofeo “Blue Riband”.
Il “Nastro Azzurro dell’Atlantico” o “Blue Riband” è un trofeo che dal 1910 viene attribuito alle navi passeggeri che, in servizio regolare e senza rifornimenti, registrano il primato di velocità media nell’attraversamento dell’Atlantico da Est a Ovest, navigando contro la corrente del Golfo. Dal 1935, anno in cui il trofeo fu ufficializzato,[ref]Su proposta del parlamentare britannico Harold Hales, per questo detto anche “Hales Trophy”.[/ref] i punti di partenza e di arrivo per il calcolo della velocità media sono proprio il faro di Bishop Rock e, dall’altra parte dell’Atlantico, il faro di Ambrose nella baia di New York. Il regolamento prevede che la nave possa fregiarsi del nastro azzurro solo infrangendo il primato del precedente vincitore, il che rende via via più difficile ottenere il trofeo. L’ultimo “Blue Riband” da Est a Ovest è stato assegnato nel 1952 alla nave americana SS United States che registrò una velocità di 34,51 nodi (63,91 km/h) effettuando la traversata in 3 giorni, 12 ore e 12 minuti. Esisteva anche il record in senso contrario, detto “Eastbound”, considerato viceversa dal faro di Ambrose al faro di Bishop Rock: tale primato non dava però diritto al “Blue Riband”. Anche questo record è detenuto dalla United States con 65,91 km/h.

17 – La SS United States, vincitrice del trofeo “Blue Riband” nel 1952 e primatista della traversata “Eastbound”.
Note
[references class=”compact” /]
Bibliografia e fonti
- Nicholson, Christopher P. “Bishop Rock.” Rock Lighthouses of Britain.
Toronto: Dundurn, 1995. 113-126.
- Mariotti, Annamaria. “Bishop Rock.” Fari. Vercelli: White Star, 2009. Pagg. 84-87.
- Otter, R. A. “Bishop Rock Lighthouse.” Civil engineering heritage: Southern England
. London: Published for the Institution of Civil Engineers by Thomas Telford, 1994. P. 5.
- “Bishop Rock.” Trinity House. Corporation of Trinity House and Depford Strond, Web. 15-12-2013.
- Skempton, A. W. “Walker, James.” Biographical Dictionary of Civil Engineers in Great Britain and Ireland: 1500-1830
. London: Thomas Telford, 2002. 755-756.
- Larn, Richard & Bridget Larn. Shipwreck index of the British Isles. London: Lloyd’s Register of Shipping, 1995.
- “Bishop Rock Lighthouse.” Engineering Timelines. Web. 21-12-2013.
- Rowlett, Russ. “Lighthouses of Southwest England.” The Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill. Web. 15-12-2013.
Ann Cargill ed il naufragio del Nancy
- Stevens, Todd e Edward Cumming. Ghosts of Rosevear: And the Wreck of the Nancy Packet
. 2a ed. Glasgow [Scotland]: Brown, Son & Ferguson Ltd, 2009.
- Stevens, Todd. “The Search for the Nancy Packet, Rosevear Ledge, Scilly.“ Scillypedia – Encyclopedia of the Isles of Scilly. N.p., 29 Apr. 2012. Web.
- “A Scandalous Star.” BBC News. BBC, 18 Sett. 2008. Web.
- “Diva famous again in death – The last season of a British singing sensation in Calcutta.” The Telegraph [Calcutta – Kolkata] 20 Sett. 2008, Calcutta (India), pag. 1. telegraphindia.com. Web.
Immagini
- © John Rostron, 6-12-2009 [CC-BY-SA-2.0] via Geograph;
- Incisione del XVIII secolo [PD] da Commons;
- John Bartolomew, 1874, originale da Commons;
- 1847, da Illustrated London News via Scillypedia;
- © David Lally, Scilly 12-11-2012 [CC-BY-SA-2.0] via Geograph;
- Johan Zoffany, c.a 1770. Olio su tela, conservato al Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid. Via Allart gallery.
- © Richard Knights, 5-8-2005 [CC-BY-SA-2.0] via Geograph;
- James Gilray, 1784 (courtesy of Todd Stevens), via scillydivers;
- 1900 [PD] da Life of Sir James Douglas;
- stampa del XIX secolo, autore sconosciuto (courtesy of Bob Scotney)
- 1910-11 [PD] Encyclopaedia Britannica 11th Ed., Vol. 16, parte 6 (Project Gutemberg)
- © S.Dell’Acqua. Contiene immagini tratte da:
- Stampa del XIX secolo, autore sconosciuto;
- da Minutes of the Proceedings Institution of Civil Engineers vol. 108, 1891-1892. England: Institution of Civil Engineers, 1891.
- James Douglass, disegno originale per il nuovo faro, tavola n°2. Datato 26 maggio 1881 (Trinity House).
- © David Lally, 17-7-2005 [CC-BY-SA-2.0] via Geograph;
- Chance Brothers, 1887 c.a (courtesy of Thomas Tag) via Hyper-Radial Lenses;
- © John Davey, St.Agnes 14-9-2006 [CC-BY-SA-2.0], via Geograph;
- NOAA [PD]
- State Library of Queensland;