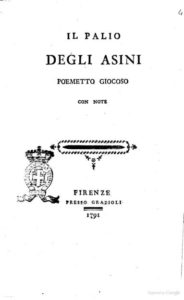tendenza a sminuire o deviare la discussione di un problema specifico e contingente mettendola pretestuosamente a confronto con argomentazioni più generiche e sostenendo la priorità di queste ultime rispetto all’argomento iniziale: deriva dall’espressione “ben altro”, rafforzativo di altro, con il suffisso –ismo che evoca dottrine, atteggiamenti e comportamenti. Il termine benaltrismo è stato diffuso dal giornalista e scrittore Gianni Mura che ne fece ampio uso nella sua rubrica sportiva domenicale “Sette giorni di cattivi pensieri” pubblicata dal 1976 sul quotidiano La Repubblica.
Ebbi contro i cosiddetti “benaltristi”, quelli che qualsiasi cosa tu voglia fare ti dicono “Ci vuole ben altro!”.
Corriere della Sera – Magazine 08/09/2005
Nel dibattito socio–politico la retorica benaltrista consiste nel sostenere ottusamente (o faziosamente) l’inutilità della soluzione di un determinato problema rinviandone la causa a un generico “ben altro”, ovvero che il problema in questione non sia altro che la conseguenza di una problematica più ampia su cui sarebbe quindi prioritario intervenire. Esistendo sempre, di fatto, un problema più importante o una soluzione più radicale, il benaltrismo sposta indefinitamente la discussione su argomenti sempre più generici e teorici (v. anche supercazzora) portando inevitabilmente all’inerzia e al “nulla di fatto” (→gattopardismo). In politica è anche un modo per sviare un discorso sgradito, o anche di ottenere maggiore consenso portando la discussione su argomenti qualunquisti e populisti, più sentiti dalla “pancia” del paese (→ggente), senza dover arrivare necessariamente ad una soluzione.
- Bartezzaghi, Stefano Non se ne può più.
Milano: Mondadori, 2012.
- “benaltrismo” La Repubblica. Web.
- “benaltrismo” Una parola al giorno. 29 Set. 2013, Web.
- Elemento, Fabio “benaltrismo” Fallacielogiche.it 5 Mag. 2013. Web.
- Giumelli, R. “L’italia malata di benaltrismo” La Voce di New York. 15 Mag. 2014, Web.
Immagine: succo/Pixabay.
paese della cuccagna, luogo immaginario di abbondanza e ricchezze per antonomasia (anche metaforicamente), pacchia:
«Un piccolo “bengodi” inglese durante lo sciopero minerario»
Corriere della Sera, martedì 9 marzo 1927, pag. 5.
Il termine è formato per composizione dall’avverbio bene e da godi, imperativo del verbo “godere”. L’immaginario Paese di Bengodi della contrada di Berlinzone è descritto da Giovanni Boccaccio come un paese della cuccagna nella III novella dell’VIII giornata del Decamerone (1351), intitolata “Calandrino e l’elitropia”:
«Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra de’ Baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce e avevasi un’oca a denaio e un papero giunta; ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva; e ivi presso correva un fiumicel di vernaccia, della migliore che mai si bevve, senza avervi entro gocciola d’acqua.»
La descrizione del Paese del Bengodi è di Maso del Saggio che, insieme a Bruno e Buffalmacco, si burla del credulone Calandrino il quale, attratto dal meraviglioso paese e in particolare dall’abbondanza di una pietra che rende invisibili (l’elitropia), si mette vanamente alla sua ricerca.
Espressione analoga è →eldorado.
- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 220. ISBN 88–08–08878–2
- “Cuccagna e Bengodi“, Taccuini Storici. Web.
Immagine: 1916, John William Waterhouse, The Decameron (Commons).
nel gergo militare piccola fortificazione in cima ad una altura (un monte, un colle, uno scoglio); nell’uso comune casa vecchia e disagiata, fatiscente:
La bicocca era isolata, appollaiata in cima alla rupe; un profondo silenzio regnava tutto intorno.
L. De Kerany, Guardiani del faro (Salani, 1941)
Anticamente la bicocca era una roccaforte o un piccolo castello in cima ad un’altura o comunque un luogo elevato, probabilmente dallo spagnolo bicoca (o bicoco) che indicava la garitta di vedetta, a sua volta dal germanico biche, punta (da cui anche l’italiano “picco”):

Vocabolario Italiano e Spagnolo (Franciosini), 1706.
Il quartiere milanese di Bicocca prende infatti il nome da un castelluccio chiamato “Bicocca degli Arcimboldi” (sotto), dimora di campagna della famiglia Arcimboldi di Parma, costruito intorno al 1450 durante la Repubblica Ambrosiana (1447 — 1450).

Milano, la “Bicocca degli Arcimboldi” ai primi del ‘900.
L’edificio dette il nome anche ad una sanguinosa battaglia che si combattè nelle sue vicinanze il 27 aprile del 1522, ricordata appunto come la “battaglia della Bicocca”, durante la IV Guerra d’Italia (1521 — 1526). Nella Bicocca alloggiavano gli uomini di Prospero Colonna (1452 — 1523), condottiero al servizio della Spagna. L’esercito spagnolo di Carlo V d’Asburgo sconfisse le forze francesi di Francesco di Valois, che contarono oltre tremila caduti: da questa disfatta, preludio alla definitiva sconfitta della battaglia di Pavia del 1525, nacque il detto francese «c’est una bicocque», per indicare un luogo di scarso valore strategico a fronte dello sforzo per conquistarlo. Così racconta infatti lo storico milanese Pietro Verri (1728 – 1797):
La battaglia della Bicocca è rimasta nella memoria de’ Francesi, i quali per significare che un sito costerebbe molto sangue, e gioverebbe poco acquistandolo, soglion dire: “c’est une bicocque”. La conseguenza di tal giornata fu che i Francesi intieramente perdettero il Milanese.
Pietro Verri, Storia di Milano, 1798 – Tomo II, cap. XXIII pp. 186-189
Per estensione, bicocque divenne anche sinonimo di “postaccio”, “baracca”, pur mantenendo il significato originale di “castelluccio” riportato ancora nel 1802 dal Dizionario Francese–Italiano di J.L.B. Cormon e V. Manni:
Ciò contribuì, anche in italiano, allo slittamento semantico dal significato di “fortificazione”, “edificio su un’altura” proprio del lessico militare a quello di “casupola misera e cadente” nel linguaggio comune. Curiosamente per gli spagnoli, che invece alla Bicocca avevano vinto, il termine bicoca assunse il significato opposto, ossia di facile vittoria, di qualcosa conquistato senza sforzo.

Gli stabilimenti Pirelli alla Bicocca, 1922.
La Bicocca di Milano

Quartiere Bicocca a Milano (© teotelloli/Fotolia).
Dagli inizi del Novecento quello che oggi è il quartiere Bicocca divenne il centro dell’area industriale che si era rapidamente costituita nella zona tra il comune di Greco e Sesto San Giovanni, luogo simbolo dell’industrializzazione della Lombardia ed elemento trainante dell’economia italiana: fu sede degli stabilimenti Pirelli (che ebbe la propria sede proprio nella Bicocca degli Arcimboldi), Ansaldo, Breda; nel 1929 vi fu costruito il Centro Traumatologico Ortopedico. A partire dagli anni ’70 ebbe inizio una fase di deindustrializzazione dell’area e delocalizzazione delle industrie esistenti, che aprì un dibattito sul recupero e la conversione delle vaste aree dismesse. Il progetto di riqualificazione, caratterizzato da incertezze strategiche e da lunghi corsi decisionali, fece della Bicocca una «zona di trasformazioni per antonomasia» (Dell’Acqua–Pavone, op. cit.). Oggi la Bicocca è un quartiere di residenze ed uffici, vi si trova l’Università degli Studi di Milano–Bicocca (fondata nel 1998) e del Teatro degli Arcimboldi (2002).
La Bicocca di Novara
Anche il quartiere sud–est di Novara è chiamato Bicocca e prende il nome dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria alla Bicocca, così detta perché inizialmente cosisteva in una piccola cappella (detta “degli Spagnoli”) edificata dopo la metà del XVI secolo a servizio di un piccolo sobborgo. Anche questa località dette il nome ad una battaglia, quella di Novara detta anche “della Bicocca” combattuta il 23 marzo del 1849: fu lo scontro decisivo della Prima guerra d’indipendenza italiana durante il Risorgimento, vinto dalle forze austriache del maresciallo Josef Radetzky contro l’armata piemontese del generale polacco Wojciech Chrzanowski. Così racconta lo scrittore Tommaso Arabia nel 1847:
Caduta Mortara, il generale in capo [gen. Michele Bes, ndr] pensò a raccogliere tutte le sue schiere intorno a Novara aspettando gli austriaci in prossimità di una cascina denominata la Bicocca. […] Radetzki in persona […] scaglia tutte le sue forze contro la Bicocca e si impadronisce del Castellazzo e della Farsata. Chrzanowski chiama tutte le riserve e ordina di assalire da tutti i lati gli imperiali; ordina al Duca di Genova di ripigliare la Bicocca, ma le due prime brigate non vollero combattere, ed il Principe potendo raccogliere a stento fra tanti fuggiaschi tre battaglioni, fu costretto a retrocedere.
Tommaso Arabia, La Nuova Italia e la sua costituzione: studii (Napoli: Saverio Starita, 1847). Pag. 127.
- Pianigiani, Ottorino “bicocca” Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana <etimo.it>
- “Il significato di Bicocca” Residenza Arcimboldi.
- Franciosini, Lorenzo Vocabolario Italiano e Spagnolo, II Parte. Presso gli Associati, 1706. Pag. 96.
- Cormon, J.L.B, V. Manni Dizionario Francese-Italiano
. Lione: B. Cormon e Blanc libraj, 1802. Pag. 69.
- “Bicocca” Dizionario De Mauro. <internazionale.it> Web.
- Dell’Acqua, Marco e Giuliano Pavone “Perché il quartiere della Bicocca si chiama così?” in 101 perché sulla storia di Milano che non puoi non sapere. Roma: Newton Compton, 2015. Pag. 35–36. ISBN 978-8854184404
- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 47. ISBN 88–08–08878–2
- Bolocan Goldstein, Matteo. Trasformazioni a Milano: Pirelli Bicocca direttrice nord-est. Milano: FrancoAngeli editore, 2002. ISBN 978-8846442130
- Grisoni, F. “La Bicocca e la sua battaglia” Il Portale. 22 Mag. 2014. Web.
Foto in alto: LalalaB/Pixabay.
(sostantivo maschile) localismo emiliano e in particolare di Ferrara, Reggio Emilia, Modena e Parma per ghiacciolo, dolce freddo da passeggio costituito di acqua con sciroppo aromatico fatta gelare su uno stecco in legno. Deriva dal nome di un produttore locale di ghiaccioli, la ditta “BIF” di Cavriago (Reggio Emilia) fondata nel 1960, così chiamata dale iniziali dei cognomi dei soci (Biada-Iori-Fornaciari[1]); l’acronimo è poi diventato comune per i ghiaccioli di qualunque produttore. A Bologna i ghiaccioli erano invece detti →cof.
La domenica passava il gelataio col carrettino. Io racimolavo cinquanta lire per due gusti nel cono. Oppure il bif al bar della cooperativa. Ma se prendevo il gelato, non potevo concedermi il ghiacciolo.
Zucchero Fornaciari, Il suono della domenica (Mondadori 2013). Pag. 286.
A Reggio Emilia, se volete un ghiacciolo, potete chiedere un «Bif».
Basini, Lugli e Segreto (a cura di), Produrre il mondo… (Laterza, 2013) op. cit.
Non si ricordò nemmeno che mi aveva promesso un ghiacciolo, un bif, per noi ferraresi.
Arnaldo Ninfali Scandalo ’60 — Ritorno a Ferrara (Amazon, 2016) Pag. 118.
I ghiaccioli prodotti dalla ditta BIF potevano avere, sullo stecco in legno, un’iscrizione stampigliata a fuoco che dava diritto a ricevere gratuitamente un altro ghiacciolo:
A spiegare, fu un ghiacciolo BIF che, miracolosamente, era per ben due volte risultato riportare la scritta marchiata a fuoco, con la quale ne avanzavi immediatamente un altro senza pagare…
Francesco Guccini Vacca d’un cane (Feltrinelli, 1994) Pag. 112.
- [1]Basini et al. op. cit.↩
- Basini, Gian Luigi, Giampiero Lugli e Luciano Segreto (a cura di) Produrre il mondo: l’industria reggiana dalla crisi petrolifera alla globalizzazione. Bari: Laterza, 2005. Pag. 419. ISBN 978-8842076476.
Foto in alto: © patronestaff/Fotolia
diminutivo di biliardo, dal francese billard a sua volta da bille, “palla”; comunemente sinonimo di calciobalilla. Attestato dal 1940, con il termine biliardino si definiscono però diversi tipi di tavoli per giochi che prevedono l’uso di “bilie” o palle:
- tavolo da biliardo di dimensioni ridotte e dotato di buche, sul quale si gioca il biliardo americano o pool, specialità del biliardo sviluppatasi in nordamerica e diffusasi in tutto il mondo in diverse varianti. Accezione originaria e considerata più appropriata del termine “biliardino”.
- tavolo da calciobalilla, gioco che simula il calcio, costituito da un cassone rettangolare che riproduce un campo da calcio in miniatura, dotato di barre trasversali alle quali sono fissate piccole sagome rigide di legno o plastica dette “omini” o “ometti”; per estensione o metonimia, anche il gioco stesso. Nel calciobalilla, da due a quattro giocatori divisi in due squadre manovrano le barre tramite manopole in modo da colpire una pallina del diametro di 32–34 mm con lo scopo di mandarla nella porta avversaria. Per quanto considerata impropria, è l’accezione più comune nel linguaggio corrente.
- tavolo per il gioco della bagatelle (francese), in italiano bagatèlla o bagattèlla, gioco di biglie popolare in Francia durante il regno di Luigi XIV, consistente in un piano di gioco in legno con buche buche e pioli, sul quale i giocatori devono mandare le biglie nelle buche per mezzo di un bastoncino simile ad una piccola stecca da biliardo, evitando i pioli.
- biliardino o “biliardo giapponese” (inventato in realtà in Europa nel XVIII secolo ma simile al pachinko giapponese), gioco da sala derivato dalla bagatelle e antenato del flipper, costituito da un semplice piano inclinato sul quale venivano fatte scorrere dall’alto delle biglie d’acciaio, lanciate manualmente o per mezzo di un pistone a molla, le quali finivano più o meno casualmente dentro buche o passaggi obbligati ai quali corrispondevano determinati punteggi.
- biliardino elettrico o elettromeccanico noto anche come flipper; gioco di abilità a moneta per giocatore singolo diffuso dalla fine degli anni 1950 in bar e locali pubblici.

1- pool o biliardo americano

2 – calcio balilla o biliardino

3 – bagatelle

4 – biliardo giapponese, antenato del flipper

5 – flipper o pinball, detto anche “biliardino elettrico” (solitamente a gettone)
1: tavolo da pool o “biliardino” (foto di C. SHII su Unsplash). 2: tavolo da “calciobalilla” o “biliardino” (foto di Kelly Sikkema su Unsplash). 3: tavolo da bagatelle (N. Tysoe, UK/Commons CC BY 2.0). 4: tavolo da “biliardo giapponese”, Germania XVIII secolo (Wuselig/Commons PD). 5: tavolo da pinball o biliardino elettrico, noto anche come “flipper” (foto di Patrick Von su Unsplash).
-
Gelli, Jacopo Giochi e passatempi. Milano: Hoepli, 1989. Pag. 24.
- “biliardino” in Pianigiani Ottorino, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana (1907).
- “biliardino” in Vocabolario online. Treccani. Web.
- “biliardino” in Sinonimi e contrari. Treccani. Web.
- “biliardino” in Il Sabatini Coletti dizionario della lingua italiana. Corriere della Sera. Web.
- “biliardino” in Il Nuovo De Mauro. Internazionale. Web.
Foto in alto:Kelly Sikkema su Unsplash
scritto anche bimbominkia, s.m. (f. bimbaminchia) spregiativo, adolescente dal comportamento stupido e infantile e/o il cui stile di vita è basato sull’adesione alle mode convenzionali e sull’uso smodato di social network, chat e messaggistica: i bimbiminchia sono «quei ragazzi nati a cavallo tra gli anni novanta e duemila che se da un lato vivono sempre connessi, completamente assorbiti da ipod, smartphone e social network, dall’altro rischiano di rimanere per sempre sconnessi, scollegati, dalla realtà» (A. Pecora in Che Futuro! op. cit). Per estensione, chiunque si comporti in modo stupido, fastidioso, insolente. Il termine è formato per composizione dal sostantivi bimbo, che allude ironicamente alla giovane età e minchia (volg. “fallo”) nel senso di persona poco intelligente (come nell’insulto testa di minchia). Nella successiva variante grafica bimbominkia (oggi più diffusa) la “k” ha funzione rafforzativa, evocando la scrittura sintetica tipicamente utilizzata dagli adolescenti nella messaggistica e caratterizzata da espedienti come abbreviazioni, troncature e sostituzione di gruppi di lettere con singoli caratteri (come ad esempio, appunto, la sostituzione del gruppo consonantico “ch” con “k” o della sillaba “per” con il segno matematico di moltiplicazione).
Il neologismo è di sicuro impatto: «bimbominkia». L’effetto è garantito, sarà la k a catturare o il sostantivo infantile abbinato alla parolaccia, ma la parola è difficile da dimenticare. Anche perché, a dispetto dell’apparente leggerezza, l’invenzione linguistica accende i riflettori sul più violento scontro generazionale registrato nel social network fra ragazzini e adulti, questi ultimi indignati per l’invasione degli under 20 su Twitter, fino a ieri riservato a un pubblico pensante.
Panorama, 07 Mar. 2012
Il termine sarebbe nato nell’ambiente dei forum su internet, in particolare quelli dedicati ai giochi di ruolo in rete (MMORPG[1]), per indicare quei principianti (in gergo i “niubbi”, dall’inglese newbie) particolarmente molesti. L’uso risalirebbe a prima del 2006 (forse 2003) e Claudio Pizzigallo, che sul suo blog Pizzi Chi? ne ha ricostruito la storia, attribuisce l’invenzione di questa parola a Fabio Bolzoni, utente milanese del forum gaming.ngi.it noto come “Lord Phobos” che così soprannominò un giovane utente «particolarmente ostinato e pertinace». Il racconto della genesi della parola ne dà anche la migliore definizione possibile:
La parola mi venne in mente così, di botto.
Lo stavo offendendo, come facevo spesso, a causa di qualche sua uscita particolarmente infelice e imbarazzante. Volevo dargli del bambinetto di merda, del rincoglionito bimbetto, del ragazzino della minchia, del piccolo ritardato senza speranza.
Tutto si fuse istantaneamente in una singola parola che racchiudeva tutto: “Braindamage, tu sei un bimbominchia “.
F. Bolzoni, intervistato da C. Pizzigallo su Pizzi Chi?, 4 Mag. 2013.
Meno credibile è l’ipotesi etimologica avanzata sul forum di Word Reference (op. cit.) secondo la quale sarebbe invece una storpiatura di Bimbomix, titolo di una serie di compilation musicali pubblicate dall’etichetta discografica Baby Records dal 1983 al 1987 e destinata ad un pubblico molto giovane.
In altre lingue
- Inglese: secondo lo stesso Bolzoni, il termine bimbominchia è traducibile in inglese come prick–o–kid (Pizzigallo, op. cit.), mentre il dizionario contestuale Reverso Context propone tween, teenie bopper o emo (quest’ultimo però si riferisce ad una specifica sottocultura). Gli utenti del forum di Word Reference propongono invece sucker, che significa “idiota”, “stupido”, “coglione”.
- Spagnolo: Martino Sacchi segnala il termine assimilabile tontopolla attestato almeno dal 2011.
- [1]MMORPG: Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game.↩
Fonti
- Pizzigallo, Claudio “Chi ha inventato la parola bimbominchia? Una scoperta sensazionale” in Pizzi Chi? 4 Mag. 2013. Web.
- Pizzigallo, Claudio “Intervista all’inventore dei bimbiminchia” in Pizzi Chi? 4 Mag. 2013. Web.
- Guadagni, Davide “Il dizionario dell’antilingua” in L’antilingua (blog) L’Espresso.
- Pecora, Aldo “I 10 indizi per stanare un bimbomikia…” in Che Futuro! 4 Mar. 2015. Web.
- “bimbominkia” in Neologismi, Treccani. Web.
- “bimbominkia” in Reverso Context
- “bimbominkia” in Forum, Word Reference. Web.
- Paco “El tontopolla, una expecie en expansión” in La vida como yo la veo. 7 Lug. 2011. Web.
Immagine in alto: © mikitiger/Fotolia.
carro a due ruote a trazione animale per il trasporto di cose (e occasionalmente di persone); variante di baroccio o barroccio; dal latino *birotium, composto di bi– (due) e rota (ruota); per estensione un’automobile sgangherata, “carretta”.
Passa il biroccio tra le viti e li olmi
Giovanni Pascoli, La Canzone del Paradiso (I) in Le Canzoni di re Enzio (1908).
Il biroccio era solitamente realizzato in legno, con ampio pianale di carico e trainato da un cavallo, un asino o una coppia di buoi. Al di là delle caratteristiche del carro, il termine biroccio era legato anche al tipo di impiego: a differenza di un qualsiasi carro agricolo, che era un cespite della famiglia contadina o dell’azienda agricola, il biroccio era condotto da un birocciaio (o barocciaio), piccolo imprenditore di classe sociale umile, proprietario del mezzo, che effettuava trasporti e consegne per conto terzi. Il birocciaio era quindi equiparabile alla moderna figura del “padroncino” nel trasporto su gomma.
Per estensione, in passato il termine biroccio era utilizzato ad indicare anche altri tipi di vettura, sia a due ruote come il calesse[1][2] (che è però per il trasporto di persone), sia a quattro ruote come il cabriolet.[3] Il diminutivo biroccino (o baroccino) poteva indicare invece un piccolo carro a due ruote per il trasporto di persone, come il calesse o il calessino, o un carretto a mano di piccole dimensioni utilizzato dai venditori ambulanti. Del resto, in mancanza di uno standard sulle caratteristiche e la nomenclatura dei carri, queste denominazioni avevano contorni definiti dall’uso locale, più che dalle caratteristiche del veicolo.
Il termine biroccio è rimasto nell’uso moderno ad indicare in modo ironico, per analogia con il frugale carretto a trazione animale, un’automobile o altro mezzo a motore sgangherato, traballante o particolarmente economico:
…mentre l’Ultramobile – strano trabiccolo simile ad un biroccio senza cavalli – mostra caratteristiche tutte nuove.
da Luigi Sardi, Battisti, De Gasperi, Mussolini: tre giornalisti all’alba del Novecento (Curcu & Genovese, 2004) pag. 282.
Tu sei l’omarino del biroccio plebeo. L’alfista è l’auriga del Carro del Sole: è Fetonte.
da Giovannino Guareschi, “diario di viaggio” in La famiglia Guareschi #2 1953-1968 Milano: RCS (2012). pag. 554
Baroccio o biroccio
Foto in alto: carro con buoi ad Assisi nel 1938, foto di Domenico Anderson (1854-1938). [PD] Commons
- [1]Lambruschini, cit. in Viani (op. cit.)↩
- [2]cfr. “calesse” in Sinonimi e contrari. Treccani. Web.↩
- [3]Rastrelli, cit. in Viani (op. cit.)↩
- [4]Prospero Viani, (op. cit.)↩
- [5]Nota al Palio Degli Asini di Modesto Rastrelli (Firenze, 1791), pagg. 52-53.↩
- “biroccio” in Vocabolario online. Treccani. Web.
- “barroccio” in Vocabolario online. Treccani. Web.
- “BAROCCIO, e BIROCCIO” in Vocabolario degli Accademici della Crusca, 4ª ediz. 1729. Vol. 1 pag. 390
- Viani, Prospero “Baroccio” in Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme erronee della lingua italiana, Le Monnier, 1858. Volume 1 pag. 196.
- “baroccio e carro agricolo” in Taccuini Gastrofisici, Web.
- spina posta in cima al manico di alcuni strumenti cordofoni, atta a regolare la tensione delle corde, chiamata anche cavicchio, chiave o pirolo. Di etimologia incerta, ma secondo il linguista Napoleone Caix (1845 – 1882) dal latino PÈSSULUM che significa “piolo”, “legnetto”.
- sciocco, grullo (regionalismo toscano): dal volgare toscano bischero, nel senso di membro maschile, a sua volta per similitudine da bischero (1) ossia il “pirolo” dello strumento musicale. Da qui divenne voce popolare di ingiuria o rimprovero, similmente a minchione, il pirla milanese o il belìn genovese. Un’altra ipotesi etimologica, meno accreditata presso i linguisti, fa risalire il termine alla famiglia fiorentina dei Bischeri e ad un aneddoto circa la costruzione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, iniziata nel 1290. Il Comune deliberò di acquistare tutte le case e i terreni che si trovavano nell’area interessata, tra i quali vi erano quelli della famiglia Bischeri. Questi iniziarono una estenuante trattativa con il Comune, trascinata per anni, con lo scopo palese di speculare il più possibile sull’operazione. Questo comportamento fu giudicato stupido e testardo dalla cittadinanza e finì per spazientire il Comune, che espropriò coattivamente gli immobili rimborsando la famiglia con ben pochi fiorini: da ciò, bischero sarebbe diventato sinonimo di stupido.
Se tu fossi alto quanto tu sè bischero tu berresti alle grondaie. modo di dire fiorentino
- “Bischero” in Pianigiani, Ottorino, Dizionario etimologico della lingua italiana (1907)
- “Bischero” in Vocabolario Treccani — <treccani.it> Web.
- Nocentini, Alberto “Bischero: un caso apparentemente risolto”, in Archivio glottologico italiano, nº 90, 2005, pp. 114-116.
In alto: un pirolo nel cavigliere di un violino (Just plain Bill [CC-BY-SA 3.0] Commons).