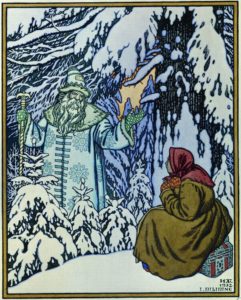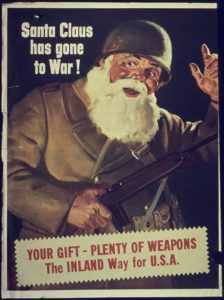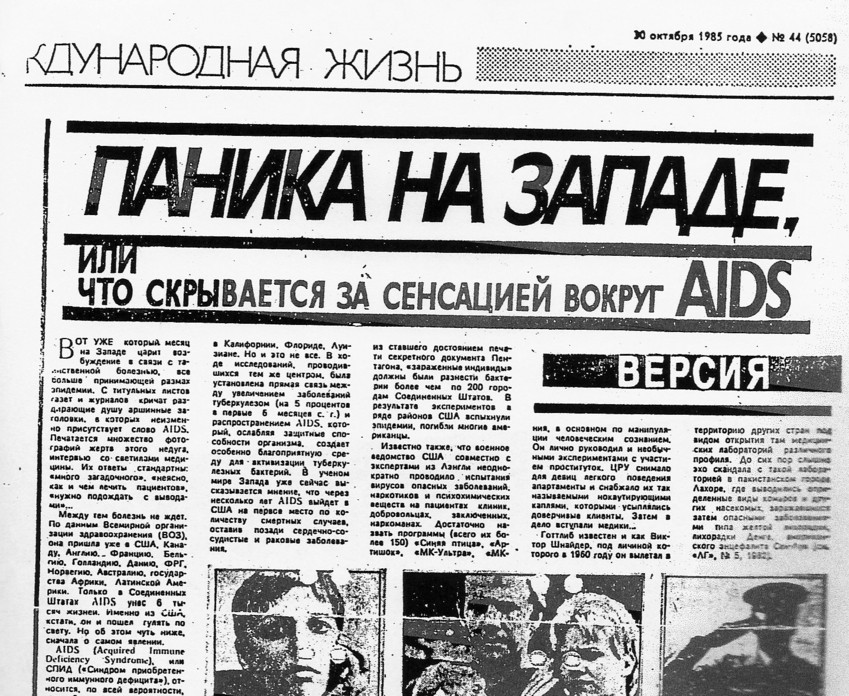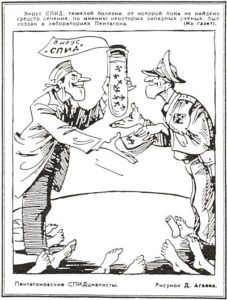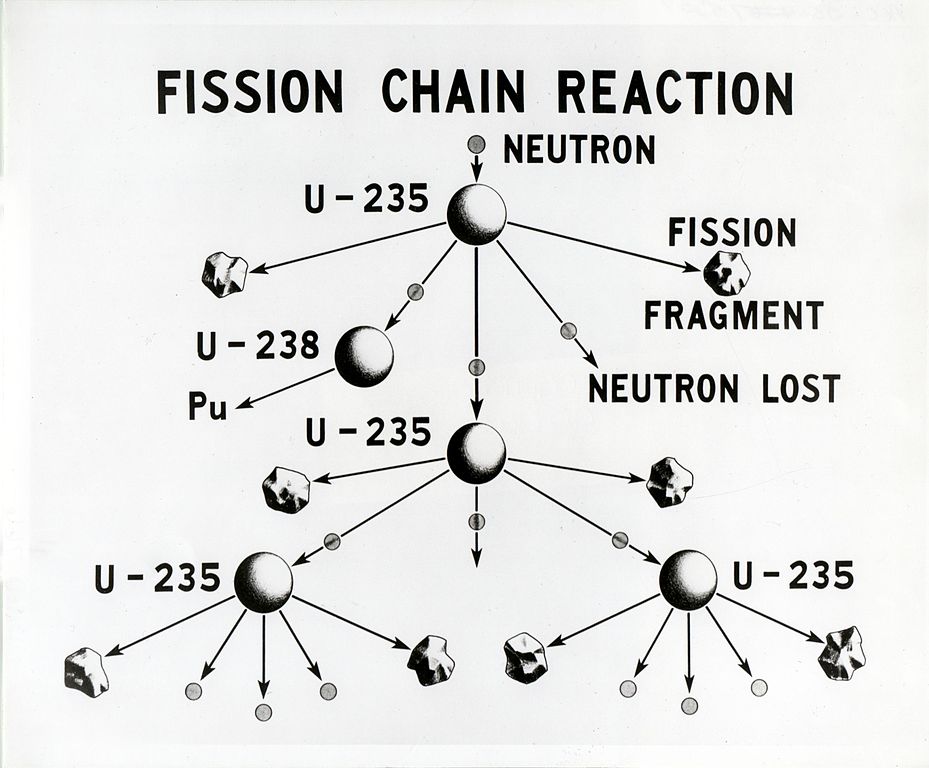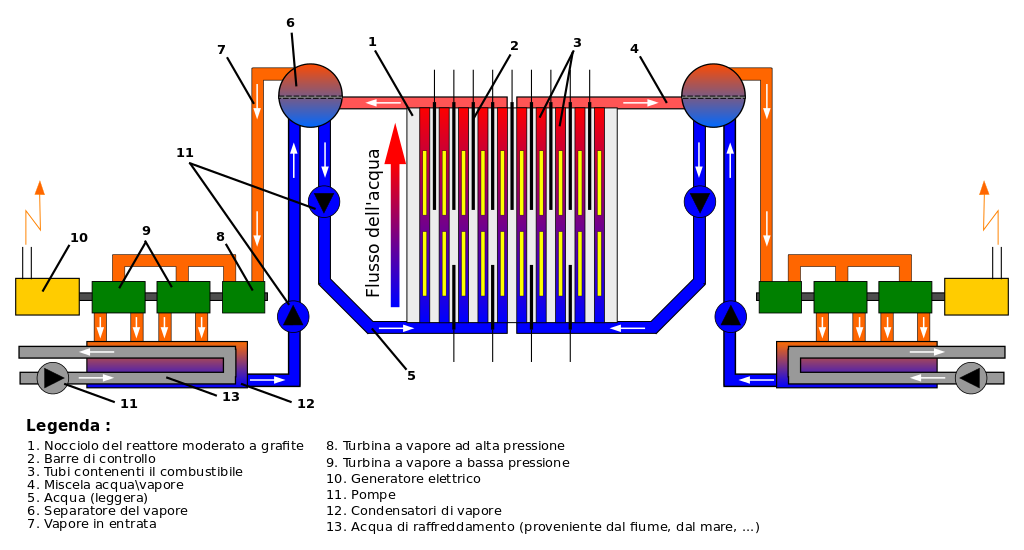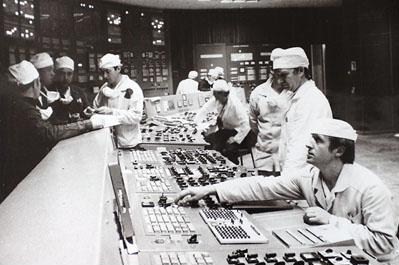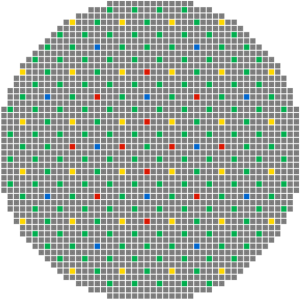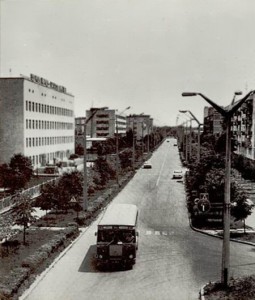Ha una lunga barba bianca e guance rosse, un lungo abito orlato di pelliccia, viene d’inverno e porta i regali ai bambini. Ma arriva qualche giorno dopo Babbo Natale: è Nonno Gelo, il tradizionale portatore di doni del folklore natalizio russo e di molti paesi dell’est. Solitamente si veste di blu o di azzurro, a volte di bianco e in tempi recenti anche di rosso, proprio come il suo omologo occidentale. È un caso, si può dire, di “convergenza evolutiva”: nonostante nel tempo le due figure siano diventate molto simili, fino quasi a sovrapporsi, l’origine di Nonno Gelo non ha nulla a che vedere con il santo Nicola di Bari da cui deriva invece il mito di Santa Klaus.

1. Nonno Gelo nell’abito tradizionale.
Nonno Gelo, tanto per cominciare, non era un santo ma un demone. Si chiamava Morozko ed aveva il potere di congelare le persone. A lui erano attribuiti i decessi da assideramento, soprattutto tra gli incauti che si avventuravano per i boschi o tra i bambini che, non sorvegliati dai genitori, si perdevano. L’immaginario popolare era profondamente suggestionato dagli elementi della natura, dalla cui benevolenza dipendeva la sopravvivenza dell’uomo, e in particolare dalle manifestazioni estreme del rigido inverno russo, la cui rappresentazione antropomorfica nel pantheon della mitologia slava era appunto il demone Morozko. Non inganni l’accezione occidentale della parola demone: nella letteratura russa il демон (démon) è uno spirito, senza alcuna particolare connotazione negativa. Il “demònio” provocatore del male, della tentazione e del peccato, è detto invece бес (bes) — infatti il titolo originale de I Demoni di Dostoevskij è Бесы (Besy). Protagonista di fiabe e leggende del folklore russo, Morozko apparteneva alla categoria dei démony e non era quindi propriamente malvagio, quanto piuttosto un elemento di equilibrio tra il bene ed il male, severo verso gli immeritevoli ma benevolo verso le persone oneste e di buona volontà. Una fiaba tradizionale siberiana, raccolta da Alexander Afanas’ev nell’opera Fiabe Russe (Народные Русские Сказки) pubblicata tra il 1855 ed il 1863, narra di una ragazza di nome Marfusha fatta abbandonare nel bosco, al freddo, dalla malvagia matrigna che voleva liberarsene. Qui sopraggiunge il Gelo che, intenerito dal buon cuore della ragazza, anziché assiderarla decide di portarla con sé e coprirla di regali, per poi punire invece la matrigna per l’ignobile atto “congelandole” la figlia prediletta.
Nonno Gelo, tanto per cominciare, non era un santo ma un demone
Dalla fine del primo millennio dopo Cristo, in Russia, le divinità pagane iniziavano a perdere terreno di fronte all’avanzata del Cristianesimo. Quest’ultimo non ammetteva figure ambigue e Morozko, per sopravvivere, dovette gradualmente adattarsi abbandonando il proprio lato “malvagio”, smettendo cioè di congelare ignari passanti e limitandosi a portare i doni ai bambini per diventare così Ded Moròz (Дед Мороз), il bonario “Nonno Gelo”. Nel frattempo, a partire dal XVIII si andava diffondendo in Russia il culto del vescovo di Myra San Nicola di Bari, tuttora patrono della Russia, che secondo la tradizione portava anch’egli i regali la notte del 6 dicembre, giorno a lui dedicato nel calendario liturgico. Il passaggio di Nonno Gelo fu invece fissato per il 31 dicembre, notte di capodanno, festività molto sentita in Russia (e fastosamente festeggiata). Ciò avvenne sicuramente dopo il 1700, quando Pietro il Grande decretò l’adozione del calendario giuliano per uniformarsi alle potenze europee:[ref]In realtà, in Europa, dal 1582 era stato introdotto il calendario gregoriano che aveva sostituito il giuliano nella maggioranza dei paesi.[/ref] fino ad allora, infatti, era in vigore il calendario bizantino il cui capodanno cadeva il 1° settembre dell’attuale gregoriano. Ad aumentare la confusione, nel 1917 i bolscevichi avrebbero imposto il calendario gregoriano, oggi adottato nella maggior parte dei paesi del mondo occidentale, e per eliminare la discrepanza di 13 giorni tra i due calendari si stabilì per decreto che il 1918 sarebbe iniziato direttamente con il 14 gennaio, saltando tutti i giorni precedenti. La Chiesa Ortodossa, in disaccordo con la riforma, continuò invece ad utilizzare invece il calendaro giuliano sicché le festività religiose ancora oggi sono slittate di 13 giorni rispetto al calendario ufficiale: il Natale ortodosso cade pertanto il 7 gennaio anziché il 25 dicembre. Intanto, nel mondo occidentale San Nicola, che già riassumeva in sé molte rappresentazioni antiche del portatore di doni di ispirazione religiosa o popolare, si trasformava a poco a poco nel suo moderno alter ego laico Babbo Natale aka Santa Claus, la cui figura veniva progressivamente a definirsi a partire da opere come i poemi A Visit From St. Nicholas di Clement Clark Moore (1822) ed alle illustrazioni di Thomas Nast per la rivista politica Harper’s Weekly di New York (1863—1865). In Russia il Santo rimase tale, relegato per lo più all’ambiente cristiano, mentre fu Nonno Gelo ad assumere il ruolo di portatore laico di doni attribuito in occidente a Babbo Natale. Pur influenzato da quest’ultimo, mantenne alcune caratteristiche proprie come il colore dell’abito, blu o bianco anziché rosso e spesso riccamente ornato con motivi ispirati ai cristalli di ghiaccio e ai fiocchi di neve, i tradizionali stivali di feltro (i valenki) e l’immancabile bastone di ghiaccio con cui si aiuta ad avanzare nella neve. Nonno Gelo preferisce infatti spostarsi a piedi ma, se proprio deve utilizzare la slitta, nelle più comuni raffigurazioni popolari sembra prediligere alle renne la tradizionale troika, ovvero il tiro a tre cavalli.

3. Ded Moròz con la tradizionale slitta a tre cavalli (troika) in un disegno del 1887 del pittore tedesco Whilhelm Amandus Beer.
Dalla Russia con amore

4. Ded Moròz e Sneguročka in una cartolina russa del 1917.
Un’altra notabile differenza sta nel fatto che Babbo Natale è fondamentalmente un solitario. A parte eventuali aiutanti elfi e compagne apocrife occasionamente attribuitegli,[ref]A. Bianchi in La vera storia di Babbo Natale (ed. 3ntini, 2004) riporta tale Jessica Maria Claus come consorte di Babbo Natale (p. 48).[/ref] non ha figure stabili di contorno ed è solo con le sue renne mentre porta a termine il compito per cui è universalmente conosciuto. Nonno Gelo invece arriva quasi sempre accompagnato da Sneguročka (Снегурочка), nome che in russo significa “fanciulla di neve”. È il 1873 quando l’omonima opera teatrale di Aleksandr Nikolaevič Ostrovskij, con echi shakespeariani e musiche di Čajkovskij (quello de Lo Schiaccianoci, 1892) viene presentata al Teatro Bolšoj di Mosca riportando in auge la drammatica storia di Sneguročka, disposta a perdere la propria natura immortale in cambio della possibilità di innamorarsi come ogni essere umano. Quando ciò le viene concesso, la giovane si avventura fuori dalla foresta e si scioglie al primo raggio di sole (mai una gioia). Figura ricorrente in fiabe e leggende popolari, Sneguročka ha origine nelle antiche credenze pagane e rappresenta ancora una volta l’eterno alternarsi delle opposte forze della natura. Sarebbe infatti figlia dell’inverno e della primavera, unitisi carnalmente in quell’unico giorno all’anno in cui si incontrano per il naturale avvicendarsi delle stagioni. Sua madre è la giovane Vesna, personificazione della primavera e dea della bellezza. Suo padre — l’inverno — altri non è che quel vecchio marpione di Morozko, alias Ded Moròz: la piccola Sneguročka sarebbe quindi tecnicamente figlia di Nonno Gelo.

5. Nonno Gelo e Sneguročka in abiti tradizionali a Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia. A prescindere dal colore, il vestito di Nonno Gelo è di solito riccamente ornato rispetto a quello di Babbo Natale.
«Alleato dei preti e dei kulaki»
Mentre la maggior parte dei paesi occidentali viveva una trasformazione sociale, economica e politica in senso democratico e liberale, la Russia imperiale di Nonno Gelo restava immobile nel modello di governo autocratico e conservatore degli Zar e con l’arrivo del XX secolo rimaneva una delle nazioni più arretrate d’Europa. Le tensioni sociali portarono alle rivoluzioni russe[ref]Rivoluzione del 1905, rivoluzione di febbraio e di ottobre del 1917.[/ref] che si conclusero con la caduta dell’Impero e la presa di potere dei bolscevichi dopo il famoso “ottobre rosso” del 1917. I bolscevichi avevano tra gli obbiettivi ideologici l’abolizione totale della religione, definita da Karl Mark «l’oppio dei popoli»,[ref]«La religione è il singhiozzo di una creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di una condizione priva di spirito. È l’oppio dei popoli» (Karl Marx, Critica della filosofìa hegeliana del diritto pubblico).[/ref] in favore dell’ateismo universale. Se Nicola di Bari era ovviamente espressione dell’odiata chiesa cattolica, anche il povero Ded Moròz fu visto come una manifestazione di credenze pagane o di superstizioni da abolire: incompatibile con la visione materialista e scientifica del mondo promossa dalla propaganda antireligiosa, nel 1928 fu accusato di essere un «alleato dei preti e dei kulaki»[ref name=”petrone”]Petrone (op. cit.) Pag. 85–88.[/ref] (sic) e messo al bando insieme agli alberi di Natale, considerati simboli religiosi e borghesi.[backref name=”petrone” /][ref]Filomonova, Olga in “Елочные базары” in ВЗГЛЯД, 29 novembre 2005. Web.[/ref] Le processioni religiose, le celebrazioni del Natale e del Capodanno Russo furono proibite in favore di festività legate ad un imposto immaginario socialista; nel 1929 fu addirittura introdotto un “calendario rivoluzionario” con settimane di cinque giorni per cancellare anche il ricordo della domenica cristiana come giorno di riposo. Ma le abitudini e le tradizioni religiose si rivelarono durissime da sradicare e queste misure furono tanto impopolari che il regime dovette gradualmente mollare la presa sulle domeniche e tornare al calendario gregoriano.
Al mio segnale scatenate il Natale
Negli anni ’30 ci fu una svolta nella politica delle festività. Preso atto che il Natale sarebbe stato comunque festeggiato, nel partito comunista qualcuno iniziò a pensare che fosse meglio liberalizzarlo facendone un mezzo di propaganda rivolto soprattutto ai bambini e ragazzi. Bisognava però trovare una giustificazione per il cambio di rotta e a fornirla fu il primo segretario del Comitato Regionale di Kiev e del Partito Comunista Ucraino, tale Pavel Postyshev, considerato uno dei principali fautori della scellerata pianificazione dell’agricoltura che provocò l’holomodor, la terribile carestia che si abbattè sull’Ucraina tra il 1932 ed il 1933 causando la morte di milioni di persone. In una sua lettera pubblicata sul quotidiano Komsomól’skaja Pravda[ref]Il Komsomól’skaja Pravda era l’organo ufficiale del Komsomol, l’organizzazione giovanile del Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Da non confondersi con il più noto Pravda, che era invece l’organo ufficiale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica.[/ref] denunciava la proibizione degli alberi di Natale, chiamati però eufemisticamente “alberi di Capodanno”, come una «deriva di destra» (no, sul serio…) In fondo, sosteneva Postyshev, le feste invernali erano una tradizione pre–cristiana; non c’era nulla di male ad addobbare un albero o scambiarsi doni e i bambini sarebbero stati più felici (sottintendendo quindi più fedeli al partito). Fu il segnale; alberi e decorazioni tornarono nelle case, nelle strade, nelle scuole e addirittura nelle caserme. Racconta lo scrittore russo Victor Fischer: «Mi ricordo l’emozione e l’allegria a Mosca allorché la triste politica che vietava la celebrazione delle festività tradizionali fu invertita in un solo giorno. Gli abeti inondarono la città e le decorazioni a lungo nascoste emersero in addobbi luminosi.»[ref]Fischer, Victor e Charles Wohlforth To Russia with Love: An Alaskan’s Journey Fairbanks: University of Alaska Press, 2012. Pag. 47.[/ref]

6. Ballo di Capodanno del 1937 nel quartier generale dell’Armata Rossa: sullo sfondo si vede un grande albero addobbato (dal quotidiano Pravda del 2 gennaio 1937).
L’intento era chiaramente di trasferire l’immaginario natalizio, con tutti i suoi riti e simboli, sul capodanno laico che avrebbe così assorbito ogni festività religiosa limitrofa. A tale scopo fu riabilitato anche Nonno Gelo che nel 1937, dopo quasi vent’anni di esilio, potè tornare in patria a condizione che lavorasse per il regime. Il suo ruolo sarebbe stato di riempire il vuoto lasciato dal suo alter ego cristiano e compagno di esilio San Nicola, prevenendone così il ritorno. Sarebbe venuto quindi a capodanno e avrebbe distribuito i doni nella piazza di ogni villaggio, sotto un grande albero allestito a cura del locale Komsomol, l’organizzazione giovanile del partito comunista. Il primo giorno di lavoro, il capodanno del ’37, fu un disastro: gli alberi erano spesso addobbati con candele per mancanza di corrente elettrica e i costumi di bassa qualità utilizzati dai figuranti prendevano fuoco. A Novo–Nikolaevsk due funzionari del Komsomol furono avvolti dalle fiamme, una ragazzina di dodici anni perse la vita a Slobodskoj (vicino a Kirov), in tutta l’Unione Sovietica si registrarono 39 morti e svariati ustionati, per lo più bambini.[backref name=”petrone” /] Nonostante l’inizio difficile, Nonno Gelo continuò a distribuire i doni nelle piazze con gli auguri di Stalin. Inizialmente indossava la tradizionale mise azzurro–ghiaccio per distinguersi dall’omologo occidentale; in seguito però fu tollerato anche il rosso in quanto colore della bandiera rivoluzionaria e Nonno Gelo finì così, paradossalmente, per assomigliare ancor di più all’odiato Babbo Natale capitalista. La bella Sneguročka fu di nuovo al suo fianco ma orfana di madre, poiché — vuoi che dopo vent’anni di esilio ci si era dimenticati di lei, vuoi che le nemmeno le divinità pagane erano gradite dal regime — ogni riferimento a quella relazione di tanti anni fa con la Primavera era scomparso. In mancanza di una figura materna Sneguročka passò da figlia a nipotina, poi compagna (!) e addirittura in alcune cartoline d’auguri sovietiche l’incestuosa coppia venne raffigurata intorno a una culla con un neonato, metafora del nuovo anno, in una chiara imitazione laica della Natività cristiana.
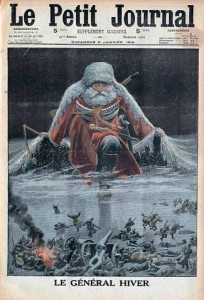
9. Il Generale Inverno che immobilizza le truppe sul fronte orientale della I guerra mondiale è raffigurato su Le Petit Journal del 9 gennaio 1916 come una sorta di Babbo Natale malvagio.
Razzi e renne
Nel 1945 le forze sovietiche presero Berlino. La guerra in Europa era finita, il mondo era da ricostruire ma le superpotenze vincitrici avevano idee antitetiche su come farlo. Le crescenti tensioni internazionali sfociarono nelll’ostilità politica e ideologica tra l’occidente e il cosiddetto “blocco comunista”; nel giro di pochi anni i due Babbi si trovarono separati dalla “cortina di ferro”, come Churchill chiamò la linea di confine che divideva l’Europa:[ref]«Da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente»: dal discorso di Winston Churchill a Fulton (Missouri) il 5 marzo 1946.[/ref] Santa Claus ad ovest e Nonno Gelo a est. Durante la guerra fredda, la competizione per il raggiungimento della supremazia militare e tecnologica portò a notevoli sviluppi da ambo le parti, soprattutto nel campo dell’atomo e dello spazio. A oriente, Nonno Gelo e Sneguročka sembrarono appassionarsi al progresso tecnologico e in particolare alla corsa allo spazio, abbandonando la slitta per cavalcare razzi e veicoli spaziali sempre più veloci verso il radioso futuro socialista.
10. Ded Moròz e Sneguročka durante la corsa allo spazio.

11. Il volantino di Sears del 1955 con il numero di telefono sbagliato che dette inizio al programma “NORAD Tracks Santa”.
Intanto a Occidente, non riuscendo a convincere il più tradizionalista Babbo Natale a sostituire le renne nemmeno con un jet, si decise almeno di mettergli a disposizione la tecnologia radar: tutto ebbe inizio nel 1955 quando un negozio “Sears”[ref]Sears, Roebuck & Co. nota come “Sears” è una catena americana di grandi magazzini fondata nel 1886 da Richard Warren Sears and Alvah Curtis Roebuck in 1886: dette il nome al celebre grattacielo “Sears Tower” di Chicago che ne fu sede fino al 1990.[/ref] di Colorado Springs pubblicò su un giornale locale un annuncio pubblicitario nel quale si invitavano i bambini a telefonare direttamente a Babbo Natale. Per un fortuito errore di battitura, però, il numero di telefono pubblicato non fu quello del negozio ma quello della vicina base dell’aeronautica militare, sede del Comando di Difesa Aerea Continentale (CONAD), che la sera del 24 dicembre fu tempestata di chiamate da parte di bambini che chiedevano delucidazioni sulla consegna dei regali. Il colonnello Shoup in servizio quella notte dette disposizione al personale di assecondare i bambini fornendo loro le coordinate della slitta in volo, inaugurando così una tradizione che resiste ancor oggi. Ben presto la minaccia dei bombardieri nucleari a lungo raggio portò Stati Uniti a Canada ad una più stretta collaborazione per la difesa aerea e nel 1958 il CONAD confluì nel nuovo Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America (NORAD); la sede principale fu spostata nella Cheyenne Mountain Air Force Station (sempre in Colorado) ma il servizio di tracciamento di Babbo Natale, chiamato ora “NORAD Tracks Santa”, fu mantenuto ed oggi continua anche sull’apposito sito internet. Quella del NORAD rimane una delle poche aggiunte alla tradizione di Babbo Natale e secondo Gerry Bowler, professore di storia all’Università di Manitoba e autore del libro Santa Claus: A Biography, l’unica che ne porta davvero il mito nell’era moderna prendendone un elemento tradizionale — il viaggio con la slitta — e inserendolo in un contesto tecnologico. La risposta di Nonno Gelo arrivò solo nel 2009, vent’anni dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, quando le Forze Spaziali Russe[ref]Le Forze spaziali russe (Vozdushno–KosmicheskieSily Rossii, abbr. VKS) erano la branca delle forze armate della Federazione Russa che si occupa delle operazioni militari riguardanti lo spazio. Dal 2015 furono incorporate nelle Forze Missilistiche Strategiche, la forza armata preposta alla gestione dei missili balistici intercontinentali.[/ref] lanciarono l’analogo servizio “GLONASS Tracks Father Frost“: il GLONASS, acronimo di Global’naja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema, è infatti il sistema satellitare globale di navigazione russo, controparte del Global Positioning System (GPS) statunitense e del sistema satellitare europeo Galileo.
Finlandia vs. Russia
Il viaggio di Babbo Natale e quello di Nonno Gelo per la consegna delle strenne non differiscono solo per la data (la vigilia di Natale il primo, capodanno il secondo) ma anche per il punto di partenza, la casa o il villaggio dove le due figure risiedono. Nel XIX secolo, i riferimenti nordici e germanici contenuti nel celebre poema di Moore e nelle illustrazioni natalizie di Thomas Nast (che era di origine bavarese) fecero nascere in nordamerica la convinzione che Babbo Natale provenisse dal Polo Nord; un luogo sì freddo e remoto, ma anche inaccessibile ai comuni mortali, distante e non contaminato dalla vita di tutti i giorni. Collocare Babbo Natale al Polo Nord significava però anche «confinarlo in una mitica terra di nessuno, in una sorta di luogo più fantastico che reale», scrive Carlo Sacchettoni nel libro La storia di Babbo Natale (1996), una «zona “franca” dove il sogno può diventare un evento possibile, dove la favola può trasformarsi in realtà.» Per gli europei, Babbo Natale risiede invece in Lapponia e per la precisione vicino a Rovaniemi, in Finlandia. Già dal 1925, nella corrispondenza pubblicata su alcuni giornali locali sotto Natale,[ref]Sacchettoni, pag. 92 (op. cit.)[/ref] si leggevano le perplessità sulla fiabesca provenienza polare di Babbo Natale da parte dei pragmatici finlandesi, i quali giustamente obbiettavano che le renne al polo non avrebbero potuto pascolare. Inoltre il paese con più renne era la Finlandia e quindi se Babbo Natale aveva le renne era molto più probabile che vivesse nella Lapponia finlandese. Nel 1927 Markus Rautio, presentatore di un programma per bambini alla radio pubblica finlandese, dichiarò che il mitico villaggio di Babbo Natale si trovava un poco più a nord del circolo polare artico, nella zona del monte Korvatunturi. A mettere il sigillo dell’ufficialità alla — fino ad allora presunta — cittadinanza finlandese di Santa Claus fu la ricostruzione post bellica. Dopo la seconda guerra mondiale la Lapponia fu la prima regione a ricevere gli aiuti dall’UNRRA,[ref]UNRRA: United Nations Relief and Rehabilitation Administration.[/ref] organizzazione delle Nazioni Unite precorritrice dell’attuale UNICEF. Nel 1950 la delegata degli Stati Uniti per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ed ex first lady in quanto moglie del defunto presidente Franklin Delano Roosevelt), considerata l’anima dell’UNRRA, effettuò una visita a sorpresa a Rovaniemi per constatare i progressi del programma di ricostruzione in Lapponia. In tale occasione fu organizzata una cerimonia di ricevimento presso una capanna costruita appositamente in una sola settimana e posta simbolicamente sul napapiiri, il Circolo Polare Artico. La capanna divenne una attrazione turistica e intorno ad essa sarebbe cresciuto quello che oggi è internazionalmente noto come il “Santa Claus Village“, un parco tematico gestito dall’ente regionale per il turismo. Altri paesi nordici rivendicarono la residenza o l’ufficio di Babbo Natale: per i Norvegesi è a Drøbak, un villaggio risalente al diciottesimo secolo che ha saputo conservare la sua architettura tradizionale; in Groenlandia è presso l’ufficio postale di Nuuk, capoluogo dell’isola; per la Svezia è nel parco tematico a sud di Mora; per gli islandesi[ref]Nella tradizione islandese, però, il Babbo Natale euro–americano è solitamente sostituito dai tredici “Jólasveinar”.[/ref] svernerebbe in un villaggio termale vicino a Hveragerði; in Danimarca invece è praticamente ovunque. Anche in Alaska c’è una casa di Babbo Natale a Fairbanks e villaggi estemporanei fioriscono dappertutto ogni anno, ma quello più famoso e più comunemente ritenuto “ufficiale” resta quello finlandese di Rovaniemi.
[mapsmarker layer=”22″]
Rovaniemi in Finlandia e Velikij Ustjug in Russia: rispettivamente i villaggi di Babbo Natale (rosso) e Nonno Gelo (blu).
Ded Moròz, invece, originariamente era il demone dell’inverno e la sua residenza era ovunque ci fosse ghiaccio e neve, soprattutto nelle foreste (stiamo parlando dei tempi in cui si divertiva a congelare viandanti a caso solo per il “LOL”). In particolare in Bielorussia la casa di Ded Moròz (anzi, Dzied Maroz come lo chiamano lì) è tradizionalmente collocata nella foresta di Białowieża. Solo dopo la transione della Russia al libero mercato divenne chiaro che un villaggio di Nonno Gelo al pari di quelli occidentali potesse essere una risorsa economica: nel 1998 la residenza ufficiale di Ded Moròz fu stabilita nell’idilliaco villaggio di Velikij Ustjug, antico centro monastico e mercantile circa mille chilometri a nord–est di Mosca, per iniziativa dell’allora sindaco Yuri Luzkhov che intendeva rilanciare il turismo. Vi si tiene anche una festa del “compleanno di Nonno Gelo” il 18 novembre[ref]Richmond, Simon Russia Europea EDT/Lonely Planet, 2009. Pag. 12.[/ref] e la cittadina riceve circa 200 mila turisti all’anno, desiderosi di vedere la casa di legno («…una via di mezzo tra un museo e un festival del kitcsh» secondo Lonely Planet[ref]Russia. Edizioni EDT/Lonely Planet, 2012. P. 371.[/ref]) dove Nonno Gelo e Sneguročka preparano i regali e trascorrono la vita di tutti i giorni. In fondo, che sia est o che sia ovest, i sogni dei bambini sono sempre gli stessi. [endmark]

12. Nonno Gelo e Sneguročka negli abiti tradizionali.
Condividi questo articolo
Note
[references class=”compact” /]
Bibliografia e fonti
- Petrone, Karen Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington (IN): Indiana University Press, 2000. ISBN 0-253-33768-2
- Dixon–Kennedy, Mike Encyclopedia of Russian & Slavic Myth and Legend ABC–Clio, 1998 P. 178.
- Sacchettoni, Carlo La storia di Babbo Natale
Roma: Edizioni Mediterranee, 1996.
- “Of Russian origin: Ded Moroz” in Russiapedia (Get to know Russia Better). Autonomous Nonprofit Organization “TV–Novosti”. Web.
- “Of Russian origin: Snegurochka” in Russiapedia (Get to know Russia Better). Autonomous Nonprofit Organization “TV–Novosti”. Web.
- “A pictorial History of Santa Claus” in Public Domain Review, 2012. Web.
- Lucia, “Il Babbo Natale dei dittatori” in Una Penna Spuntata. 9 Dic. 2012. Web.
- Lucia, “La fanciulla di ghiaccio che non poteva amare” in Una penna spuntata. 21 Dic. 2009. Web.
- Fair, Charles. Storia degli errori militari. Dall’antica Roma al Vietnam. Odoya, 2013. ISBN 978-8862881715
- Elliott, Daniel “Secret Santa helper: First Lady pitches in with NORAD” in NBC News, 24 Dic. 2010. Web.
- Taplin, Phoebe “Reveling in Russian Santa’s fairytale home” in Russia Beyond the Headlines. 14 Dic. 2010. Web.
- Dell’Acqua, Silvio “Babbo Natale era Verde?” in Laputa, 1 Dic. 2012. Web.
Immagini
Copertina: © Vadimdem/Fotolia
- © Demian/Fotolia.
- Ivan Yakovlevich Bilibin, 1932 (Commons).
- Wilhelm Amandus Beer, 1887 (Commons).
- Cartolina russa del 1917 (Commons).
- Belovezhskaya Pushcha (Belarus), 18-12-2004 (Commons).
- dal quotidiano Pravda del 2 gennaio 1937.
- Cartolina sovietica di capodanno destinata alle truppe, 1940 (Commons).
- Poster di propaganda del U.S. Office for Emergency Management, War Production Board. 1942–3 circa (Commons).
- Le Petit Journal, 9 gennaio 1916 (Commons).
- Cartoline sovietiche.
- Annuncio pubblicitario del negozio “Sears” di Colorado Springs, 1955 (Commons).
- © Demian/Fotolia.
Opera tutelata dal plagio su www.patamu.com con numero deposito 52570.

Occorreva stare molto attenti per tenere a freno l’immaginazione,
ai piedi di quelle oscure Montagne della Follia. H.P. Lovecraft
L’Unione Sovietica del 1959 era un impero con diversi volti che contendeva agli Stati Uniti la supremazia mondiale sul filo della costante minaccia nucleare. Per molti nel mondo essa era l’avanguardia comunista, il “Sol dell’avvenire” della classe operaia che avrebbe condotto l’umanità in una nuova era. Con sommo sconforto degli Stati Uniti, l’Unione Sovietica aveva davvero inaugurato una nuova era della storia umana il 4 ottobre del 1957, quando aveva lanciato nello spazio il primo satellite artificiale chiamato Sputnik, che in russo significa “compagno di viaggio”. E sono proprio dieci “compagni di viaggio”, nonché amici, i protagonisti nel febbraio del 1959 di una triste storia avvolta nel mistero. Il ventitreenne Igor Alekseevič Djatlov, laureando della facoltà di radio ingegneria al Politecnico degli Urali, aveva organizzato una spedizione per dedicarsi allo sci di fondo e all’escursionismo con obiettivo il monte Otorten, sulla catena universalmente nota come il confine naturale tra Europa e Asia: gli Urali. Il nome “Otorten” nella lingua degli indigeni mansi significa “non andateci”, probabilmente perché è molto difficile da raggiungere durante la stagione invernale e quindi da evitare. In pieno inverno una spedizione del genere era a prescindere molto impegnativa, ma tutti i partecipanti erano sciatori ed escursionisti esperti e l’intenzione di Djatlov era di allenarsi per una ben più difficile spedizione artica. Nell’Unione Sovietica di allora lo sport era considerato dal regime un valido strumento di coesione sociale ed era fortemente incentivato nelle scuole e nelle università, tanto che tra i giovani il turismo derivante dallo sci era molto popolare. Lo sci turistico sovietico però non era ciò che saremmo portati a credere: niente stazioni sciistiche e abbigliamento alla moda come in Occidente, ma un’attività sportiva difficile e impegnativa sotto il controllo delle università e dello Stato al fine di poterla adattare a esigenze militari.
Fu così che in onore del ventunesimo congresso del Partito Comunista programmato a Mosca dal 27 gennaio al 5 febbraio, per nulla intimorito dalla sinistra toponomastica mansi, Djatlov partì in treno il 25 gennaio 1959 dalla cittadina russa di Sverdlovsk — oggi Ekaterinburg[ref]Tra il 1924 e il 1991 la città di Ekaterinburg fu rinominata Sverdlovsk (Свердловск) in onore del leader bolscevico Jakov Michajlovič Sverdlov; la denominazione è tuttora usata dalle ferrovie russe e l’oblast’ di cui la città è capoluogo ha mantenuto il nome di Oblast’ di Sverdlovsk.[/ref] — e con lui la compagna Zinaida Kolmogorova (22 anni, studentessa di radio ingegneria) insieme a Ljudmila Dubinina (23 anni, studentessa di ingegneria ed economia), Aleksandr Kolevatov (24 anni, studente di fisica tecnica con ampio curriculum), Jurij Dorošenko (21 anni, studente) e Jurij Judin (22 anni, studente di ingegneria ed economia), tutti studenti del Politecnico degli Urali, più Rustem Slobodin (23 anni, ingegnere), Jurij Krivoniščenko (24 anni, ingegnere detto anche “Georgij”), Nikolaj Thibeaux-Brignolles (24 anni, ingegnere civile, figlio di un comunista francese emigrato in Russia e poi ucciso dal regime staliniano) e Aleksandr Zolotarëv (38 anni, ex soldato nonché esperta guida).[ref]In realtà il suo nome era Semyon ma si presentava agli altri come Aleksandr.[/ref]

Il viaggio della spedizione Djatlov verso il Cholat Sjachl.
Arrivati a Ivdel’ i dieci amici proseguirono con un furgone fino a Vijay, l’ultimo centro abitato prima della natura selvaggia. Il 27 gennaio la spedizione partì alla volta del monte Otorten, ma appena il giorno dopo Jurij Judin si ammalò e non fu in grado di proseguire oltre; Djatlov promise a Judin che avrebbe mandato una lettera al loro club sportivo non appena fossero tornati dal viaggio, ma quella lettera non arrivò mai. Il gruppo proseguì nella sua marcia arrivando il 31 gennaio sul versante orientale del monte Cholat Sjachl,[ref]O anche Cholatčachl’.[/ref] che nella lingua mansi significa “montagna dei morti”.[ref]Altre traduzioni sono anche “montagna morta” o “montagna della morte”, probabilmente dovuto al fatto che sia priva di vegetazione e cacciagione.[/ref] [mapsmarker marker=”234″ basemapDefault=”googleTerrain” width=”100″ widthUnit=”%” height=”480″ panel=”false”]
Il passo del Cholat Sjachl, sugli Urali.
Il 1 febbraio si incamminarono per superare il passo montano, ma una tempesta di neve causò scarsa visibilità e il gruppo perse l’orientamento finendo per dirigersi a ovest verso la cima; appurato l’errore i nove decisero di piantare le tende a 300 metri dalla vetta per accamparsi e sperare in condizioni meteo più favorevoli per il giorno dopo, che coincideva con il trentottesimo compleanno di Aleksandr Zolotarëv. Fu nella notte tra il 1 e il 2 febbraio che avvenne la tragedia. Giorni dopo la teorica conclusione della spedizione, prevista al più tardi per il 12 febbraio,[ref]Il ritardo è fisiologico in questo tipo di spedizione per cui l’allarme non fu dato subito.[/ref] i familiari non avevano ancora notizie e il 20 febbraio si organizzò una prima spedizione di studenti e professori volontari che non ebbe esito. Furono quindi allertate le autorità che iniziarono le ricerche il 22 febbraio e grazie ai mezzi aerei individuarono, il 26 febbraio, i resti dell’accampamento.

Il ritrovamento dei resti dell’accampamento.
Nel fascicolo di chiusura indagine si affermava che «una forza naturale si è presentata come causa della loro morte, (una forza) che le persone non erano nelle condizioni di superare»…
Una volta raggiunto il sito, i militari[ref]Dell’esercito e della milizia sovietica.[/ref] si trovarono di fronte ad una scena sconcertante: la tenda era stata lacerata dall’interno senza sciogliere i nodi dell’ingresso e con all’interno tutte le attrezzature tra cui scarpe, vestiti, diari sui quali l’ultima data appuntata era quella del primo di febbraio e macchine fotografiche; tutt’intorno le uniche orme erano quelle dei nove giovani. Seguendo le tracce furono ritrovati i prime due corpi: Jurij Krivoniščenko e Jurij Dorošenko giacevano semi nudi nella neve sotto a un pino. Sotto l’albero vi erano i residui di un fuoco a testimonianza che avevano provato a scaldarsi, ma sulla corteccia del pino furono ritrovati brandelli di carne e i rami erano spezzati fino a un’altezza di 4 metri e mezzo. I due uomini avevano quindi tentato di salire sull’albero per sfuggire a qualcosa? A distanze diverse tra la tenda e il pino furono ritrovati i corpi di Igor Djatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin: la loro posizione lasciò intendere che stavano tentando di rientrare al campo. All’appello però mancavano ancora quattro fondisti: furono ritrovati solo due mesi dopo, il 4 maggio, sepolti sotto quattro metri di neve in una gola scavata da un torrente nel bosco. I corpi riportavano gravi traumi e fratture interne simili a quelle provocate dagli incidenti stradali, inoltre il corpo di Ljudmila fu ritrovato senza lingua. Nel fascicolo di chiusura indagine si affermava che «una forza naturale si è presentata come causa della loro morte, [una forza] che le persone non erano nelle condizioni di superare» e per questo motivo le autorità opteranno per l’interdizione del passo a sciatori ed escursionisti dilettanti.

Ritrovamento del corpo di Rustem Slobodin, sepolto sotto la neve.
Il passo del Cholat Sjachl fu ribattezzato Passo Djatlov in memoria del capo spedizione. Da allora le più diverse e fantasiose ipotesi sono state fatte su ciò che è davvero accaduto quella tragica notte. A fomentare le speculazioni furono alcuni dettagli “insoliti” come la tenda chiusa ma lacerata dall’interno a indicare una fuga precipitosa da qualcosa, un qualcosa che forse era già nella tenda; alcuni avevano tentato di salire sull’albero magari per trovare riparo da una minaccia, ma non vi erano impronte di animali; le orme degli sciatori furono ritrovate intatte dopo un mese mentre i corpi erano ricoperti di neve; qualcuno indossava abiti di altri e furono rilevate tracce di radioattività su alcuni indumenti; solo quattro avevano riportato ferite e fratture gravi e uno aveva una frattura sul cranio; i cadaveri presentavano un avanzato stato di decomposizione nonostante le gelide temperature e uno “strano” colorito arancio. Infine, un altro gruppo di sciatori ricorda quella notte di aver visto delle sfere arancioni nel cielo. Per spiegare tutto ciò c’è chi ha parlato di un esperimento nucleare; chi di un esperimento militare segreto; chi di ipotetici alieni; chi di un attacco degli indigeni mansi e chi di un’antica maledizione; praticamente vi è tutto un ampio catalogo delle più fantasiose teorie tanto che l’incidente ha ispirato un film dal titolo Devil’s Pass (2013). Di recente l’autore americano Donnie Eichar ha esposto in un libro la sua ipotesti per spiegare il mistero: le particolari condizioni climatiche e di conformazione della montagna avrebbe prodotto dei “mini–tornado” e con essi degli infrasuoni, quei suoni non udibili dall’orecchio umano perché inferiori ai 20 Hz di frequenza ma che possono indurre stati di ansia, malessere e anche alterazioni della vista; sarebbe stata quindi l’ansia causata dagli infrasuoni a spaventare i giovani spingendoli a scappare in fretta e furia dalla tenda nonostante il freddo intenso.
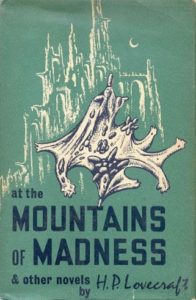
Illustrazione di Lee Brown Coye per la prima edizione di Alle montagne della follia di HP Lovecraft” (Arkham House, 1964).
Ma il Cholat Sjachl può davvero essere un «regno di paura e di orrore», come le montagne della follia di H.P. Lovecraft? La risposta dipende da ciò in cui si vuol credere. Non potremo mai sapere la verità con certezza su ciò che accadde quella notte, a tanti anni di distanza e senza ulteriori elementi rispetto a quelli già noti, ma il rasoio di Occam[ref]Il principio teorizzato da Guglielmo di Ockham per il quale a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire.[/ref] porta a concludere che non sia il caso di scomodare antichi alieni o forze misteriose. La tragedia del Cholat Sjachl può essere stata provocata, molto più banalmente, dalla paura di una valanga che in questo caso rappresenta il classico “elefante nella stanza”, un’espressione della lingua inglese[ref]In inglese: elephant in the room.[/ref] per indicare una verità palese che viene ignorata. L’eco di una valanga nelle vicinanze, o il movimento sussultorio causato dalla stessa, avrebbe indotto il gruppo a sentirsi in imminente pericolo, tanto da squarciare la tenda per scappare dalla valanga in preda al panico. Superata la paura si accorsero di essere esposti a temperature di meno trenta gradi Celsius senza adeguata copertura; accesero un fuoco e qualcuno si arrampicò sull’albero per cercare di rintracciare l’accampamento nonostante la notte e la tempesta di neve; alcuni cercarono di tornare all’accampamento ma morirono di ipotermia a duecento metri l’uno dall’altro; i superstiti recuperarano dei vestiti per aumentare le possibilità di sopravvivenza ma finirono per precipitare nella gola, l’altezza era di circa dieci metri, e anche loro morirono a poca distanza gli uni dagli altri per via delle ferite riportate.
E tutti gli altri elementi strani della vicenda? Anche per essi c’è una spiegazione razionale. L’aver ritrovato le orme dopo un mese mentre i corpi erano ricoperti di neve è un fenomeno tutt’altro che raro, dovuto alle dinamiche dei venti e delle nevicate; il colorito arancio così come lo stato di decomposizione è normale nelle vittime di montagna; la radioattività rinvenuta sugli abiti era minima e perfettamente compatibile con la radioattività cui potevano essere stati esposti gli studenti durante le attività di laboratorio; la mancanza della lingua di una vittima è riconducibile alla decomposizione o forse a qualche animale. Le sfere arancioni nel cielo erano i test del missile balistico R-7 “Semërka”[ref]La versione lanciatore “Vostok” di questo missile collocò in orbita il 4 ottobre 1957 il primo satellite artificiale creato dall’uomo, lo Sputnik 1.[/ref] entrato in servizio operativo proprio in quei giorni al cosmodromo di Plesetsk; il ritrovamento di corpi semi nudi può essere dovuto all’undressing paradossale: il corpo reagisce all’ipotermina con una vasocostrizione al fine di concentrare il sangue negli organi vitali, questo può causare nella vittima la sensazione improvvisa di caldo che induce a spogliarsi peggiorando la situazione, fino a causare la morte in poco tempo. Jurij Judin, l’unico sopravvissuto della spedizione, ha passato la sua vita a chiedersi cosa sia successo quella notte ai suoi amici: anche se non sarà molto di conforto, la spiegazione più plausibile è che si sia trattato di tanta sfortuna. [endmark]
Note
[references class=”compact” /]Bibliografia e fonti
- McCloskey, Keith Mountain of the Dead: The Dyatlov Pass Incident Stroud: The History Press, 2013. ISBN 978-0752491486
- Eichar, Donnie Dead Mountain: The Untold True Story of the Dyatlov Pass Incident San Francisco: Chronicle Books, 2013. ISBN 978-1452112749
- Ciampoli, Sonia “L’incidente di Passo Dyatlov” in Query, 11 Feb 2014. Web.
- Geraci, Angela “Mistero del Passo Dyatlov, c’è una nuova teoria…” in Corriere della Sera, 3 Feb 2014. Web.
- Smith, Anthony “Dyatlov Pass Explained: How Science Could Solve Russia’s Most Terrifying Unsolved Mystery” in International Science Times, 1 Ago 2012. Web.
- Dunning, Brian “Mystery at Dyatlov Pass” in Skeptoid, 8 Lug 2008. Web.
- Corcoran, Kieran “Has the mystery of nine skiers who died in the Siberian wilderness in 1959 been SOLVED?…” in Daily Mail, 24 Dic 2013
- “Le bufale dell’incidente del Passo Djatlov” in Mistero Risolto, 5 Lug. 2013. Web.
- “L’incidente del passo Dyatlov” in Bizzarro Bazar, 7 maggio 2012. Web.
- Fuso, Silvano “Chiedi all’esperto” in Vialattea.net, n.d. Web.
- “Dyatlov Pass Answers” in Aquiziam Mysteries, n.d. Web.
Quod est veritas? Che cosa è la verità? Con queste parole, riportate dai Vangeli, un incredulo Ponzio Pilato sintetizzava con rara efficacia la difficile ricerca della sfuggente Verità. Oggi, come allora, il confine tra verità e menzogna è una membrana quanto mai porosa in cui l’informazione si mescola con la disinformazione ed è sempre più difficile distinguere i fatti dalla pula pervasiva ed indefinibile delle mezze verità, delle incognite indecifrabili, delle falsità. La stessa Internet, salutata da molti come la democratizzazione dell’informazione, viene invece oggi criticata come il mezzo perfetto per la diffusione massiccia ed immediata di teorie cospiratorie, pseudo–complotti dalle più fantasiose idee senza alcun fondamento scientifico o storico. Prima ancora dell’avvento della noosfera informatica studiosi della comunicazione avevano già ipotizzato la diffusione di notizie tramite il semplice passa parola di cui i moderni social network sono soltanto una versione più rapida e potente. Il famoso semiologo Sebeok era giunto alla sorprendente conclusione che l’unico sistema per mantenere vivo nel tempo il ricordo della posizione e del pericolo di un giacimento di scorie radioattive, fosse quella di istituire una sorta di “casta sacerdotale” con il compito di custodire e tramandare oralmente la pericolosità del materiale seppellito. La stessa “congregazione” di custodi di scorie nucleari avrebbe poi diffuso deliberatamente racconti e leggende sul luogo “maledetto” contribuendo fattivamente ad allontanare eventuali curiosi. Il tempo avrebbe forse cancellato il ricordo del perché quel luogo dovesse essere tanto temuto, ma la paura e la distorsione delle informazioni non avrebbero reso meno efficace l’allontanamento dai materiali così a lungo radioattivi. Se infatti il tempo di dimezzamento medio di alcuni radio–isotopi è di circa 10 000 anni, potremmo arrivare a pensare che la disinformazione e l’inganno perpetrati abbiano un fine quanto mai utile. Lo stesso antropologo Brunvard, colui che per primo ha raccolto e studiato il fenomeno delle leggende contemporanee, in The Truth Never Stands in the Way of a Good Story (2000) sottolinea come l’ipotesi di Sebeok colga perfettamente l’essenza del funzionamento delle cosiddette “leggende metropolitane”. Ci troviamo tuttavia dinnanzi a fenomeni “naturali”, nati dalla semplice comunicazione umana e non appositamente diffusi con uno scopo. È allora lecito domandarsi: cosa accadrebbe se qualcuno organizzasse invece una campagna tesa alla diffusione di informazioni false per screditare qualcuno o qualcosa o addirittura un’intera area politica/culturale? E soprattutto è mai successo? Esistono prove storiche di reali complotti tesi ad “inoculare” il virus della disinformazione per screditare magari un blocco politico?
Dall’Ochrana all’operazione “Infektion”
La diffusione di notizie, informazioni e racconti attraverso il passaparola o la diffusione di pamphlet a tesi è stato da sempre uno degli espedienti più utilizzati per la propagazione di preconcetti, idee distorte con preciso scopo politico o sociale. È sufficiente osservare quanto la ricerca storica abbia scoperto riguardo il falso/plagio dei “Protocolli dei Savi Anziani di Sion” per avvalorare la tesi secondo la quale le assurde affermazioni del libro, credute come vere, siano state una delle concause che hanno spinto o comunque creato il pretesto che ha condotto fino al terribile fenomeno della Shoah. La ricostruzione storica ha dimostrato il ruolo fondamentale che ha giocato l’Ochrana, la polizia segreta della Russia zarista, nel pilotaggio della creazione di questo falso storico. Esiste quindi un precedente storico che dimostra la predisposizione all’uso di quelle che vengono definite oggi come “misure attive”, termine che può essere tradotto in maniera molto più semplice come “disinformazione”.
Ci troviamo dinanzi alle prove di un complotto per la propaganda di uno “pseudo-complotto” attribuito falsamente ad uno “pseudo-complotto”: un perverso gioco di parole che riesce a malapena a delineare il gioco sottile di rimandi, falsità e disinformazione oramai quasi impossibili da dipanare.
La ricerca storica nel periodo della guerra fredda ha mostrato prove inequivocabili dell’esistenza di una vera e propria campagna di disinformazione tesa a screditare gli Stati Uniti d’America. La diffusione, come una vera e propria inoculazione di un virus, di una falsa notizia riguardante l’AIDS è partita il 17 luglio del 1983 dalle pagine del giornale di New Delhi (India), Patriot. L’articolo dal titolo “AIDS may invade India: Mystery disease caused by US experiments” riportava una presunta lettera anonima di un «well–known American scientist and anthropologist» il quale dichiarava che la diffusione nella città di New York dell’AIDS è ed era dovuta alla sviluppo di un virus appositamente creato dal Pentagono come nuova e pericolosa arma biologica.

1 – USA, 1987: operatore del “Centers for Disease Control” (CDC), organismo di controllo sulla sanità pubblica degli USA, maneggia agenti biologici in un laboratorio virologico di massimo contenimento.
Si tratta ovviamente di un’affermazione del tutto falsa, studi accreditati su riviste peer–review spiegano infatti che questo terribile virus è il risultato di una zoonosi partita dalle scimmie e poi diffusasi attraverso diversi “spillover” in Africa. Un attenta analisi dell’articolo sul Patriot evidenzia tuttavia come il tutto sia una “misura attiva” creata dal KGB. Il testo, infatti, ha numerose forme linguistiche che tradiscono come la lettera non sia stata scritta da persone di madre lingua, ma, con molta probabilità, appositamente tradotta. Inoltre è assodato, attraverso la testimonianza in un processo tenutosi a Londra dell’ex spia russa Ilya Dzhirkvelov, che il Patriot era un giornale in qualche modo finanziato ed utilizzato per altre campagne di questo tipo:
Los Angeles Times, 9 agosto 1987

2 – Piazza Dzerzhinsky (oggi Lubyanka) a Mosca, dove si trovava il quartier generale del KGB: se la diffusione del virus dell’HIV ha avuto inizio in Africa, quella della disinformazione ha avuto inizio probabilmente qui.
La pubblicazione sul Patriot non ebbe un grande seguito ma creò comunque un importantissimo precedente che fu più volte invocato. Un documento ufficiale del Dipartimento di Stato Americano di quegli anni (“Soviet Influence Activities: A Report on Active Measures and Propaganda, 1986–87” agosto 1987 ), pur riportando il titolo ed il nome della testata, non fa riferimento ad una data corretta di pubblicazione nè al numero di pubblicazione del giornale. Tutto questo dimostra come il governo americano non fu in grado all’epoca di reperire una copia del giornale pur essendo sicuro della sua pubblicazione. Il famoso “Dossier Mitrokhin”[ref]Col nome di archivio (o dossier) Mitrokhin ci si riferisce ai materiali che l’ex funzionario del KGB, Vasilij Nikitič Mitrochin raccolse durante la sua attività e poi divulgò in tre volumi.[/ref] riassume efficacemente in un paragrafo la vicenda aggiungendo ulteriori dettagli:
C. Andrew, Vasilij Mitrokhin The Mitrokhin Archive II: The KGB and the World (2005)
L’inizio della diffusione su grande scala può comunque avere come punto di riferimento l’articolo del settimanale sovietico Literaturnaya Gazeta del 30 Ottobre 1985 (sopra) che riporta “letteralmente” quanto stampato sul Patriot. Questa pubblicazione può essere ritenuta a tutti gli effetti il “paziente zero” di un’epidemia mediatica che ha coinvolto tutto il mondo e ha consolidato un vero e proprio mito–leggenda ancora oggi difficile da debellare. Il culmine della campagna di disinformazione si ebbe comunque con la pubblicazione di una vignetta sul quotidiano Pravda (Правда) il 31 ottobre 1986. Nel disegno era raffigurato un “medico” che consegna, dietro pagamento in dollari, la fiala di un virus ad un militare (da notare che il virus ha la forma di piccole svastiche!), mentre a terra è possibile vedere numerosi piedi distesi a simboleggiare le vittime di questo terribile retro–virus. Dopo il mutato periodo politico e l’avvento della Glasnost’ si ebbe un parziale arresto della campagna di disinformazione: la falsa notizia, come sappiamo, fu «ufficialmente ripudiata».
Christopher Andrew e Vasilij Mitrokhin, The Sword and the Shield (1999), pag. 244–245.

5 – Fort Detrick, Maryland: edificio del U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID). Qui, secondo il mito, sarebbe stato “fabbricato” il virus dell’HIV.
La ricerca storica contemporanea si sta ora focalizzando sulla figura di Jakob Segal e sul ruolo giocato dalla STASI come propagatrice della campagna di disinformazione ideata dal KGB. Se è infatti ormai assodato l’origine e lo scopo iniziale dell’operazione “Infektion” creata dal KGB, non altrettanto possiamo dire della STASI, la polizia segreta dell’ex-DDR e se abbia o meno fatto parte del presunto “pseudo complotto”. Ci troviamo infatti dinanzi alle prove di un complotto per la propaganda di uno “pseudo-complotto” attribuito falsamente ad uno “pseudo-complotto”: un perverso gioco di parole che riesce a malapena a delineare il gioco sottile di rimandi, falsità e disinformazione oramai quasi impossibili da dipanare.
Il Prof. Dr. Erhard Geissler, in un suo articolo su Pubmed dal titolo “Disinformation squared: was the HIV-from-Fort-Detrick myth a Stasi success?”,[ref]Geißler, Dr. Erhard, RH Sprinkle: Pubmed, Autunno 2013 (op. cit. )[/ref] parla di “disinformazione al quadrato”. Il leggendario Markus Wolf[ref]Markus Johannes Wolf (1923 – 2006), è stato un agente segreto delle repubblica democratica tedesca, vicedirettore del Ministero per la Sicurezza di Stato dal 1954 al 1989 nonché fondatore e direttore, per lo stesso organismo, dell’Hauptverwaltung Aufklärung o HVA, organismo deputato a coordinare le attività di spionaggio e di intelligence al di fuori del Paese.[/ref] in un suo articolo, scritto in occasione di un dibattito sulla simulatio a Milano, descrive nel dettaglio l’operato della divisone “provvedimenti attivi” che aveva lo specifico compito, come abbiamo visto, di diffondere attraverso radio e giornali notizie false. Tale operato serviva a screditare pubblicamente il blocco occidentale con evidenti vantaggi politici sul piano internazionale. Questo era proprio quello che si voleva fare tramite l’assurda notizia dell’AIDS come arma di distruzione di massa; quello che più colpiva era che personaggi famosi come il biologo Jakob Segal erano stati manipolati insieme a scrittori ed intellettuali proprio per contribuire ingenuamente alla diffusione della notizia.
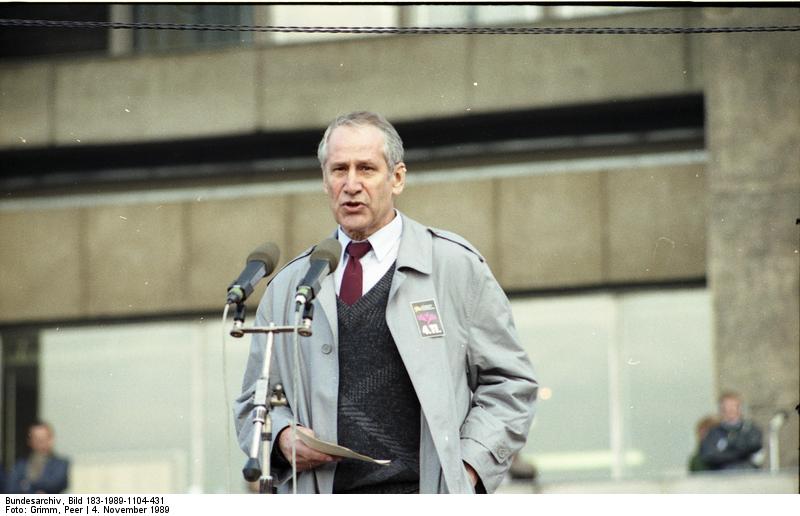
6 – Berlino, 1989: Markus Wolf in Alexanderplatz. All’epoca era vicedirettore del Ministero per la Sicurezza di Stato della Germania Est (Bundesarchiv).
Nel libro L’uomo senza volto di Wolf (ed. Rizzoli, 1997) viene raccontato come veniva creata una “misura attiva” e si resta veramente sconcertati di come i mezzi di comunicazione siano così vulnerabili a contaminazioni esterne tese a screditare un blocco politico. Ecco dunque, per esempio, un breve estratto del citato articolo di Wolf:
Un esempio particolarmente significativo di come alcune menti di proposito si rendano indipendenti e di come i maestri della disinformazione non riescano più a distinguere l’invenzione dalla realtà è il caso della pubblicazione circa la provenienza del virus dell’AIDS. Più o meno quando il mio congedo dal servizio era imminente, nell’autunno del 1986, la divisione per i “provvedimenti attivi” ricevette dal suo partner del servizio informazione sovietico del materiale con l’indicazione di contribuire alla sua diffusione in Occidente. Diceva che il virus HIV era stato coltivato in un laboratorio segreto di tecnologia genetica negli Stati Uniti e il suo effetto sperimentato su alcuni detenuti, dapprima era stato trasmesso all’esterno e poi nel resto del mondo. Quasi contemporaneamente a questo consiglio proveniente da Mosca il famoso biologo Jakob Segal con sua moglie, l’immunologa Lilly Segal pubblicava un lavoro su “AIDS: natura e origini”, in cui venivano provate le stesse affermazioni suffragate nei dettagli da numerosi argomenti scientifici. Bastò un’intervista dello scrittore Stefan Heym, residente a Berlino Est e considerato spesso e volentieri come dissidente in Occidente, con il professor Segal su un giornale di Berlino Ovest e tali argomentazioni trovarono la strada verso il pubblico. La reazione sia tra gli scienziati che tra i lettori fu violenta. L’ambasciatore americano a Berlino si vide costretto a scrivere una lettera di protesta. Gli argomenti dei Segal, in sostanza, facevano emergere il fatto che il virus HIV non poteva assolutamente provenire dall’Africa tanto meno attraverso i morsi dei cercopitechi, bensì attraverso la manipolazione genetica di un laboratorio P-4 in un edificio 550 rigorosamente schermato a Fort Detrick nello stato del Maryland. L’argomentazione sembrava essere convincente anche se alcuni retrovirologi contestarono immediatamente la possibilità della combinazione dell’HIV, secondo il campione presentato da Segal, e la forza probatoria della sua catena indiziaria. Io, come la maggior parte dell’opinione pubblica, diedi per scontata la probabilità di questa tesi. Perché gli Stati Uniti avrebbero dovuto comportarsi nella ricerca delle armi biologiche diversamente da come si comportarono negli esperimenti dimostratisi radioattivi che furono condotti per trent’anni su circa 700 uomini, tra i senza tetto, i detenuti “volontari”, i pazzi? Intanto pare che la catena indiziaria dei Segal fosse stata fatta saltare e che un alto ufficiale del KGB abbia rivendicato il diritto sulla paternità spirituale dì questo provvedimento attivo. Rimase oscuro anche a me e lo è tuttora, chi in questo caso ingannò deliberatamente e chi si fece ingannare. L’Occidente non risultò colpevole di tali inganni.
Il Venerdì di Repubblica, tratto da un articolo di KOS nº 151, pp. 44–45, 47, 49.
Come possiamo valutare quanto riportato da Markus Wolf? Ci fu da parte della STASI un aiuto alle teorie del biologo Jakob Segal? Fu manipolato o semplicemente lasciato libero di perpetuare le sue pseudo–teorie? I dati storici sono in questo caso contrastanti e non possono fornirci un quadro chiaro della situazione. Jakob Segal (con sua moglie Lilli) fu l’unico biologo della DDR a sostenere, fino alla sua morte a Berlino, la teoria della creazione dell’AIDS in USA arrivando a teorizzare l’incrocio di due virus come il VISNA e l’HTVL I. Intervistato dichiarò di non aver mai collaborato con la STASI in nessun modo. Tuttavia due ex spie della STASI nel loro libro Auftrag Irreführung. Wie die Stasi Politik im Westen machte (Carlsen Verlag, Hamburg 1992) lo accusarono di essere uno dei primi “propagatori” della leggenda. I documenti ritrovati descrivono però un diverso scenario: più volte Segal tentò di far accreditare la propria teoria che non trovò comunque un riscontro politico.
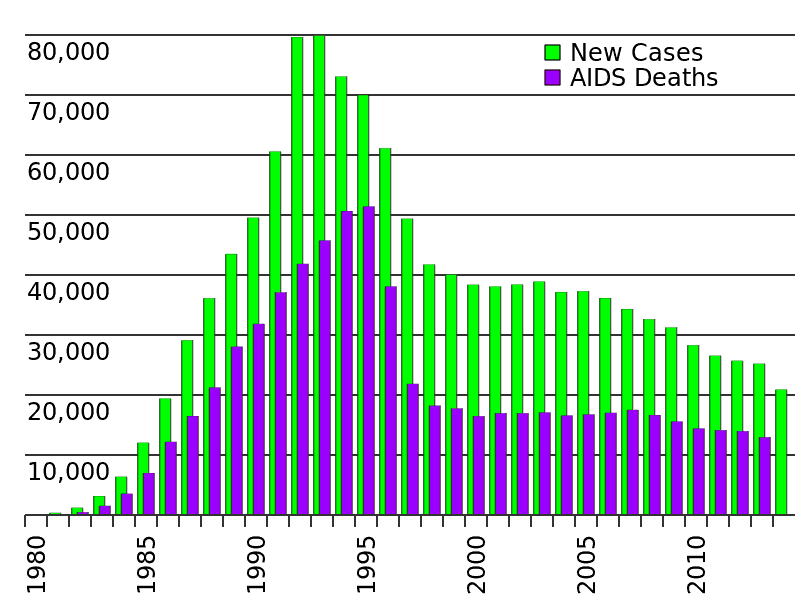
7 – Nuovi casi e decessi da AIDS negli USA tra il 1980 e il 2014: dati da Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “HIV Surveilabnce Report”, vol. 13-24.
Questa che potrebbe sembrare una semplice guerra di informazioni senza alcuna rilevanza sulla salute pubblica ha avuto invece numerose e gravi ripercussioni sulla realtà. Uno studio dal titolo “Are HIV/AIDS Conspiracy Beliefs a Barrier to HIV Prevention Among African Americans?” ha dimostrato come la diffusione della falsa notizia, riguardo la creazione in laboratorio del virus dell’AIDS, abbia spinto incredibilmente buona parte della popolazione afro–americana a non usufruire di misure di prevenzione o a non diminuire comportamenti a rischio di contagio. Inoltre secondo lo studio “Conspiracy Beliefs About the Origin of HIV/AIDS in Four Racial/Ethnic Groups”, statistiche su ben quattro gruppi etnici riportano una alta diffusione di teorie cospiratorie riguardo all’uso del AIDS come arma per un ipotetico “genocidio” razziale. Numerosi “negazionisti” dell’HIV–AIDS usano ancora oggi derivazioni dell’originale erronea informazione per propugnare le più disparate e pseudoscientifiche teorie. È necessario quindi comprendere quali siano i meccanismi che hanno reso possibile la propagazione di tale disinformazione per tentare di arginare il suo diffondersi. Quello che per ora può essere ritenuto l’unico incredibile risultato che supera lo spazio ed il tempo è, come riporta nel suo saggio Thomas Boghart, che: «(L’) intelligence del blocco sovietico ha creato un mostro che è sopravvissuto ai suoi stessi creatori.[ref]Da Studies in Intelligence, Dic. 2009 (op. cit.)[/ref]» [endmark] [references class=”compact” /]
Bibliografia e fonti
- Labanti, Roberto “Di spie, di cospirazioni e di epidemie” CICAP, 28-11-2014. Web
- Gillette, Robert “AIDS: A GLOBAL ASSESSMENT: Soviets Suggest Experiment Leaks in U.S. Created the AIDS Epidemic” Los Angeles Times, 9 agosto 1987.
- Mitrokin, Vasilij, C. Andrew The Mitrokhin Archive II: The KGB and the World Penguin, 2005.
- Mitrokin, Vasilij, C. Andrew The Sword and the Shield Basic Books, 1999. Pag. 244–245.
- “AIDS as a biological weapon” IIP Digital. U.S. Department of State, 14 gennaio 2015.
- Geissler, Dr. Erhard “Qudratdesinformation selbst durch die BStU“
- Geissler, Dr. Erhard, RH Sprinkle “Qudratdesinformation selbst durch die BStU“ Pubmed, Autunno 2013.
- Boghardt, Thomas. 2009. “Operation INFEKTION: Soviet Block Intelligence and Its AIDS Disinformation Campaign.” in Studies in Intelligence – Journal of the American Intelligence Professional (CIA), Dicembre 2009 Vol.53 nº 4, pp. 1–24. CIA.
- Selvage, Douglas, Christopher Nehring Die AIDS-Verschwörung. BStU, 2014. ISBN 978-3-942130-76-9
- Geissler, Dr. Erhard “The AIDS Myth at 30” International Journal of Virology and AIDS, 3 marzo 2016.
- “Soviet Influence Activities: A Report on Active Measures and Propaganda, 1986 – 87” United States Department of State, agosto 1987.
- Bogart, Laura M., PhD, Sheryl Thorburn, PhD “Are HIV/AIDS Conspiracy Beliefs a Barrier to HIV Prevention Among African Americans?” JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, Vol 38 nº2, 1 febbraio 2005.
- Ross, Michael W, E. James Essien, Isabel Torres. “Conspiracy Beliefs about the Origin of HIV/AIDS in Four Racial/Ethnic Groups” JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, Vol 41 nº3, marzo 2008. Pag 342–344. (in NCBI).
Ringraziamenti
Un grazie speciale va alla Dott.ssa Graziella Morace che ha corretto le prime bozze di questo articolo ed a Roberto Labanti che, oltre a trovare l’articolo originale scritto sulla rivista KOS, mi ha fornito preziosi consigli sulle diverse fonti.
Immagini
Copertina: © Andreas Gradin / Fotolia.
-
- 1987 c.a [PD] CDC / U.S. National Library of Medicine.
- Mosca 1966, RIA Novosti archive / Valeriy Shustov [CC-BY-SA 3.0] Commons.
- Literaturnaya Gazeta, 30 Ottobre 1985.
- Pravda, 31 Ott. 1986.
- Fort Detrick, 2008 U.S. Army [PD] Commons.
- Berlino 1989, Bundesarchiv / Grimm, Peer [CC-BY-SA 3.0] Commons.
- 2014, [PD] Commons.
Articolo già pubblicato su Medium l’8–6–2016 e riadattato per Laputa per concessione dell’autore.
[mapsmarker marker=”229″ basemapDefault=”googleTerrain” width=”100″ widthUnit=”%” height=”480″ panel=”false”]
La notte tra il 25 ed il 26 aprile 1986 il reattore numero 4 della centrale elettronucleare di Černobyl’ esplose, proiettando nell’atmosfera vapori e polveri altamente radioattive: fu il più disastroso incidente mai verificatosi in una centrale nucleare e uno degli unici due classificati al massimo livello della scala INES dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica: l’altro è quello di Fukushima del 2011.
Quello che, a stare alle dichiarazioni dei fisici, sarebbe potuto accadere al massimo una volta in 10.000 anni, adesso è accaduto. Diecimila anni si sono fusi in questa giornata. La legge delle probabilità ci ha fatto capire che intende essere presa sul serio.[ref name=”guasto”]Wolf, Christa Guasto — notizie di un giorno. Roma: Edizioni E/O , 1997. Pag. 34 e 47. ISBN 88-7641-308-1[/ref]Christa Wolf, scrittrice della Repubblica Democratica Tedesca
Il principio di funzionamento di una centrale atomica non è molto diverso da quello di una centrale idroelettrica o a vapore: ci sono delle grosse turbine che, girando, azionano enormi generatori di corrente. Anziché la forza dell’acqua imprigionata in una diga, o il vapore prodotto dalla combustione del carbone, del gas o anche della spazzatura, si impiega il vapore prodotto dall’acqua di raffreddamento di un reattore nucleare a fissione. Esistono diversi tipi di reattori, quello impiegato a Černobyl’ è del tipo RBMK (acronimo per Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj, ovvero “reattore di grande potenza a canali”), raffreddato ad acqua e moderato a grafite. Non inganni il termine moderato, che nell’uso comune ha un significato differente: in fisica un “moderatore” è un materiale che ha la funzione di rallentare i neutroni veloci prodotti dalla fissione, in modo da aumentare la loro efficacia nel colpire e spezzare un atomo fissile.
Il moderatore, in pratica, è necessario per aumentare il numero di fissioni all’interno del nocciolo, facendo sì che la reazione a catena sia in grado di autosostenersi: quando ciò avviene, si dice che il sistema è “critico” (curiosa l’inversione semantica secondo la quale moderare significa aumentare e una condizione detta critica è invece desiderabile, anzi perseguita mediante accorgimenti tecnici). Per evitare che la reazione aumenti in modo incontrollato, con conseguenze disastrose, si usano “barre di controllo”[ref]Dette anche “barre di moderazione”: nell’articolo evitiamo questo termine per evitare confusione con il “moderatore” che ha funzione opposta.[/ref] mobili fatte di un materiale metallico che a differenza del moderatore ha una elevata capacità di assorbire i neutroni lenti, riducendone quindi la capacità di colpire un atomo fissile: l’equilibrio tra la quantità di moderatore e la quantità di assorbitore (o “veleno”) mantiene la reazione allo stato critico. Il nocciolo del reattore RBMK è quindi un grande cilindro di grafite che funge da moderatore, attraversato da canali paralleli (da qui la definizione di “reattore a canali”) dentro i quali sono disposte alternativamente le barre di combustibile fissile, in questo caso ossido di uranio arricchito al 2% con uranio-235, e le barre di controllo mobili di boro (un semimetallo[ref]Elemento con proprietà intermedie tra quelle dei metalli e dei non metalli.[/ref]), oltre a qualche barra di uranio-238 che veniva così arricchita per la produzione di plutonio destinato alle armi nucleari. Questi canali sono attraversati dall’acqua “leggera” ovvero comune acqua, così detta in contrapposizione all’acqua arricchita con deuterio, detta “pesante”, utilizzata come moderatore in altri tipi di reattori nucleari.
L’acqua assorbe l’enorme calore prodotto dalla reazione trasformandosi in vapore, che viene convogliato sotto pressione alle turbine a due stadi per la produzione di energia elettrica. Il vapore esausto viene raffreddato in uno scambiatore, che dissipa il calore residuo nell’acqua fredda proveniente dal fiume. I due circuiti restano separati: il vapore così raffreddato diventa acqua bollente che ritorna nel reattore per un nuovo ciclo, mentre l’acqua del fiume — se tutto è andato bene — è calda ma priva di radioattività e può essere reimmessa nell’ambiente. A Černobyl’ l’acqua è ovviamente prelevata dal Pryp’jat’ e prima di tornare nel fiume, viene raffreddata in un apposito stagno dove dal 1979 si alleva pesce destinato all’industria alimentare, immesso poi sul mercato (come evidenzia una rapporto del KGB del 1981) senza alcun controllo.
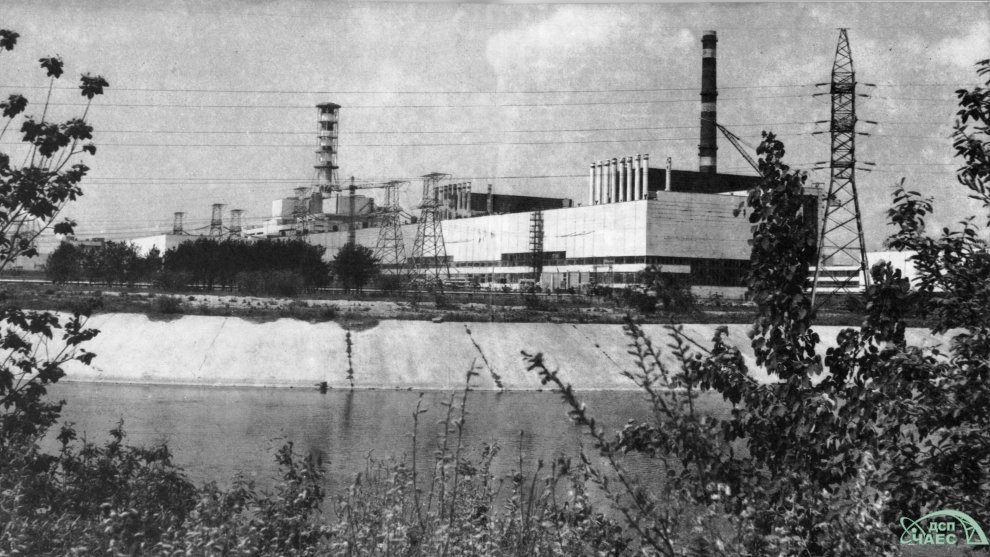
4 – Centrale “V.I. Lenin” di Černobyl’ nel 1984: in primo piano lo stagno di raffreddamento (chnpp.gov.ua).
Ore 1:06 del 25 aprile 1986. È notte fonda a Pripjat’, mentre alla centrale si dà inizio alla procedura. Il reattore è alla potenza massima di 3200 megawatt termici; in preparazione al test viene avviato un programma di regolazione controllato dal computer che ridurrà lentamente la potenza fino al 50%, ovvero 1600 MW. Per regolare la potenza di un reattore nucleare si agisce sulle barre di controllo mobili: alzandole, sfilandole cioè dal nocciolo, diminuisce la quantità di moderatore che assorbe i neutroni lenti o “termici”; la reazione a catena aumenta quindi di intensità. In questo caso si dice che il sistema è “supercritico”. Interrompendo l’estrazione delle barre, la cui velocità deve essere determinata in fase di progetto per evitare reazioni impreviste, il sistema si stabilizza sulla potenza desiderata. Quando si vuole ridurre la potenza si reintroducono le barre di controllo, che assorbendo i neutroni lenti riducono l’intensità della reazione fino a spegnerla. Queste barre sono quindi anche il primo sistema di sicurezza attivo di un reattore a fissione: qualora gli strumenti rilevassero un valore anomalo (temperatura, potenza, pressione, radioattività) una serie di dispositivi ne provocherebbe l’inserimento automatico, spegnendo rapidamente il reattore anche senza l’intervento umano.
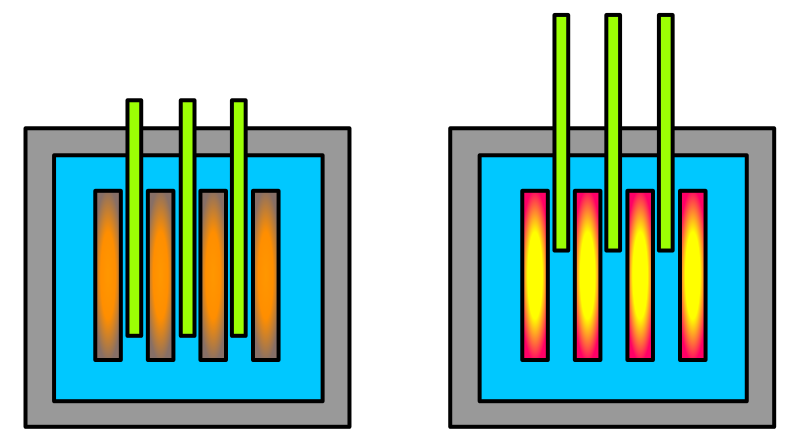
5 – Rappresentazione schematica del funzionamento delle barre di controllo: a sinistra le barre sono abbassate nel nocciolo e assorbono una maggiore quantità di neutroni, rendendo il reattore “sottocritico” (la potenza diminuisce); a destra sono sollevate e lasciano che una maggiore quantità di neutroni alimenti la reazioni a catena, in questo caso il reattore è “supercritico” (la potenza aumenta). Il reattore è “critico” quando la quantità di neutroni non catturati dalle barre è esattamente quella necessaria a mantenere la potenza stabile.
In realtà si tratta appunto di una leggenda: le barre di sicurezza erano azionate da un circuito elettromeccanico[ref]Fermi, Enrico “Experimental production of a divergent chain reaction“. 1951.[/ref] ma l’immagine pionieristica dell’uomo con l’ascia rende efficacemente l’idea di come funzioni l’arresto di emergenza di un reattore nucleare. Ma c’è un problema. Un reattore di potenza come l’RBMK non può mai essere totalmente “spento” come può esserlo un motore o un televisore: il combustibile fissile continua a produrre una grande quantità di calore che deve essere evacuato mantenendo in circolazione il liquido refrigerante, che nel RBMK è acqua. Per garantire un raffreddamento sufficiente, le 8 pompe elettriche di circolazione richiedono ben 5,5 megawatt, una potenza enorme ma che a pieno regime è appena lo 0,5% dell’energia prodotta dai turbogeneratori. A reattore spento, o in caso di rottura dei tubi del vapore in pressione, l’alimentazione alle pompe viene a mancare e devono quindi subentrare i generatori diesel di emergenza: questi però impiegano circa 60–75 secondi per arrivare a regime e qualora lo spegnimento fosse improvviso (scram) questo gap temporale potrebbe causare il surriscaldamento del nocciolo, con pericolose implicazioni di sicurezza. L’idea è quindi di verificare se il girante della turbina, prima di fermarsi, sia in grado di produrre per inerzia l’energia sufficiente ad alimentare le pompe di raffreddamento e i sistemi fondamentali per almeno 40–50 secondi, abbastanza per un passaggio sul filo del rasoio all’alimentazione di emergenza. Il precedente test sul reattore nº 3 si era svolto senza incidenti, ma aveva dimostrato che l’inerzia non era sufficiente e si era intervenuti migliorando i regolatori di tensione, che ora devono essere sottoposti a nuova verifica.
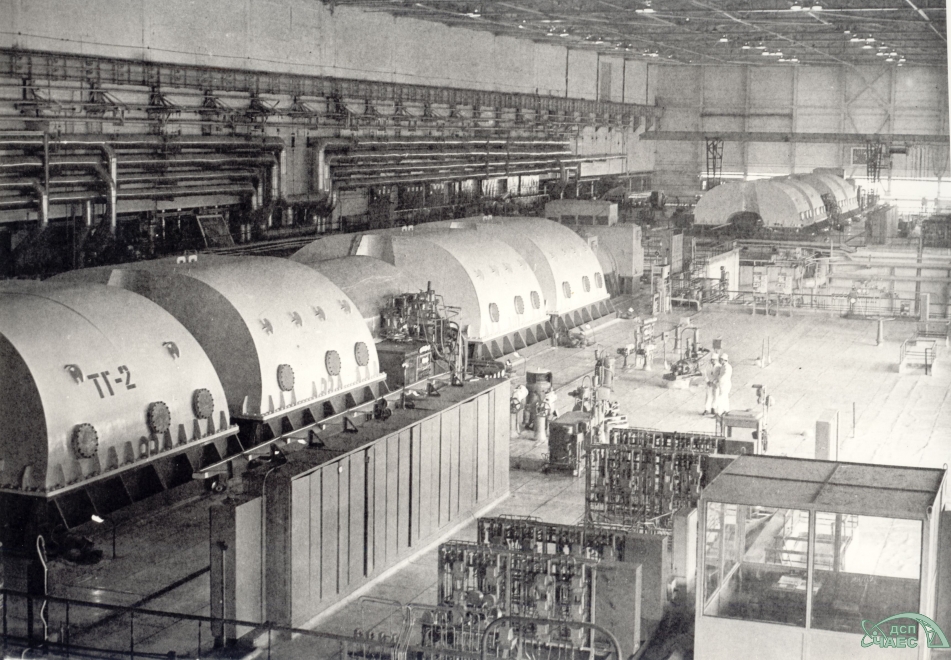
7 – Centrale di Černobyl’, sala dei turbogeneratori (chnpp.gov.ua).
Ore 3:47. Secondo la ricostruzione della World Nuclear Association, a quest’ora il livello del 50% viene raggiunto e la riduzione di potenza si arresta.[ref name=”wna”]cfr. World Nuclear Association (op. cit.)[/ref] Avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta al di sotto dei 1000 MW, ma a causa di un guasto ad un’altra centrale elettrica regionale l’ente gestore della rete[ref]Il cosiddetto “controllore” o “dispacciatore”.[/ref] chiede alla centrale “V.I. Lenin” di non ridurre ulteriormente la potenza per non lasciare scoperta l’area di Kiev: è venerdì e le fabbriche avranno bisogno di energia elettrica. Viene quindi fissato un nuovo orario, la una della notte successiva. Almeno, questa sarebbe stata la spiegazione ufficiale fornita dalla commissione d’inchiesta federale condotta da Valeriu Alexandrovici Legasov per giustificare un grave errore amministrativo, cioè che il test fosse lasciato al turno di notte quando l’organico era inferiore e il personale stanco o non addestrato. Legasov, considerato un valente accademico e persona dalla moralità irreprensibile,[ref name=”pavel”]cfr. Nică (op. cit.)[/ref] si suiciderà però nel giorno del secondo anniversario dell’incidente, il 26 aprile del 1988.

8 – Piloni della rete elettrica a Černobyl’ (Commons)
Ore 14:00. Il sistema di raffreddamento di emergenza viene escluso per evitarne l’intervento automatico, che vanificherebbe il test. Questo passaggio è previsto dalla procedura e non sarà tra le cause dirette dell’incidente.[backref name=”wna” /] Quello del raffreddamento, a ben vedere, non era nemmeno il problema principale: il vero responsabile del disastro sarebbe stato il cosiddetto “coefficiente di vuoto positivo”, una caratteristica tipica del reattore RBMK. Come abbiamo visto l’elemento moderante è necessario a rallentare i neutroni affinché siano in grado di alimentare la fissione. Se il moderatore è la stessa acqua di raffreddamento, quando questa arriva all’ebollizione viene sostituita dal vapore, che ha minore capacità moderante, e la reazione diventa immediatamente sottocritica fino a spegnersi o a stabilizzarsi su una potenza inferiore. Così, se il nocciolo si surriscalda o si verifica una perdita di liquido, il reattore si spegne: il “coefficiente di vuoto” in questo caso è negativo ed è un fattore di sicurezza intrinseco. Ma non è il caso del reattore RBMK che, invece, è moderato a grafite che è un materiale solido. Se viene a mancare l’acqua di raffreddamento, per ebollizione o perdita, il moderatore resta dove si trova continuando ad alimentare la reazione in un reattore che si sta surriscaldando. Né è possibile “svuotare” la grafite semplicemente aprendo un rubinetto. Inoltre l’acqua leggera ha un blando potere di assorbire i neutroni, tolto il quale la frittata è presto fatta: in questo caso si dice che il coefficiente di vuoto è positivo. Perché si scelse di usare un sistema così instabile per costruire in un reattore tanto potente? In gran parte per ridurre i costi, seppure a discapito della sicurezza. Un nocciolo in grafite, materiale più efficace come moderatore rispetto all’acqua pesante, consentiva di usare come combustibile l’uranio “lievemente arricchito” (SEU[ref name=”seu”]SEU, Slightly Enriched Uranium.[/ref]), con una concentrazione di uranio-235 non superiore al 2%, meno costoso di quello con gradi di arricchimento più elevati. Inoltre non c’era bisogno di utilizzare acqua “pesante” come moderatore, ma solo la più economica acqua leggera per il raffreddamento.
Ore 23:10. Su Pripjat’ è scesa la notte. La domanda di energia elettrica è inferiore e la procedura di riduzione della potenza può riprendere. V. P. Bryukhanov, il direttore della centrale, sta dormendo tranquillo nel suo appartamento nel centro della città, nel palazzo della nomenklatura che si affacciava su piazza Lenin. Gli incarichi importanti venivano spesso attribuiti in base alle logiche del partito più che a quelle del buonsenso o della necessità: il direttore, ad esempio, proveniva da impianti tradizionali e non aveva esperienza di impianti nucleari, come il capo ingegnere Nikolaj Fomin. Il vicecapo ingegnere responsabile dei reattori 3 e 4, Anatolij Djatlov, aveva esperienza con i piccoli reattori ad acqua pressurizzata installati sui sottomarini. Qui si trattava di tenere a bada un mostro migliaia di volte più potente: un demone, come quel Černobog della mitologia slava, oscura divinità il cui nome (“dio oscuro”) contiene la stessa radice čĭrnŭ (nero) da cui anche Černobyl’, che significa “erba nera”.[ref]Riferimento all’artemisia (Artemisia vulgaris), pianta erbacea molto comune nella zona[/ref]

10 – Centrale di Černobyl’, sala del reattore nº1 (chnpp.gov.ua).
Ore 24:00. Cambio del turno: il personale della notte prende servizio. Il supervisore Yuri Tregub viene sostituito dal collega Aleksandr Akimov alla “guida” del reattore, ma rimane sul posto. Al contrario di quella diurna però, la squadra della notte non era stata adeguatamente istruita alla procedura del test: da programma, avrebbero dovuto solo prendere in carico un reattore spento dal pomeriggio. Come gli “accudienti”, ovvero coloro che prendono in custodia la locomotiva a vapore durante le soste e non devono necessariamente avere l’esperienza del fuochista che conduce la caldaia in corsa.
Ore 00:28 del 26 aprile 1986. La potenza del reattore è scesa a 500 MW, quando le norme di sicurezza vietano il funzionamento prolungato al di sotto dei 700 MW perché l’instabilità del RBMK a bassa potenza è nota. L’operatore, l’ingegnere Leonid Toptunov, trasferisce il controllo dal sistema automatico “locale” (LAC) che controlla 12 barre, inefficace a potenza ridotta, a quello “globale” che agisce sulle altre 167 ma senza impostare sul computer il valore minimo da raggiungere.[ref]Altieri, pag. 45 (op. cit.)[/ref]
Grave errore, o forse un malfunzionamento del computer: la potenza precipita pericolosamente a 30 MW. Toptunov tenta di riguadagnare potenza estraendo le barre di controllo, ma il reattore è “avvelenato” dallo xeno-135, un prodotto di fissione che si accumula nel reattore quando si diminuisce repentinamente la potenza. In realtà questo viene prodotto anche durante il normale funzionamento dal decadimento dello iodio-135, ma viene eliminato dallo stesso processo di fissione poiché, assorbendo neutroni, diventa xeno-136 che è stabile. A bassa potenza o a reattore spento il flusso di neutroni viene a mancare e lo xeno-135 si accumula nel reattore. Assorbendo i pochi neutroni in circolazione agisce più o meno come le barre di controllo, limitando la reazione a catena fino a spegnerla. Il che, però, costituisce un serio problema perché falsa le letture degli strumenti, mascherando la normale reattività del nucleo, ma poi decade naturalmente liberandone di nuovo la potenza: è come avere delle barre di controllo supplementari invisibili, che si dissolvono lentamente. Per questo quando viene spento un reattore è necessario attendere due o tre giorni perché lo xeno-135 (che ha un tempo di dimezzamento di poco più di 9 ore) porti a compimento il suo processo di decadimento naturale eliminandosi. L’ingegnere capo Djatlov, descritto dai colleghi come irascibile e duro di comprendonio,[ref]Medvedev, pag. 52 (op. cit.)[/ref] non vuole doversi giustificare con Mosca per un ritardo nel test e fa quindi pressione perché si stabilizzi il reattore in qualche modo e si prosegua con il programma, nonostante tutto suggerisca di interrompere.
-
12 – Schema del nocciolo del reattore 4.
barre di controllo (167);
barre di controllo automatiche, LAC (12);
barre di controllo supplementari, sono più corte ed entrano dal basso (32);
sorgenti di neutroni per l’accensione (12);
tubi acqua/vapore in pressione, possono contenere anche le barre di combustibile (1661).
Ore 00:43:27. Secondo la ricostruzione della World Nuclear Association[ref name=”WNA”]WNA (op. cit.)[/ref] vengono disabilitati i controlli di sicurezza dei turbogeneratori, per prevenire l’interruzione automatica del test. La turbina numero sette era già stata esclusa per convogliare tutta la pressione disponibile sulla numero otto. Altro errore, perché significava eseguire il test senza una turbina di backup.
Ore 1:00. Nonostante solo 18 barre di controllo siano inserite, il reattore avvelenato dall’accumulo di xeno-135 raggiunge a malapena una potenza di 200 MW, abbondantemente al di sotto della soglia di sicurezza. Gli operatori attivano alla 1:03 ed alla 1:07 due pompe di raffreddamento supplementari oltre alle sei già in funzione per assicurare un adeguato raffreddamento del nocciolo dopo il test. A piena potenza termica, la pressione del vapore nel nocciolo genera una forte resistenza idraulica che le pompe devono vincere per poter garantire la circolazione dell’acqua di raffreddamento. Ma a una potenza così bassa, la pressione del vapore non riesce a contrastare le pompe che finiscono per spingere 60 000 m³/ora di acqua in un impianto progettato per 45 000 m³/ora. Il circuito va in cavitazione, i tubi vibrano minacciosamente, la pressione del vapore scende ulteriormente a causa del raffreddamento lasciando posto all’acqua, la cui capacità di catturare i neutroni lenti fa diminuire ulteriormente la potenza.
Ore 1:19. Secondo Grigori Medvedev, vice-capo ingegnere del reattore nº 1 e autore del libro The Truth about Chernobyl, a questo punto il disastro poteva ancora essere evitato rinunciando al test e riducendo gradualmente la potenza fino allo spegnimento. Anche quest’ultima occasione viene sprecata: per contrastare questa ulteriore perdita di potenza dovuta all’eccesso di acqua vengono estratte ulteriori barre di controllo. I sistemi di sicurezza che avrebbero dovuto intervenire automaticamente erano già stati disattivati.
Ore 1:22:30. Restano solo 8 barre di controllo inserite nel nocciolo, quando il minimo previsto dalle norme di sicurezza è 15.[backref name=”WNA” /] Gli operatori hanno ridotto manualmente il flusso di acqua per ripristinare la pressione del vapore, il reattore sembra stabilizzarsi ma la reazione è avvelenata dallo xeno-135. Toptunov osserva perplesso una stampa del computer: i parametri che vede suggeriscono un immediato spegnimento di emergenza del reattore. Esita, in fondo il computer può sbagliare, poi riferisce ad Akimov e Djatlov. Entrambi trovano i dati inquietanti, ma Djatlov ripone piena fiducia nella solidità della tecnologia sovietica: «Ancora due o tre minuti e sarà tutto finito, muoviamoci ragazzi!». L’ingegnere elettrico addetto alle misurazioni, Gennady Petrovich Metlenko, annuncia che l’oscillografo è acceso e pronto a misurare. È il segnale.
Il demone Černobog si sveglia, e non trova nessuna gabbia a contenerlo perché tutte le barre di controllo erano state estratte.
Ore 1:23:04. Igor Kershembaum, ingegnere capo addetto alle turbine, chiude la valvola che manda il vapore al turbogeneratore numero otto dando inizio alla fase cruciale del test. La turbina inizia a rallentare, la previsione è che riesca a produrre per inerzia l’energia sufficiente ad alimentare le pompe di raffreddamento. Gli elettricisti registrano sugli strumenti il calo di potenza elettrica. Alla chiusura della valvola di uscita, però, il vapore resta intrappolato nel nocciolo: le pompe avrebbero bisogno di maggiore energia per vincerne la pressione, ma sono sottoalimentate perché l’unica turbina si sta fermando e non ce la fanno. Il flusso d’acqua refrigerante si riduce drasticamente, il nucleo si surriscalda e l’acqua che si trova all’interno diventa vapore. Qui entra in gioco il “coefficiente di vuoto positivo”: senza più acqua ad assorbire i neutroni, l’effetto moderante della grafite prevale e la potenza inizia improvvisamente ad aumentare. Il demone Černobog si sveglia e non trova nessuna gabbia a contenerlo, perché quasi tutte le barre di controllo sono state estratte.
Ore 1:23:40. Alexandr Berezin, ingegnere capo addetto al monitoraggio del pannello, preme il pulsante AZ-5 che corrisponde al comando di “scram“, l’abbassamento contemporaneo di tutte le barre di controllo. Non è chiaro se lo scram viene eseguito a seguito dell’improvvisa ondata di potenza o se, come avrebbe scritto in seguito Djatlov, semplicemente perché si ritiene concluso l’esperimento. Le barre di controllo in carbonato di boro, come abbiamo visto, dovrebbero assorbire i neutroni placando la reazione a catena; ma per uno sconcertante errore di progettazione hanno terminali di alluminio lunghi un metro pieni di grafite: abbassandole tutte insieme si ottiene che per i primi istanti si introduce dell’altro moderante (la grafite) che prende il posto dell’acqua causando inizialmente un ulteriore aumento di potenza. L’abbassamento completo delle barre avrebbe richiesto 18–20 secondi, ma in soli quattro secondi la potenza raggiunge un livello pari a mille volte quello nominale.[ref name=”lewins”]Lewins, pag. 20. (op. cit.)[/ref] In condizioni normali, un aumento di temperatura avrebbe causato una diminuzione della reattività dell’uranio, stabilizzando così il reattore: è il cosiddetto “coefficiente di temperatura negativo”. L’incremento di potenza è però troppo improvviso e violento, il coefficiente di vuoto ha il sopravvento su quello di temperatura. Il nocciolo raggiunge i 2000 °C, i canali si deformano per il calore bloccando la discesa delle barre di controllo a circa 2/3 della corsa e rendendo così impossibile il completamento dello scram: il reattore è definitivamente fuori controllo, è il meltdown nucleare. Gli operatori sganciano il meccanismo di manovra della barre, sperando che queste scendano per gravità, ma senza successo. Intanto, a causa dell’altissima temperatura, l’acqua presente nel nocciolo si scinde in ossigeno e idrogeno, quest’ultimo si combina con il carbonio della grafite formando metano: il reattore si riempe così di gas altamente infiammabili.
L’esplosione

13 – Chernobyl. L’ultimo giorno di Pripjat, dipinto di Alexey Akindinov, 2014 (Commons).
Ore 1:24 del 26 aprile 1986. La pressione del vapore causa una violenta detonazione che solleva la piastra di copertura del reattore pesante mille tonnellate e distrugge il tetto dell’edificio, lasciando scoperto il nocciolo del reattore all’aria esterna: pochi istanti dopo l’ossigeno presente nell’atmosfera si mischia con i gas infiammabili creando una miscela che, a contatto con la grafite incandescente, provoca una seconda, violentissima esplosione. Frammenti di grafite, uranio, tubature, barre di controllo ed altri materiali fortemente radioattivi vengono proiettati fino ad un chilometro di distanza, il catrame del rivestimento del tetto si incendia. L’edificio è poco più di un capannone industriale: il reattore RBMK era troppo grande per realizzare una struttura di contenimento che, oltretutto, non era ritenuta fondamentale in virtù della perfezione della tecnologia sovietica. Nei minuti seguenti alle due esplosioni i tecnici non hanno un’idea della portata del disastro. Akimov è convinto che il reattore sia integro e resta nella struttura. Gli strumenti utilizzati per le prime misurazioni sono del tutto inadeguati ad una emergenza: hanno fondo scala ad appena 3,6 Röntgen/ora. Il direttore Bryukhanov, svegliato nel cuore della notte da una telefonata nel suo appartamento di Pripjat’, comunica a Mosca il valore indicato dagli strumenti, ma in un secondo tempo ci si accorge che nei pressi del reattore nº4 la radioattività è cinquemila volte superiore: quando all’esterno vengono registrati valori incredibili, che raggiungono i ventimila Röntgen/ora, si pensa inizialmente che la strumentazione sia guasta e il problema continua ad essere sottostimato. Intanto i pompieri, ai comandi del tenente Vladimir Pravik, arrivano in pochi minuti dalla vicina caserma di Pripjat’ e sono già sul tetto dell’edificio nel tentativo di spegnere l’incendio; ignari del pericolo e privi di qualunque protezione efficace, a pochi passi dalla cosa più radioattiva che l’umanità avesse mai conosciuto fino ad allora. Sarebbero tutti morti nel giro di qualche giorno.
Ore 5:00. I pompieri hanno spento i focolai di incendio, ma la grafite del nocciolo è ancora in fiamme. L’acqua delle lance non riesce a placare il fuoco e si trasforma immediatamente in vapore radioattivo. Si decide quindi di ricorrere agli elicotteri militari per gettare sul nocciolo pesanti sacchi di sabbia addizionata di boro (il materiale usato per le barre di controllo), piombo e dolomia: anche gli equipaggi di questi velivoli si esporranno così ad elevatissime dosi di radiazioni. Intanto, sebbene le voci comincino a diffondersi, gli abitanti di Pripjat’ restano ufficialmente all’oscuro di quanto sta accadendo fino alla mattina del 27 aprile, quando viene finalmente dato l’ordine di evacuazione della città.
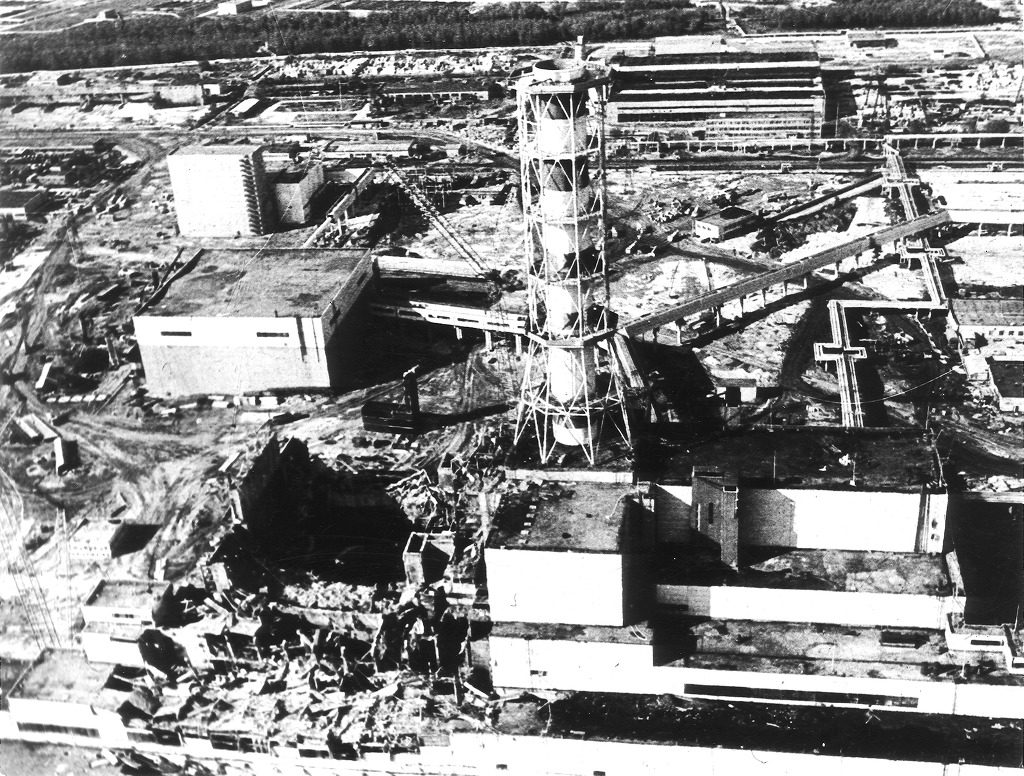
14 – Il reattore 4 distrutto dall’esplosione, in una foto aerea scattata poco dopo l’incidente, il 28 aprile 1986.
Lunedì 28 aprile. Le autorità sovietiche ed ucraine tentano di mantenere il silenzio, ma la nube radioattiva si sta già diffondendo verso l’Europa. Alla centrale nucleare di Forsmark, in Svezia, viene rilevata una quantità anomala di radiazioni dalle scarpe di un tecnico di ritorno da una pausa. Scatta l’allarme, ma dai primi accertamenti sembra che la contaminazione non arrivi dal reattore: viene da fuori. Basta poco, agli svedesi, per capire che la fonte è un’immensa nube che sembra provenire da oltre la cortina di ferro. Da Mosca arrivano solo risposte vaghe, ma i satelliti spia americani fotografano l’incendio dimostrando in modo incontrovertibile che qualcosa è successo e la notizia si diffonde in tutto il mondo con un impatto emotivo enorme. Anche, finalmente, “oltre cortina” dove si stima che il 36% dei sovietici abbia appreso la notizia prima da una radio occidentale che dagli organi di informazione del proprio paese.
A partire da quelle esplosioni nucleari i fondamenti della vita si sono rivelati come un terno al lotto. E la stessa aureola di infallibilità e sicurezza basata sui fondamenti delle scienze si è disintegrata.[ref]in L’espresso nº 28 anno LIII, 19 luglio 2007, p. 107.[/ref] Ulrich Beck, sociologo tedesco.

15 – Minatori privi di protezioni scavano il tunnel di raffreddamento.
Si teme che il nocciolo possa sprofondare cadendoci dentro e provocando così una enorme, catastrofica esplosione di vapore. Si prende così la decisione di inviare una squadra di sommozzatori che, consapevoli dei rischi della missione, si immergono eroicamente nell’acqua altamente contaminata per azionare manualmente le valvole che avrebbero svuotato le vasche. Ma non basta: la centrale “V.I. Lenin” era stata costruita nel bel mezzo delle paludi del fiume Pryp’jat’, l’acqua è ovunque. Se fosse entrata in contatto con il materiale fuso avrebbe potuto causare una violenta esplosione di vapore, senza contare la contaminazione delle falde. Per scongiurare il disastro viene scavato a braccia un tunnel di raffreddamento sotto il reattore, in condizioni di temperatura e radioattività proibitive. Sul tetto dell’edificio la quantità di radiazioni è talmente elevata da causare problemi ai circuiti dei robot telecomandati che devono rimuovere i frammenti di grafite.
Entro sette mesi dall’esplosione, a novembre 1986, viene completato il cosiddetto “sarcofago” progettato dall’ingegnere Lev Bocharov, una struttura di contenimento fatta di 400 mila m³ di calcestruzzo e 7300 tonnellate di ferro.[ref]Ebel, Robert E.; Chernobyl and its aftermath: a chronology of events (1994 ed.). Washington D.C; CSIS. ISBN 978-0-89206-302-4.[/ref] Queste persone — pompieri, militari, riservisti, personale sanitario e volontari civili — che con ammirabile abnegazione lavorano alla messa in sicurezza del sito saranno in seguito chiamati “liquidatori” (ликвидаторы); status che avrebbe garantito loro, in cambio del sacrificio della propria vita, una medaglia, una paga per le ore di servizio ed una pensione anticipata che molti di loro non riusciranno comunque a raggiungere.
Le conseguenze dell’incidente furono pesantissime: 65 le vittime dirette, più un numero di vittime presunte che va dalle quattromila persone stimate dal Chernobyl Forum[ref]Rapporto del Chernobyl Forum, incontro istituzionale promosso dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica tenutosi a Vienna tra il 2003 ed il 2005, cui parteciparono altre organizzazioni dell’ONU, Banca Mondiale, autorità della Russia, Bielorussia e Ucraina: “Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine” (PDF), International Atomic Energy Agency, pp. 16-17.[/ref] dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica dell’ONU alle 30–60 mila stimate da un rapporto del Partito Verde Europeo,[ref]Rapporto “TORCH” (PDF) ovvero The Other Report on Chernobyl.[/ref] fino alle centomila stimate da Greenpeace,[ref]”Chernobyl, il costo umano di una catastrofe” (PDF) 2006.[/ref] oltre ad un numero non precisato di malattie ed invalidità.[ref]L’incidenza di tumori alla tiroide ha avuto un’incremento drammatico nelle aree di Russia, Bielorussia ed Ucraina (curabili nel 90% dei casi), tuttavia ci sono discordanze sul numero di casi attribuibili all’incidente. Gli studi epidemiologici non hanno evidenziato fluttuazioni significative di altre patologie in conseguenza dell’incidente.[/ref] Lo stress dell’evacuazione forzata e lo sradicamento dalle proprie relazioni sociali, le paure per effetti sulla salute a lungo termine e l’emarginazione causarono depressione, disturbi psicosomatici e da stress post-traumatico, con conseguenti suicidi, alcolismo e uso di droghe.

18 – Filo spinato davanti al Cafè Pripyat’
Leningrad, Kursk, Smolensk, Ignalina: nonostante gli incidenti si susseguissero, nessuno di questi fu reso noto e nessuno si preoccupò di prendere misure adeguate per migliorare la sicurezza del reattore.
Di chi fu la responsabilità di tutto ciò? Le autorità sovietiche incolparono interamente il personale della centrale per salvare la faccia al Partito: nell’agosto del 1986 si tenne un processo-farsa a porte chiuse, per il quale la procura generale aveva già stabilito a tavolino le colpe e le pene dando precise istruzioni ai giudici.[ref]Nică, pag. 23 (op. cit.)[/ref] Berezin viene incolpato di avere premuto troppo tardi il pulsante di scram, quando successive ricostruzioni dimostreranno l’inconsistenza di tale accusa. Il direttore Bryukhanov, l’ingegnere capo Fomin, il vicecapo ingegnere Dyatlov ed altri ritenuti responsabili furono condannati alla reclusione fino a dieci anni con lavori forzati; 67 persone furono licenziate e 27 espulse dal Partito Comunista. Considerato che nel sistema sovietico avrebbero potuto essere fucilati (se solo le autorità supreme avessero così disposto) andò loro abbastanza bene.
Iodio 131. Cesio. Spiegazioni da parte di altri scienziati che contestano ciò che hanno detto i primi; e sono furibondi e perplessi. Tutto questo, insieme a ciò che veicola le sostanze radioattive, per esempio la pioggia, ora ci scorre addosso.[backref name=”guasto” /]Christa Wolf
Nonostante l’enorme mole di studi prodotti sull’incidente, ancora oggi non esiste una ricostruzione universalmente condivisa di ciò che accadde quella notte tra il 25 ed il 26 aprile del 1986. Sicuro è che le premesse per una catastrofe c’erano tutte: già nel febbraio del 1979, un rapporto segreto del KGB al Comitato Centrale riferiva che «alcuni cantieri di lavoro che stanno costruendo il blocco nº 2 della centrale di Černobyl’ lavorano senza alcun rispetto delle norme, delle tecnologie di montaggio e di costruzione definite.»[ref name=”ed75″]Dundovich, pag. 75–76 (op. cit.)[/ref] Il rapporto evidenzia elevati scarti (fino a 150 mm) nel montaggio degli elementi prefabbricati e una non corretta esecuzione dell’isolamento delle fondazioni: «Il danneggiamento dell’isolamento idraulico rende possibile un’inondazione della superficie della centrale in seguito alla risalita delle acque sotterranee e può anche portare a perdite radioattive nell’ambiente.» Inoltre, «le fabbriche di calcestruzzo operano senza alcuna regolarità, la loro produzione è di qualità scadente. La colata di calcestruzzo è stata più volte interrotta e ciò ha causato la comparsa di difetti…»[backref name=”ed75″ /]
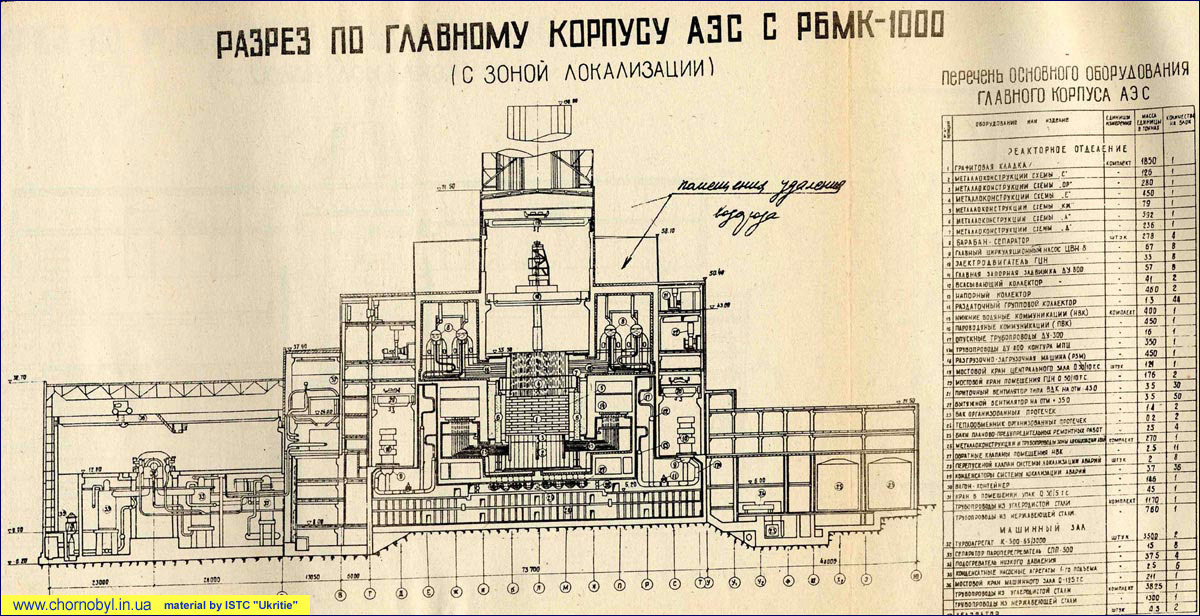
19 – Sezione del reattore RBMK-1000 negli elaborati progettuali della centrale di Černobyl’ (chornobyl.in.ua).
Oltre all’approssimazione con cui vennero condotti i lavori e alle importanti discrepanze dal progetto,[ref]Nică, pag. 32 (op. cit.)[/ref] di per sé il reattore RBMK era stato sviluppato con criteri di economia e presentava problemi noti ai progettisti: il coefficiente di vuoto positivo ed il comportamento anti-intuitivo dato dai terminali in grafite delle barre di controllo erano i più eclatanti. Già nel 1975 si era verificato un incidente minore alla centrale di Leningrad (San Pietroburgo) dovuto a queste vulnerabilità. Solo un anno dopo, un incidente simile si verificò al reattore nº 1 di Černobyl’. Poi a Kursk, a Smolensk, nel 1983 ad Ignalina in Lituania. Nonostante gli incidenti si susseguissero, nessuno di questi fu reso noto e nessuno si preoccupò di prendere misure adeguate per migliorare la sicurezza del reattore. Prassi diffusa nell’Unione Sovietica era che i funzionari di ogni ente e livello, preoccupati dell’avanzamento di carriera nella nomenklatura più di ogni altra cosa, tacessero o mentissero sulle complicazioni per non indisporre i superiori. Le autorità centrali, da parte loro, erano più interessate alla propaganda che a inezie come la sicurezza di un reattore nucleare da 3,2 GW e non esitavano a loro volta a mentire per preservare l’immagine di invincibilità del comunismo: «probabilmente — scrive Pavel Nică, giornalista moldavo inviato a Černobyl’ nell’87 – raccontare bugie è una malattia da cui non è facile curarsi, oppure si guarisce solo raccontando altre bugie».[backref name=”pavel” /] Come se ciò non bastasse, il paese soffriva di una cronica arretratezza tecnologica[ref]Dundovich, pag. 73 (op. cit.)[/ref] che, anche quando ce ne fosse stata la volontà, rendeva difficoltosa la risoluzione dei problemi. Insomma, le cause del disastro sono forse da ricercare non tanto (o non solo) negli errori di procedura commessi dagli operatori, quanto invece nei problemi endemici di un regime che iniziava a mostrare i suoi limiti e che di lì a pochi anni, tra il 1990 ed il 1991, sarebbe collassato. A “scoppiare” quella notte non fu solo il reattore, ma anche l’intero sistema sovietico. [endmark]
Note
[references class=”compact” /]Bibliografia e fonti
- Altieri, prof. Saverio L’equivoco Chernobyl. Pavia: EMI Editrice, 1987.
- Medvedev, Grigori The Truth about Chernobyl London: I.B. Tauris & CO, 1991. Pp. 65–68. ISBN 1-85043-331-3.
- Allen, Frank “Description of the Chernobyl Accident” in N. Worley, Lewins J. (edited by) The Chernobyl Accident and Its Implications… report no. 19. Oxford: Routledge, 2003. Pp 19-22.
- Johnstone, Bob “Low power sent Chernobyl out of control” New Scientist 1522 (21 agosto 1986): Pp. 13-14.
- Cataluccio, Francesco M. Chernobyl Palermo: Sellerio Editore, 2011. ISBN 88-389-2550-X
- Nică, Pavel Chernobyl la tragedia del XX Secolo. Viterbo: Stampa Alternativa, 2011. ISBN 978-88-6222-171-9
- Dundovich, Elena Čornobil’. L’assenza. Bagno a Ripoli (Firenze): Passigli Editori, 2012. ISBN 88-368-1362-9
- Speciale Superquark. Chernobyl: nel buio degli anni luce. RAI, 2006.
- Sequence of events” World Nuclear Association, Nov. 2009. Web.
- “Chronology” Pripyat.com, 2004.co
- The Chernobyl Gallery <chernobylgallery.com> Web.
- Chernobyl , Pripyat , Chernobyl accident and Exclusion Zone <chornobyl.in.ua>
- De Battisti, Alessio “La stampa italiana e la catastrofe di Chernobyl” Storia in Network. 1 Apr. 2015, Web.
- Lindbladh, Johanna “Chernobyl as the beginning of the end of the Soviet Union” Baltic Worlds. 29 Apr. 2014, Web.
- “Frontiere dell’UE: l’allarme Chernobyl è stato lanciato in Svezia“. Parlamento Europeo — Cultura, 15-05-2014. Web.
Immagini
- Archivio Vlaskin Ivan Ivanovich, © Pripyat.com.
- United States Department of Energy [PD] Commons.
- Annuale/Quark48, 2008 [CC-BY-SA 2.0] Commons.
- Yu. Yevsyukov, 1986, dal libro “Припятъ” (Pripyat) Kiev: ed. Mistectvo, 1986 (da chnpp.gov.ua)
- [PD] Commons.
- Bkleinf2, 2011, Idaho National Laboratory Arco [CC-BY-SA 3.0] Commons.
- © ChNPP Chernobyl Nuclear Power Plant (chnpp.gov.ua).
- calflier001, Set. 2013 [CC-BY-SA 2.0] Commons.
- 1986, Pripjat; dall’archivio dell’organizzazione dei liquidatori “Zemlyaki”.
- © ChNPP Chernobyl Nuclear Power Plant (chnpp.gov.ua).
- Chernobyl Wiki [CC-BY-SA 3.0] Wikia.
- [PD] Commons.
- Alexey Akindinov, “Chernobyl. L’ultimo giorno di Pripjat” (dipinto) [CC-BY-SA 4.0] Commons.
- U.S. Department of Energy.
- da un filmato dell’epoca, 1986.
- Chernobyl Wiki [CC-BY-SA 3.0] Wikia.
- Chernobyl Wiki [CC-BY-SA 3.0] Wikia.
- D. Markosian. One Day in the Life of Chernobyl, VOA News, 28-12-2011. [PD] Commons.
- ISTC “Ukritie”/chornobyl.in.ua.
chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Matteo 24:17–19
Vi dice niente il nome Pryp’jat’?[ref name=”pripyat”]In ucraino Прип’ять (Pryp’jat’), in russo Припять, (Pripjat’); spesso scritto “Pripyat” dalla traslitterazione anglosassone. In questo articolo si userà la traslitterazione dall’ucraino, Pryp’jat’, per il fiume e dal russo, Pripjat’, per la città (essendo nome ufficiale).[/ref] È un fiume dell’Europa centrale, affluente del più noto Dnepr nel quale confluisce poco nord di Kiev, in Ucraina. Citato come “Pripet” nella Cronaca di Nestore del XI secolo, il più antico documento russo, il nome potrebbe derivare dallo slavo con il significato appunto di “affluente”,[ref]Secondo Russisches etymologisches Wörterbuch, 1950-58 del linguista tedesco Max Vasmer (1886 – 1962).[/ref] oppure dalla parola dialettale locale pripec, “riva sabbiosa”[ref]Room, Adrian. Placenames of the World: Origins and Meanings of the Names… Jefferson, NC: McFarland, 1997.[/ref][ref]Cataluccio, pag. 12 (op. cit.)[/ref] o ancora dal baltico occidentale con riferimento alle secche.[ref]Andresen, Julie Tetel, and Phillip M. Carter. Languages in the World: How History, Culture, and Politics Shape Language. John Wiley & Sons, 2015. Pag. 210[/ref][ref]”Pripyat River Explained” Everything Explained.[/ref]

2 – Il fiume Pryp’jat’ (in rosso) e la regione della Polesia (in verde).
Il bacino idrografico del Pryp’jat’ forma una vasta conca alluvionale tra Ucraina e le alture della Bielorussia nota come Polesia o Polessia, probabilmente dal prefisso pol–, comune a svariate lingue, che sembra indicare una palude o un prato boschivo (è presente infatti anche nel latino pollìcinum, “terra paludosa” da cui il toponimo italiano Polesine che indica le paludi di Rovigo e del Ferrarese[ref]Cfr: Beretta, C., E.Anati, L. L. Cavalli-Sforza e C. R. Guglielmino. I Nomi Dei Fiumi, Dei Monti, Dei Siti: Strutture Linguistiche Preistoriche. Capo Di Ponte: Centro Camuno Di Studi Preistorici, 2007. Pag. 50[/ref]). È una regione di fitte foreste di pini, aceri e betulle, interrotte da corsi d’acqua più o meno grandi che si biforcano e si snodano in continui meandri, confondendosi con stagni e paludi. Culla primigenia della civiltà slava,[ref]cfr. Borzyskowski, Andrzej “The Slavic Ethnogenesis: Identifying the Slavic Stock and Origins of the Slavs” andrzejb.net, 2003. Web, 26-01-2015.[/ref] le paludi del Pryp’jat’ sono un luogo incantevole quanto impenetrabile: alla fine del XIX secolo non vi vivevano più di sette abitanti per chilometro quadrato,[ref]Nuova Antologia Di Scienze, Lettere Ed Arti. Vol. 94. Roma: Direzione Della Nuova Antologia, 1887. Pag. 231.[/ref] concentrati nelle zone bonificate tra il 1870 ed il 1900 che non superavano un quarto della superficie totale.[ref]L’estensione va dagli 80.000 km² c.a, secondo Treccani (cfr. “Polesia“), fino a 270.000 km² secondo Encyclopædia Britannica (cfr. “Pripet Marshes“).[/ref]
Attraversate da poche, impervie strade e per di più soggette a frequenti inondazioni, le immense “paludi del Pripet” erano considerate un’ostacolo insuperabile. L’Armata Rossa dovette dividersi in due ed aggirarle mentre, nel 1920, marciava su Varsavia per sferrare la controffensiva ai polacchi che avevano preso Kiev.[ref]Guerra sovietico–polacca, 1919–1921.[/ref] Erano però anche un ottimo nascondiglio, prima per le bande di predoni che razziavano villaggi (prendendosela in particolar modo con gli ebrei), poi per i partigiani che durante la seconda guerra mondiale combatterono aspramente contro i nazisti e infine, almeno fino al 1950, per le formazioni clandestine dei nazionalisti ucraini.[ref]L’ala militare dei nazionalisti Ucraini, guidata dal generale antisemita Roman Shukhevich, cfr. Cataluccio pag. 87 (op. cit.)[/ref] Poi di nuovo il silenzio finché, un giorno del 1970, i bulldozer sovietici si aprirono un varco tra queste paludi per fondare una città dal nulla, in un punto anonimo sulla riva destra del Pryp’jat’. In onore al fiume, o forse in mancanza di fantasia, alla nuova città fu dato il nome, in russo, di Pripjat’ (Припять).[backref name=”pripyat” /] [mapsmarker marker=”223″ basemapDefault=”googleTerrain” width=”100″ widthUnit=”%” height=”480″ panel=”false”]

4 – Inaugurazione di Littoria (oggi Latina) il 18 dicembre 1932.
Secondo la mitologia greca, Prometeo sottrasse il fuoco agli dei per donarlo agli uomini come strumento di progresso e civiltà. Secondo la mitologia sovietica, Lenin avrebbe promesso agli uomini l’energia elettrica come strumento di vittoria ed affermazione dei princìpi del comunismo. Nel 1920, il presidente bolscevico dichiarava ad un corrispondente del quotidiano britannico Daily Express che il grande piano di elettrificazione di tutto il paese avrebbe creato le basi per «una vita civile senza sfruttatori, senza capitalisti, senza grandi proprietari fondiari, senza commercianti.»[ref]Daily Express, n°6198, 23 febbraio 1920.[/ref] All’Unione Sovietica le fonti di energia non mancavano: c’era abbastanza carbone, gas e petrolio da raggiungere l’autosufficienza ed esportare le rimanenze in cambio di valuta pregiata. Il 90% di queste risorse si trovava però ad est degli Urali, mentre il maggior fabbisogno di energia si concentrava ad ovest, nella parte europea, più popolosa ed industrializzata. Alle soglie degli anni’70, il costo eccessivo del trasporto attraverso la catena montuosa e la necessità strategica di mantenere l’indipendenza energetica dai paesi europei spinsero il Cremlino a rafforzare la produzione di energia elettronucleare nella regioni della Russia occidentale e dell’Ucraina.
Dipinte in queste rive
son dell’umana gente
le magnifiche sorti e progressive.Giacomo Leopardi
La scelta del luogo per il primo di questi nuovi impianti sarebbe ricaduta sulle sponde del Pryp’jat’, nei pressi di un villaggio di cento anime chiamato Yanov: trovandosi sulla ferrovia Černigov–Ovruč, una dalle poche vie di comunicazione attraverso la Polesia, aveva già una piccola stazione che poteva essere usata come testa di ponte. Era giunto il momento di portare l’ordine socialista tra queste paludi reazionarie. Nel maggio del 1970 iniziarono gli scavi di fondazione di quello che sarebbe stato il primo rettore della centrale “V.I. Lenin”.[ref]detta anche ChAES, ovvero “Čornobyl’skaja Atomnaya Elektronstancija“.[/ref] Siamo circa 18 km a nordest di un villaggio di origine medievale ormai semiabbandonato chiamato Čornobil’, che forse non vi dice nulla ma che in ucraino significa “nero stelo d’erba” e si riferisce probabilmente all’Artemisia vulgaris, pianta erbacea abbondante nella regione e molto simile all’assenzio.[ref]L’assenzio (Artemisia absinthium) e l’artemisia comune (Artemisia vulgaris) appartengono allo stesso genere, Artemisia.[/ref]

5 – Inizio dei lavori di costruzione della centrale di Černobyl’, c.a 1970 (S. Neahev/chornobyl.in.ua)
Quella di Černobyl’ non sfuggiva sicuramente a questa logica, visto che oltre a produrre energia elettrica vi si produceva plutonio per usi bellici, ma Pripjat’ non era una cittadella militare chiusa e segreta, come ne esistevano nella parte orientale del paese.[ref]Le cosiddette ZATO, Zakrytye Administrativno–Territorial’nye obrazovanija, “Formazioni amministrativo-territoriali chiuse”.[/ref] Pripjat’ era di un’altra generazione: era una atomograd (città dell’atomo), una città modello socialista da esibire con orgoglio.
La città ideale
A Pripjat’ i progettisti ebbero la possibilità di uno spazio libero dove disegnare l’utopia della “città ideale” sovietica. L’impianto urbanistico fu disegnato dagli architetti di Kiev ispirandosi allo schema del “principio triangolare” dell’architetto moscovita Nikolaj Ostozhenko, già impiegato in altre città di fondazione sovietiche, basato su una combinazione di edifici a torre alti fino a 16 piani e di tradizionali chruščёvka,[ref name=”kushev”]Il cosiddetto chruščёvka (хрущёвка in russo) o “tipo Chruščёv”, era un modello architettonico a basso costo sviluppato durante gli anni ’60 durante il governo di Nikita Chruščëv (da cui il nome).[/ref] casermoni popolari più lunghi che alti (fino a 5 piani), separati da ampi viali e spazi verdi. Gli edifici a torre consentivano di risparmiare spazio, che veniva impiegato per la viabilità ed il verde pubblico: in pratica era una rivisitazione socialista della ville radieuse di Le Corbusier. Almeno altre dieci città sarebbero state modellate su Pripjat’ ed alcuni gruppi di edifici furono replicati esattamente in altre due atomograd, Volgodonsk e Togliatti.
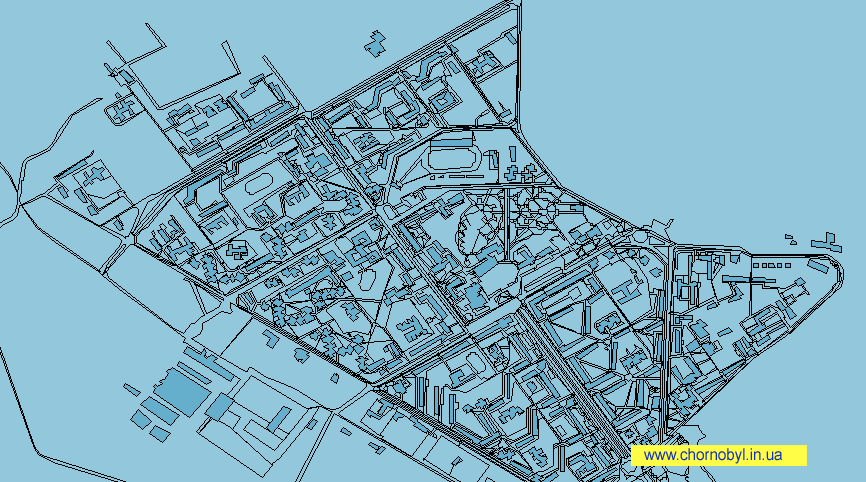
6 – Piano di Prip’jat’: pianta delle infrastrutture (chornobyl.in.ua).
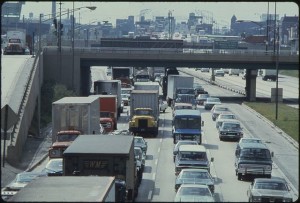
7 – Il traffico sulla Expressway a Chicago nel 1973.
Questo aspetto stava particolarmente a cuore nientemeno che al segretario generale Leonìd Brèžnev, che si occupò personalmente di curare l’assetto urbanistico di Pripjat’ dispensando consigli agli architetti. In qualche modo l’obbiettivo fu centrato: se ci pensate, oggi il traffico non è di certo il problema principale di questa città.
Pripjat’ nacque ufficialmente il 14 aprile del 1972 per decreto del Praesidium del Soviet Supremo dell’Unione Sovietica ma già dal 1970 (come ricorda l’insegna all’ingresso della città, «Припять 1970») esisteva un insediamento che comprendeva almeno un ostello, un refettorio, un ufficio amministrativo ed un villaggio temporaneo per gli operai chiamato “Lesnoj”.[ref]Forse dal nome della “città chiusa” di Lesnoj, ex “Sverdlovsk-45”, dove si assemblavano le testate nucleari; oppure perché un nome molto comune: in Russia esistono oltre 130 insediamenti così chiamati (cfr.).[/ref]
9 – Il villaggio temporaneo di Lesnoy, 1970 c.a (chnpp.gov.ua)
I nomi delle vie erano tipicamente sovietici, l’asse cittadino era prospekt Lenina (проспект Ленина) ossia “viale Lenin”. Quasi ogni città sovietica aveva una via principale intitolata a Lenin, come in Italia ogni comune aveva una “via Roma” per volere del partito fascista.

10–12 – Sopra: veduta di Pripjat’ dall’alto, il fiume sullo sfondo; sotto: viale Lenin (a destra) e l’Hotel Polyssia (a sinistra).
A Pripjat’ c’era perfino un club nautico dove era possibile praticare la navigazione da diporto e vari sport acquatici sul fiume, le cui rive erano méta anche di semplici bagnanti e pescatori. La stazione ferroviaria invece era quella del villaggio di Yanov, diventato ormai un “borgo” di Pripjat’, che si trovava appena fuori città e costituiva il principale scalo per passeggeri e merci.
[mapsmarker layer=”21″]
Area di Pripjat’: la città, il porto, la stazione di Yanov, la centrale elettronucleare di Černobyl’.

14 – Il centro: viale Lenin verso nord, sullo sfondo si vede la piazza Lenin (la fantasia dei burocrati) con il Palazzo della Cultura Energetik (chornobyl.in.ua).
Essendo realizzata con intervento unitario, Pripjat’ era una città modernista architettonicamente omogenea dal centro alla periferia. Il “centro” di Pripjat’ era la Ploshchad’ Lenina (foto 8), la grande “piazza Lenin” dove sorgeva il moderno Hotel “Polyssia” (foto 12, dal nome della regione, la Polessia) ed il palazzo della cultura “Energetik”. Il palazzo della cultura era una tipica istituzione sovietica: un edificio concepito come punto di ritrovo per i cittadini, i quali potevano svolgervi diverse attività culturali, sportive e naturalmente sorbirsi della sana propaganda. Qui si trovavano cinema, teatro, biblioteca, un centro sportivo con palestre e piscina. C’era anche una discoteca chiamata “Edison–2” (Эдисон–2), il tempio del divertimento dell’area di Čornobil’ i cui disc–jockey erano celebrità locali. Si ballava naturalmente disco music ma anche del rock’n’roll occidentale, dal rockabilly degli anni ’50 ai Beatles. Per gli amanti della musica dal vivo, non mancava la rock band autoctona, i Pulsar.
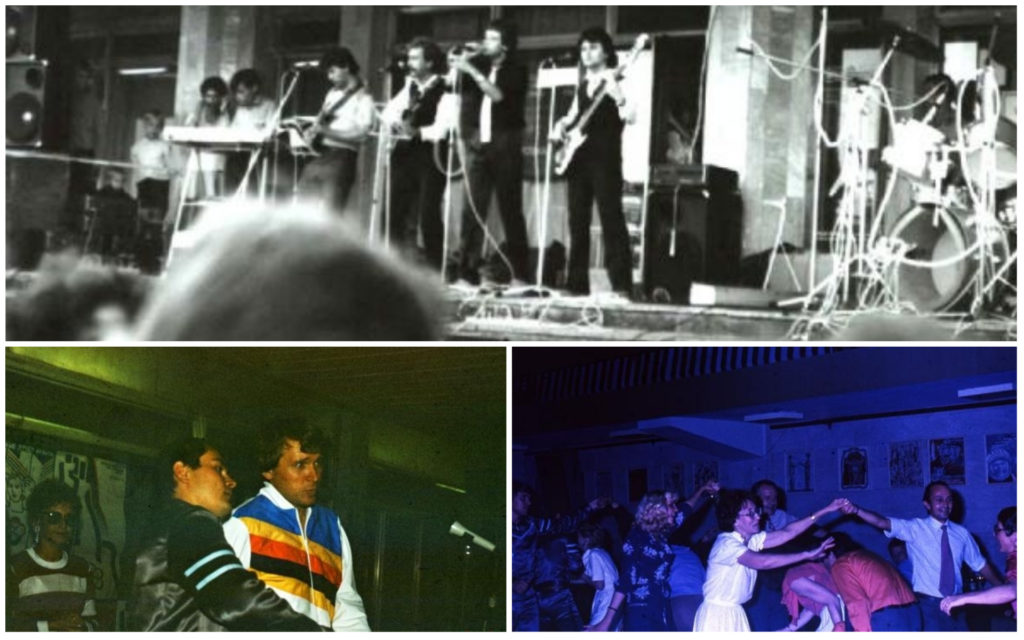
15 (sopra): i “Pulsar” suonano dal vivo davanti al Palazzo della Cultura; 16–17 (sotto): la discoteca “Edison–2” di Pripjat’ (foto: pripyat.com).
Sulla piazza centrale si trovava anche il supermarket Pripyat’ con ristorante, ma era possibile fare acquisti anche in un grande negozio di generi alimentari chiamato Voschod (“alba”) e due “centri servizi”, in pratica quelli che oggi chiameremmo centri commerciali, più periferici: ad est il “centro servizi 80” (che comprendeva tra l’altro una farmacia, parrucchiere, un atelier, uno spedizioniere) e a ovest il Yubileynyy (con barbiere, fotografo e lavasecco).
Questa città delle meraviglie non poteva che attirare nuovi abitanti da tutti i territori della sterminata Unione Sovietica, non tanto per la qualità della vita ma anche e soprattutto «per avvicinare almeno di un giorno l’ambito e radioso futuro socialista» (P. Nică [ref]Nică, pag. 32 (op. cit.)[/ref]). La popolazione aumentò così molto rapidamente, circa 1 500 persone all’anno, fino a raggiungere verso la metà degli anni ottanta i 50 mila abitanti appartenenti ad almeno 25 gruppi etnici: Pripjat’ non era un villaggio Potëmkin costruito a soli fini di propaganda ma una vera città, moderna, multiculturale e con un grande potenziale scientifico.
Nel 1977 entrò in servizio il primo reattore della centrale, che da allora sarebbe sempre stata in continuo ampliamento (un secondo reattore l’anno successivo, poi un terzo, un quarto: ne erano previsti sei), ma per garantire un lavoro a tutta questa gente furono impiantati anche quattro stabilimenti tradizionali, tra i quali la famosa fabbrica di radio “Jupiter”. A spostarsi in cerca di futuro erano soprattutto i giovani e questo faceva di Pripjat’ una città di giovani: l’età media della popolazione era intorno ai 26 anni e quasi per un terzo era costituita da bambini, per i quali erano disponibili numerosi asili e scuole;[ref]Almeno 22 asili, 15 scuole primarie e 5 secondarie.[/ref] un istituto professionale ed una scuola di musica. Nuovi progetti sarebbero stati realizzati nella Babele atomica in continua crescita: una nuova stazione ferroviaria, nuove scuole e cliniche, negozi e grandi magazzini, il palazzo dei Pionieri[ref]Come il palazzo della Cultura, ma destinato a bambini e ragazzi.[/ref] e quello delle arti, un nuovo hotel chiamato “Ottobre” (Октябрь) ed una torre della televisione alta 52 metri, tipico simbolo tecno–fallico delle città sovietiche.
Pripjat’ non era un villaggio Potëmkin costruito a soli fini di propaganda ma una vera città, moderna, multiculturale e con un grande potenziale scientifico.

22 – La ruota panoramica nel 1986 (M. Nazarenko).
«Non era un incendio come gli altri, piuttosto una strana iridescenza» ricorda Nadežda Petrovna Vygovskaya, che abitava all’ottavo piano di uno degli edifici a torre e vedeva la scena da casa sua. [ref]Cataluccio, pag. 96 (op. cit.)[/ref] Sopra la centrale l’aria era infatti luminescente per l’effetto Čerenkov. Alcuni, svegliati dai boati delle esplosioni, salirono sui tetti degli edifici a vedere quell’insolito spettacolo dell’aurora boreale atomica; altri si recarono sul ponte sopra la ferrovia per avere un posto in prima fila come se stessero assistendo ad uno spettacolo pirotecnico, non sapendo di esporsi così a dosi letali di radiazioni. I pescatori che avevano passato la notte lungo il fiume tornarono inspiegabilmente abbronzati.
Il giorno dopo
Un filmato del cineamatore Michail Nazarenko testimonia quelle ore drammatiche: alcuni automezzi lavavano le strade con un liquido bianco, nel giro di poche ore intere autocolonne di mezzi militari iniziarono a convergere sulla città. C’erano anche i carri armati, come se ci si stesse preparando a fronteggiare un’invasione. Paradossalmente, in tempi di guerra fredda, nelle scuole ci si addestrava ad un eventuale attacco americano mentre l’ipotesi di un guasto alla centrale che si trovava a soli quattro chilometri sembra non fosse nemmeno stato preso in considerazione. Questo “fuoco amico” spiazzò le autorità che, nel dubbio sul da farsi, fecero finta di nulla. Così passò un’altra notte normale, con quel bagliore sinistro e gli alberi della pineta che erano diventati rosso mattone, quasi luminescenti (la famosa “foresta rossa”). Il giorno dopo, domenica 27, i primi pompieri di Pripyat’ che erano intervenuti per spegnere l’incendio iniziavano a morire e molte persone erano già ricoverate in condizioni drammatiche. Finalmente la commissione federale d’inchiesta, giunta da Mosca la sera prima, decise per l’evacuazione.
Potete dire quello che volete del regime sovietico […] ma dovete ammettere che quando si mettevano in testa di evacuare un posto, sapevano davvero come fare.[ref]Blackwell, Andrew Benvenuti a Chernobyl e altre avventure nei luoghi più inquinati del mondo (Laterza, 2013).[/ref] Andrew Blackwell, giornalista e scrittore
Cinquantamila persone che all’improvviso avevano perso tutto, la propria casa, gli amici, le abitudini, i luoghi dei propri ricordi: una comunità cancellata per sempre. Molti di loro avrebbero avuto gravi ripercussioni sulla salute, o perlomeno l’angoscia del dubbio li avrebbe accompagnati per generazioni. Entro metà agosto sarebbero stati evacuati altri 188 villaggi tra Bielorussia ed Ucraina, alcuni dei quali rasi al suolo e interrati, per un totale di circa 116 mila persone (poco meno degli abitanti di Bergamo[ref]121 mila abitanti, ISTAT 2014.[/ref]) che sarebbero diventate 220 mila nei mesi successivi.[ref]Annex J: Exposures and effects of the Chernobyl accident (PDF), UNSCEAR, 2000. P. 453, sez. 2.[/ref] Intanto, migliaia di “liquidatori” civili e militari arrivavano da tutta l’Unione Sovietica nel disperato tentativo di mettere in sicurezza il reattore e limitare la contaminazione. Le storie drammatiche dei sopravvissuti sono state raccolte dalla scrittrice Svetlana Aleksievič nel suo famoso, straziante libro Preghiera per Černobyl’. Nonostante la politica della Glasnost’ (trasparenza[ref]Letteralmente “pubblicità” nel senso di “dominio pubblico”.[/ref]) proclamata un mese prima dal nuovo segretario generale Gorbačëv, solo martedì 29 (ovvero 4 giorni dopo) l’agenzia di stampa del Cremlino annunciò in modo telegrafico che a Černobyl’ c’era stato un non meglio precisato “incidente”. Il resto è storia contemporanea.
con pozioni infernali funestammo questi monti e queste valli
assai più della peste Faust, W. Goethe (1808)
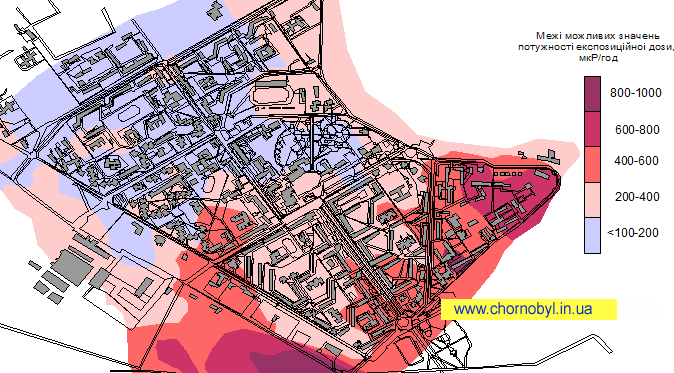
25 – Livelli di radiazioni misurati tra il 1992 ed il 1998 (chornobyl.in.ua)
Questa seconda nube atomica fatta di televisori, passeggini, termosifoni e tavolette del cesso (sic) costrinse le autorità a prendere seri, ma sempre tardivi, provvedimenti per arginare il fenomeno. Ora l’area è recintata e sorvegliata da checkpoint militari; una apposita agenzia governativa e un corpo di polizia sono stati istituiti per il controllo della “zona di esclusione”. L’accesso è consentito solo al personale autorizzato per la rilevazione periodica delle radiazioni e alle visite guidate per piccoli gruppi di turisti dell’estremo, affascinati dalla fatalità dell’apocalisse tecnologica di questa Pompei dell’era atomica, dove con un po’ di fantasia si può immaginare la vita degli anni ’80 nella più ambita delle città sovietiche. Sembra tanto tempo fa, ma noi qui guardavamo Magnum P.I. e Hazzard mentre nel palazzo della cultura di Pripjat’ si celebrava il mito del trionfo socialista. Subito dopo il disastro fu costruita una nuova città 50 km più a est, Slavutyč, per accogliere gli evacuati della zona di esclusione: come Pripjat’, fu intitolata al fiume più vicino, il Dnepr, di cui Slavutyč era l’antico nome slavo.
Oggi Pripjat’ è una città fantasma post–apocalittica. I battelli giacciono semiaffondati nel porto, tra le architetture moderne ed omogenee da città pianificata regna un silenzio spettrale. Per le strade deserte la vegetazione spontanea ha preso a crescere rigogliosa, attraverso le crepe dell’asfalto, non più disturbata dalla presenza dell’uomo. Si stima che ci vorranno cinque, forse sei secoli prima che i livelli di radioattività tornino alla normalità, almeno in superficie. Intanto, la zona di esclusione è diventata un’oasi di tranquillità per la fauna della Polessia: lupi, cinghiali selvatici, caprioli, cervi, alci e castori hanno ripreso a proliferare indisturbati. Non si può dire che sia “incontaminata”, ma è pur sempre natura. [endmark]
Note
[references class=”compact” /]Bibliografia e fonti
- Cataluccio, Francesco M. Chernobyl. Palermo: Sellerio Editore, 2011. ISBN 88-389-2550-X
- Pavel, Nică Chernobyl la tragedia del XX Secolo. Viterbo: Stampa Alternativa, 2011. ISBN 978-88-6222-171-9
- Dundovich, Elena Čornobil’. L’assenza. Bagno a Ripoli (Firenze): Passigli Editori, 2012. ISBN 88-368-1362-9
- Di Pasquale, Massimiliano Ucraina terra di confine. Fagnano Alto (AQ): Sirente, 2012. ISBN 978-88-8784-729-1
- Ribella, Davide Chernobyl Pripyat e la zona di esclusione Tricase (LE): Youcanprint, 2013. ISBN 978-88-91101-67-9
- [eng] “Near the cradles of Pripyat History” Pripyat.com, 21 dic. 2006. Web.
- [eng] “Chronology” Pripyat.com, 2004.co
- [eng] Leontiev, Yevgeny “Pripyat: Short Introduction” Pripyat.com, 28 lug. 2005. Web.
- [eng] Esaulvo, Alexandr “Pripyat in numbers;” Pripyat.com 12 apr. 2008. Web.
- [eng] The Chernobyl Gallery <chernobylgallery.com> Web.
- [eng] Chernobyl , Pripyat , Chernobyl accident and Exclusion Zone <http://chornobyl.in.ua/>
- “Una città sovietica modello. Ricordi di un pripjatiano” Le Russie di Chernobyl. Web.
- De Battisti, Alessio “La stampa italiana e la catastrofe di Chernobyl” Storia in Network. 1 Apr. 2015, Web.
- [eng] Lindbladh, Johanna “Chernobyl as the beginning of the end of the Soviet Union” Baltic Worlds. 29 Apr. 2014, Web.
Immagini
1. robarmstrong2/Pixabay.
2. CIA/Commons
3. “Болото. Полесье” (Palude. Polesia) Ivan Šiškin, olio su tela, 1890 [PD] Commons.
4. Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino/Commons.
5. S.Neahev/chornobyl.in.ua.
6. © chornobyl.in.ua
7. John H. White/Environmental Protection Agency, 10–1973 Chicago IL [PD] National Archives and Records Administration.
8. © 2015 dragunov/Depositphotos.
9. c.a 1970, © ChNPP <chnpp.gov.ua> Chernobyl Nuclear Power Plant/State Agency of Ukraine on the Exclusion Zone Management/Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine).
10–12. © Pripyat.com.
13. Yu. Yevsyukov, 1986, dal libro “Припятъ” (Pripyat) Kiev: ed. Mistectvo, 1986 (consultabile qui )
14. © chornobyl.in.ua.
15–19. © Pripyat.com.
20. Goshaproject [CC-BY-SA 3.0] Commons.
21. 1986, dall’archivio dell’organizzazione dei liquidatori “Zemlyaki”.
22–24. dal filmato amatoriale di M. Nazarenko, 26–27 aprile 1986.
25. © chornobyl.in.ua.
26. Darek83, 10-1986 [CC-BY-SA 3.0] Commons.
27. Matti Paavonen [CC-BY-SA 3.0] Commons.
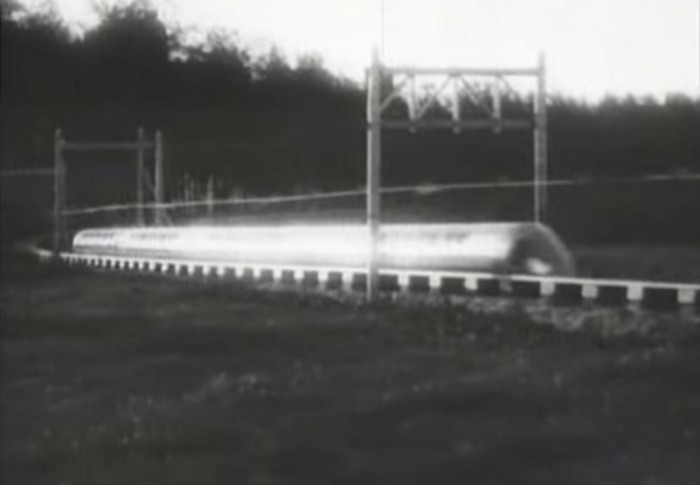
Un elettrotreno ad alta velocità aerodinamico come la fusoliera di un aeroplano, una pista di calcestruzzo levigato al posto delle rotaie: era lo Šaropoezd (traducibile come “sferotreno”) dell’ingegnere Nikolaj Jarmol’čuk.[ref]Alcune fonti riportano “Yarmanchuck” (Popular Science, op.cit.) o “Yarmolshuck” (Modern Mechanix, op. cit.), a seconda della traslitterazione. Il nome completo, in caratteri cirillici, è Николай Григорьевич Ярмольчук. Nel presente articolo è stata utilizzata la traslitterazione scientifica.[/ref] Siamo nella Russia sovietica del 1930, le ferrovie andavano principalmente a vapore e nulla del genere si era mai visto fino ad allora: non che fossero mancati esperimenti con monorotaie (→ferrovia di Boynton, 1890) o altri sistemi decisamente atipici, ma nessuno fino a quel momento si era spinto sino ad abbandonare il vincolo meccanico della rotaia.

1 – Nikolaj Jarmol’čuk, primi anni ’30.
Finita la guerra civile (1918–1923) la sua dedizione alla causa fu premiata con un posto di lavoro da meccanico presso la stazione di Kursk, nella Russia centrale, dove iniziò ad interessarsi alla tecnica ferroviaria. All’epoca i treni erano rumorosi e traballanti, la corsa era un susseguirsi di scossoni, vibrazioni, stridii, colpi secchi e rumori vari. Nikolaj dovette pensare che questi convogli sferraglianti fossero inadeguati alla nuova era del socialismo e si dovesse quindi trovare un modo per rendere la marcia più fluida, confortevole e veloce, adeguata insomma ad un paese nel pieno del progresso non solo sociale, ma anche scientifico e tecnologico. E secondo il giovane meccanico, gran parte del problema stava nell’attrito tra le rotaie e i bordini delle ruote.
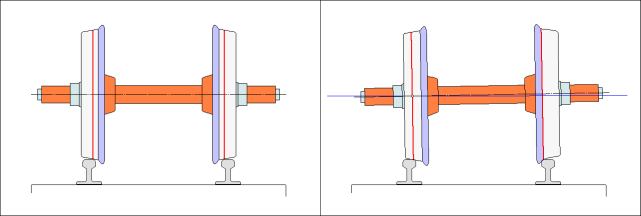
3 – Funzionamento delle ruote ferroviarie tronco-coniche: a destra la sala montata è disassata e la ruota più esterna lavora su una circonferenza maggiore, inducendo il treno a “sterzare” verso l’interno.
È necessaria a questo punto una parentesi tecnica: le ruote ferroviarie hanno una sezione tronco-conica, ossia hanno una circonferenza minore verso l’esterno e maggiore verso l’interno: quando una “sala montata” (che nel lessico ferroviario è una coppia di ruote collegate da un assile) non è perfettamente centrata sul binario, la conicità dei cerchioni farà sì che il punto di contatto della ruota più spostata verso l’interno del binario si troverà su una circonferenza leggermente minore, mentre la ruota esterna rotolerà su una circonferenza maggiore (fig. 3). Essendo le ruote rigidamente vincolate tra loro dall’assile, a parità di giri quella esterna avanzerà più velocemente e viceversa quella interna perderà velocità, inducendo l’assile a “sterzare” (per fare un paragone con i mezzi su gomma) verso il lato opposto a quello dello scostamento riportandosi così verso il centro del binario.
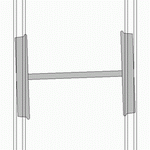
3 – “Serpeggiamento” di una sala montata sul binario.
Per liberarsi dei bordini era necessario massimizzare l’effetto autocentrante e nel 1924 Jarmol’čuk ebbe l’idea di sostituire il doppio cono della sala montata[ref]Il doppio cono (o bi-cono) è costituito dall’insieme delle due ruote coniche.[/ref] con una sfera ed il binario con una pista a sezione concava, similmente a quella per la corsa delle biglie. Il principio era il medesimo, la sfera si sarebbe naturalmente mantenuta nel centro del canale, ma senza gli urti dei bordini contro le rotaie e toccando sempre la superficie di rotolamento in un solo punto, cosa che avrebbe ridotto anche l’attrito volvente. Inizialmente Jarmol’čuk pensava ad una soluzione un tantino più estrema: la sfera stessa sarebbe divenuta un veicolo, all’interno del quale un telaio non rotante (forse stabilizzato da giroscopi) avrebbe ospitato motore, passeggeri e merci (il principio nella →nave rotolante di Knapp del 1897). Nel frattempo però il meccanico ebbe modo di frequentare due tra le più prestigiose università tecniche di Mosca, l’Istituto Tecnico Superiore Moscovita[ref]Oggi Università tecnica statale moscovita N. Ė. Bauman, nota come Baumanka (Бауманка).[/ref] e l‘Istituto per l’Energia, diventando così ingegnere. Grazie alla formazione acquisita Jarmol’čuk potè perfezionare il progetto, innanzitutto riportandolo entro limiti più realistici: il veicolo non sarebbe stato una sfera, ma avrebbe viaggiato su grandi ruote sferiche allineate, stabilizzato in corsa dall’effetto giroscopico delle stesse come una motocicletta.

4 – Una nevaljaška o poly-roly (Depositphotos).

5 – L’idea di Jarmol’čuk.
La guidovia in calcestruzzo, costruita in elementi prefabbricati con sezione a “U”, avrebbe potuto essere posata velocemente ed a costi non superiori a quelli di una normale strada; ma soprattutto avrebbe consentito di risparmiare acciaio, risorsa strategica indispensabile per costruire i cannoni. Questi indubbi vantaggi non sfuggirono alle autorità e, dopo l’entusiasmo suscitato dalla presentazione all’Istituto di Ingegneria dei Trasporti, nel 1929 il Commissariato del Popolo per le ferrovie (più o meno l’equivalente di un dicastero) istituì un apposito “KB” ossia un ufficio di progettazione[ref]Gli “uffici di progettazione” (Конструкторское бюро, abbreviato “КБ”) durante l’epoca sovietica erano istituzioni composte da un gruppo di ingegneri incaricati di lavorare ad una specifica tecnologia o progetto, cui era messa a disposizione un’officina o piccola fabbrica per costruire i prototipi.[/ref] sotto la guida dello stesso Jarmol’čuk, che ebbe così a disposizione personale e mezzi per mettere in pratica la sua idea.
Come d’uso all’epoca il nuovo ufficio ricevette la sua bella sigla, BOSST (БОССТ), mentre il treno fu battezzato Šaropoezd (шаропоезд), un composto traducibile come “sferotreno” (da шаро–, che fa riferimento alla forma sferica, e поезд che significa treno). Nell’aprile 1931 venne stanziato un milione di rubli per realizzare il prototipo cui lavorarono 89 persone tra ingegneri, tecnici, carpentieri, elettricisti e muratori; fu assegnato un terreno recintato di 15 ettari nei pressi di Mosca per la posa del tracciato sperimentale, una pista in legno (non ancora in calcestruzzo) ad anello, della lunghezza di 3 chilometri. L’installazione comprendeva l’officina per la costruzione dei veicoli, una sottostazione elettrica per l’alimentazione e, visto che lo spazio non mancava, gli orti dove il personale del KB poteva coltivare cavoli, carote, patate per integrare lo stipendio. Un anno dopo (aprile 1932) il primo Šaropoezd, un modello in scala 1 a 5 rispetto alle dimensioni finali previste, era pronto.

6 – Il primo prototipo dello Šaropoezd nel 1932.
Era un treno snello ed affusolato come non se ne erano mai visti, lungo sei metri e largo 80 cm, composto di tre vetture ognuna delle quali poteva ospitare un paio di persone in posizione semisdraiata su un comodo materassino, cosa che consentì ai progettisti di divertirsi un sacco durante i test. Le ruote, gommate e montate su sospensioni a balestra, erano segmenti di sfera (fig. 7) del diametro di un metro, alte quanto il veicolo stesso, all’interno delle quali erano ospitati i motori elettrici trifase alimentati da una linea aerea di contatto tramite un dispositivo di captazione.

7 – A sinistra, le speciali ruote dello Šaropoezd avevano la forma di segmenti di sfera. A destra, dettaglio delle balestre.
Il collaudo ebbe esito positivo: il treno raggiunse i 70 km/h con i passeggeri a bordo; il corrispondente della rivista Znanie – Sila (Знание – сила)[ref]Znanie – Sila: rivista di divulgazione scientifica russa il cui nome, che significa “Conoscenza – Forza”, è ispirato alla frase attribuita a sir Francis Bacon (1561 – 1626): «ipsa scientia potestas est», la conoscenza stessa è potere.[/ref] D. Lipoveckij raccontò così un giro sullo Šaropoezd:
Quando sono entrato in quella carrozza stretta […] francamente, ero tormentato dal dubbio e anche dalla paura. Mi aspettavo che il treno sarebbe uscito rapidamente dalla pista, che si sarebbe capovolto, che sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato e spiacevole. Ma non è successo niente. Ondeggiando delicatamente un po’, e senza il solito rumore di sferragliamento dei treni, lo Šaropoezd divorava il percorso. Nelle curve si è spontaneamente inclinato, mantenendo l’equilibrio. Le sfere rivestite in gomma scorrono silenziosamente, portando avanti il serpente di metallo con grande velocità.
Tra la fine del 1932 e l’estate del 1933 furono messi a punto i freni e fu testata la stabilità della composizione, che nel frattempo era stata portata a cinque vetture; infine il progetto ottenne il parere positivo del comitato consultivo per l’adozione su scala nazionale. Il 13 agosto dello stesso anno, il Consiglio dei Commissari del Popolo incaricò il Commissariato per le Ferrovie di avviare la costruzione di una tratta “pilota” tra Mosca e Zvenigorod oppure tra Mosca a Noginsk. Fu scelta questa seconda opzione perché nella periferia orientale era in costruzione una grande zona industriale che avrebbe richiesto un traffico, secondo le stime, di cinque milioni di passeggeri all’anno: la stazione moscovita sarebbe stata collocata nel distretto di Izmailovo, dove era previsto un terminal di interscambio con la linea tranviaria e la metropolitana di Mosca.
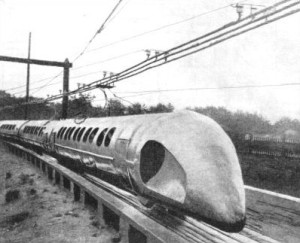
8 – Prototipo dello Šaropoezd.
Iniziò quindi la progettazione di una tratta di 50 km che sarebbe dovuta essere ultimata nell’autunno del 1934 in concomitanza con 17º anniversario della Rivoluzione d’Ottobre. Su questa tratta suburbana avrebbe viaggiato a 180 km/h uno Šaropoezd in scala reale, con ruote sferiche del diametro di 2 metri, composto 3 vetture della capienza di 82 posti ciascuna per una lunghezza complessiva di 25 metri. Ma il passo successivo sarebbe stato una versione più grande, con ruote di 3,7 m, per i collegamenti interurbani a 300 km/h: in pochi giorni sarebbe stato possibile trasportare la popolazione di intere città.
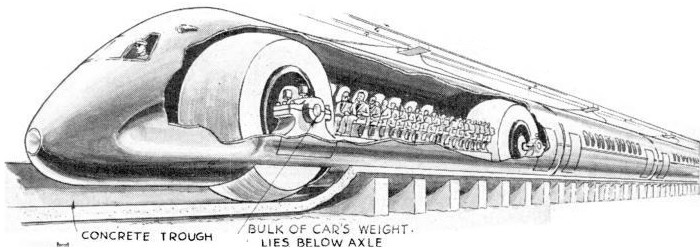
9 – Lo šaropoezd nella versione finale per i collegamenti a lungo raggio.
Ancor prima dell’inizio della costruzione la šaropoezda, la linea per lo “sferotreno”, era già stata ampiamente propagandata per l’intero paese ed aveva acceso gli entusiasmi di molti, tra i quali il poeta Vladimir Narbut che vi dedicò addirittura dei versi; lo stesso Jarmol’čuk scrisse un articolo per la rivista russa Pioner (Пионер) nel quale — non senza retorica — paragonò il treno ad un «bambino [nato] nel mese di ottobre» (cioè, simbolicamente, il mese della rivoluzione russa) e in procinto di diventare adulto. La notizia arrivò anche alla stampa occidentale, come dimostrano i brevi articoli usciti sulle riviste americane Popular Science e Modern Mechanix nel 1934, ma le informazioni al riguardo erano di difficile reperimento e un alone di mistero circondava la nuova ferrovia. Ancora nel 1957 John Robert Day e B. G. Wilson, nel loro libro Unusual Railroads, scriveranno:
…dobbiamo ricordare una notevole idea messa in pratica 25 anni fa o giù di lì in Russia. L’inventore propose un treno elettrico che correva in vasche di calcestruzzo su sfere al posto delle ruote e da una fotografia di un modello che abbiamo visto sembra essere molto efficiente. Purtroppo, non siamo stati in grado di raccogliere tutti i dettagli del sistema, ma si capisce che promette velocità molto alte.[ref]Day, John Robert, and Brian Geoffrey Wilson. Unusual Railways. New York: Macmillan, 1958. Pagina 184.[/ref]
È evidente che gli autori si riferiscono allo sferotreno di Jarmol’čuk ed il fatto che dopo un quarto di secolo venga ancora descritto come un progetto futuribile dà un’idea di quanto dovesse apparire avveniristico nell’Unione Sovietica degli anni’30. In effetti, ancor oggi è sorprendentemente moderno: il design ricorda i moderni elettrotreni ad alta velocità di oggi e quel canale in calcestruzzo assomiglia tanto alla via di corsa dei treni a levitazione magnetica.
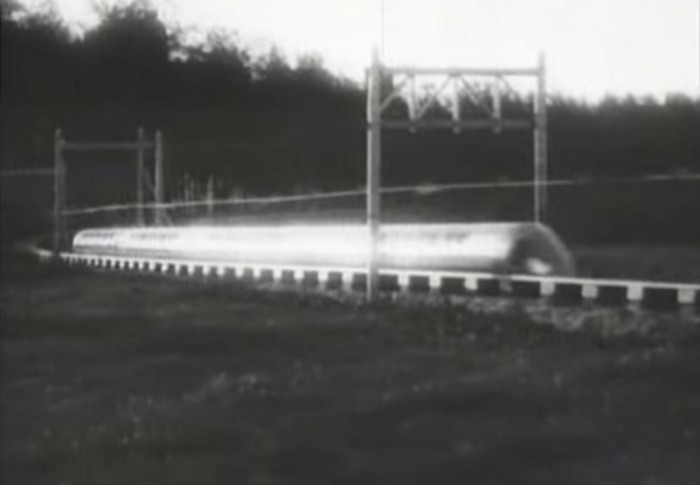
10 – Lo Šaropoezd sperimentale in corsa vicino a Mosca.
Se vi state chiedendo perché oggi non viaggiamo su “sferotreni” da 300 km/h ma sempre su rotaie tradizionali, sappiate che non fu costruita alcuna šaropoezda nel 1934 né lo sarebbe mai stata: sulla rivoluzionaria linea ad alta velocità calò improvvisamente il silenzio dell’amministrazione. Cos’era accaduto? L’entusiasmo delle autorità per lo šaropoezd e le conseguenti aspettative createsi avevano trascinato il KB che, nella foga di ultimare il progetto, aveva trascurato un dettaglio non di poco conto: in Russia nevica, e parecchio. Come liberare un canale lungo 50 km pieno di neve? E il giorno che sarebbe arrivato fino in Siberia? Già nei test del 1932–1933 era emerso che l’acqua piovana poteva accumularsi sul fondo della guidovia e formare uno strato di ghiaccio, che alle velocità previste avrebbe potuto rendere pericolosamente instabile convoglio. Il comunismo aveva forse sovvertito l’ordine sociale, ma non poteva fare altrettanto con le leggi della fisica e la šaropoezda sarebbe rimasta inutilizzabile per gran parte dell’anno. Ma c’era un altro aspetto cui sorprendentemente nessuno aveva pensato, cioè che nessuna industria sovietica all’epoca sarebbe stata in grado di produrre gomme del diametro di 3,7 metri ed in grado di sostenere quelle velocità. Forse, non c’erano nemmeno pneumatici sufficienti ad equipaggiare tutti i camion che sarebbero serviti a portare gli elementi di calcestruzzo dalla fabbrica al cantiere. Considerato il costo iniziale dell’infrastruttura, sarebbero ancora state più convenienti le ferrovie tradizionali, già posate ed ampiamente collaudate; inoltre l’entrata in servizio degli aeroplani Tupolev ANT-9 nel 1931 rendeva il trasporto aereo una soluzione competitiva per il trasporto a lungo raggio. Il progetto non era ancora “adulto” come aveva pronosticato Jarmol’čuk e di fronte a queste oggettive difficoltà le autorità, piuttosto che ammettere di avere commesso qualche errore di valutazione, preferirono cancellare il progetto senza dare pubbliche spiegazioni. Jarmol’čuk continuò a lavorare come ingegnere — pur dedicandosi ad incarichi più ordinari — e visse fino al 1978; alcune soluzioni tecniche studiate sullo “sferotreno” ebbero comunque una ricaduta positiva sull’industria del paese: ad esempio i freni aerodinamici,[ref]Gli aerofreni fecero la comparsa in quegli anni, probabilmente in modo indipendente, anche negli USA: cfr “Air Brakes for Planes Greatly Reduce the Landing Speed” in Popular Science, gennaio 1933.[/ref] previsti in aggiunta a quelli tradizionali pneumatici, sarebbero diventati di uso comune in aeronautica.
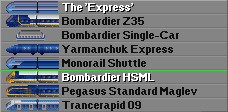
11 – Lo “Yarmachuck Express” (il 4º dall’alto) è tra i treni disponibili in Open-TTD.

12 – Una schermata di Open-TTD.
Note
[references class=”compact” /]Si ringrazia Giorgio Castiglioni di Bibliotopia per la consulenza sulla traslitterazione dall’alfabeto cirillico.
Bibliografia e fonti
- Nikolaj Polikarpov “История советского шаропоезда, чуть не перевернувшего представление о железной дороге в 30-х годах” in Maxim.ru n.d. Web. 8-1-2015.
- A. Ehrlich “ПОЕЗД НА ШАРУ” in Ogoniok (Огонёк), 20 ottobre 1933. Web. 8-1-2015.
- “Monorail runs in trough big spheres” in Popular Science, vol. 124, nº 2, febbraio 1934, p. 41, ISSN 0161-7370
- “Russia’s Giant Snake Train Rolls Speedly on Steel Balls” in Modern Mechanix, febbraio 1934 .
- Canale, S. e N. Di Stefano “Infrastrutture ferroviarie” (dispensa) in Corso di complementi di progetto di infrastrutture varie. Università degli studi di Catania – Dipartimento di ingegneria ambientale e dei trasporti. n.d. Web, 7/1/2015.
Immagini
- Da un filmato dell’epoca [PD].
- Hapesoft, 2009 [GNU FDL/CC BY-3.0] Commons.
- ikaxer, 2008 [GNU FDL/CC BY-3.0] Commons.
- © racobovt, 2008. Depositphotos.
- da Popular Science, 1934 (op. cit.)
- Fotografia del 1932 [PD] da Rusarchives.
- Da un filmato dell’epoca [PD].
- Fotografia dell’epoca [PD].
- da Popular Science, 1934 (op. cit.)
- Da un filmato dell’epoca [PD].
- [GNU FDL] da “openttdfansite.info”
- [GNU FLD] Commons.

1 – Ronald Reagan in Piazza Rossa (Mosca) il 31 maggio 1988 stringe la mano ad un ragazzino: dietro di lui Mikhail Gorbachev. Secondo la leggenda l’uomo con la fotocamera all’estrema sinistra, apparentemente un turista, sarebbe il giovane Vladimir Putin, che all’epoca era già nel KGB. Il Cremlino ha però smentito che si tratti di Putin (cfr), anche se è comunque possibile che si trattasse di un agente del KGB.
Nel maggio 1987 l’auto che trasportava il segretario generale del partito comunista sovietico verso la Casa Bianca si fermò sulla Pennsylvania Avenue. Michail Sergeevič Gorbačëv scese dall’auto e iniziò a stringere le mani alla folla. Nell’incontro successivo tra Gorbačëv e Reagan, tenutosi a Mosca, fu invece il presidente americano ad aggirarsi liberamente tra la folla della Piazza Rossa. Quelle immagini così semplici, unite ai colloqui per gli accordi sulle riduzioni dell’arsenale atomico delle due potenze, ebbero il potere di far venire meno, in entrambe le popolazioni, la paura del grande nemico della guerra fredda. Tra i due leader si instaurò un rapporto di sincera stima e amicizia, tanto che Reagan da Gorbačëv aveva appreso un proverbio russo che amava ripetere ogni volta che s’incontravano: «doveryai, no proveryai»[ref]In cirillico: Доверяй, но проверяй.[/ref] ovvero «fidati, ma controlla». Al di là della battuta infatti gli Stati Uniti continuavano a temere e a controllare l’Unione Sovietica , e lo avrebbero fatto fino alla fine. In assenza del conflitto aperto tra le due potenze, gli scontri diretti nella guerra fredda si ebbero nella propaganda, nella corsa agli armamenti ed in quella allo spazio; in tutto questo, naturalmente, le due parti si spiavano a vicenda in continuazione e una parte consistente di questa attività si svolse nelle profondità dell’oceano. Fare in questa sede una storia generale di un conflitto durato oltre mezzo secolo, ed in particolare dello spionaggio, sarebbe impossibile: vi proponiamo invece alcuni aneddoti che ci hanno particolarmente colpito per l’involontaria comicità. Non va però dimenticato che la guerra fredda ha purtroppo comportato anche operazioni molto discutibili, come ad esempio quelle di tipo “stay-behind”[ref]In Italia faceva parte di questa tipologia l’Organizzazione Gladio.[/ref] che nell’ambito della “strategia della tensione” colpirono anche ignari civili in diverse parti d’Europa; oppure la guerra in Vietnam e il colpo di stato di Pinochet. Lungi quindi dal voler fare un’apologia della guerra fredda, vogliamo invece raccontare semplicemente alcuni episodi di “storia insolita”.
Inseguimento sotto i mari

2 – Il USS Gudgeon (SS-567) negli anni ’70.
Nel 1957 il sottomarino diesel USS Gudgeon (SS-567) salpò dal porto giapponese di Yokosuka e si diresse nelle acque della base navale sovietica di Vladivostok, la più importante del Pacifico, per una missione di spionaggio. All’epoca i sovietici rivendicavano come limite delle acque territoriali le 12 miglia dalla costa ma il Gudgeon silenziosamente si inoltrò nelle acque russe, infrangendo anche il limite delle 3 miglia riconosciuto dagli U.S.A, posizionandosi ad intercettare ed ascoltare le comunicazioni militari. Ogni notte poi si allontanava di circa 20 miglia per azionare i motori diesel e lo snorkel[ref]Lo snorkel è fondamentalmente un tubo retrattile necessario al ricambio d’aria.[/ref] in modo da ricaricare le batterie ed effettuare il ricambio d’aria. Per giorni il sottomarino si mosse silenziosamente avanti e indietro nelle acque sovietiche, captando più informazioni possibili. Lunedì 19 agosto però, intorno alle 17, qualcosa andò storto e nel sottomarino risuonò l’allarme del “tutti ai posti di combattimento”: il Gudgeon era stato scoperto. Le navi sovietiche iniziarono a bombardare con il sonar il sottomarino americano, un modo per dire «sappiamo dove siete», mentre il capitano del sottomarino le provava tutte per scampare silenziosamente alla caccia. Il Gudgeon aveva però un grosso problema: le batterie erano ad un livello basso e l’aria iniziava ad essere viziata ma attivare i motori o lo snorkel avrebbe significato una facile individuazione. Tutta l’attrezzatura non strettamente necessaria fu spenta, mentre l’alto livello di anidride carbonica iniziava a provocare i primi malesseri all’equipaggio. I sommergibilisti americani stavano quindi imprecando contro Charlie Brown[ref]Nomignolo affibbiato dai marinai americani ai sovietici.[/ref] quando i sovietici alzarono l’asticella della caccia: lanciarono delle piccole bombe di profondità volte a mettere maggiore pressione agli americani senza danneggiarli. Le misure di evasione messe in atto dagli americani sembravano essere vane, mentre l’equipaggio tentava disperatamente di ridurre il livello troppo alto di anidride carbonica. Quarantotto ore dopo la situazione era immutata e il Gudgeon tentò la manovra estrema: riemergere in superficie, attivare i motori e lo snorkel e lanciare l’S.O.S; nonappena il sottomarino emerse però le navi sovietiche gli furono addosso, costringendolo ad un rapida immersione. Il tentativo era fallito, l’aria introdotta non era sufficiente e l’SOS non era stato trasmesso. Fu allora che il capitano Bessac capì che non sarebbe mai riuscito a fuggire all’inseguimento, ma non per questo era intenzionato a farsi catturare: diede l’ordine di aprire tutti i portelli dei siluri, sapendo che i sovietici lo avrebbero udito,[ref]L’idrofono, strumento indispensabile nella guerra sottomarina, consentiva di riconoscere l’apertura del vano siluri intercettandone il rumore prodotto e propagato attraverso l’acqua. Identificare questo suono significava sapere che un sottomarino si preparava a sparare e quindi guadagnare secondi preziosi per adottare eventuali contromisure. Per contro i sottomarini, sapendo di essere uditi, spesso aprivano i vani di lancio solo per lanciare un “avvertimento” ed esercitare una pressione psicologica sugli avversari, pur correndo il rischio di scatenare una reazione aggressiva.[/ref] e distribuì delle pistole agli ufficiali, mentre le spie a bordo si preparavano a distruggere tutti i documenti in caso di abbordaggio. Alla fine il Gudgeon emerse attivando immediatamente tutti e tre i rumorosi motori diesel e lo snorkel, un “S.O.S.” fu trasmesso in chiaro. Il capitano Bessac si diresse sul ponte insieme ad un ufficiale segnalatore e vide che gli inseguitori nel frattempo erano rimasti indietro e avevano anche ridotto la flotta a tre piccole navi. I sovietici trasmisero in codice Morse la richiesta d’identificazione: gli americani risposero chiedendo a loro volta ai sovietici di identificarsi. I russi risposero con «URSS» mentre gli americano ritrasmisero «USN. Stiamo andando in Giappone». I sovietici intimarono quindi al Gudgeon di rimettersi in rotta verso il Giappone e abbandonare le acque sovietiche. Aggiunsero però una cosa che divertì molto il segnalatore americano: «Grazie per l’esercitazione ASW[ref]ASW: Anti-Submarine warfare.[/ref]». La “sconfitta” del Gudgeon non piacque ai vertici della marina statunitense. L’ammiraglio Jerauld Wright incorniciò sulla porta del suo ufficio un particolare manifesto, in cui dichiarava che avrebbe donato una cassa di “Jack Daniels Old No. 7” al primo comandante che fosse riuscito a bloccare per sfinimento un sommergibile «non statunitense o non riconosciuto come amico». Nel maggio del 1959 la cassa di whiskey del Tennessee andò al capitano Theodore F. Davis, comandante del USS Grenadier (SS-525), che costrinse all’emersione un sottomarino sovietico nelle acque dell’Islanda.
Il “trucco” del K-3

3 – Il sottomarino nucleare K-3 Leninsky Komsomol
Nel 1962 la Marina sovietica subiva le continue pressioni del leader Chruščëv. Era infatti forte desiderio di Chruščëv che i sottomarini nucleari sovietici fossero in grado di lanciare missili balistici in immersione. Alla fine la Marina lo accontentò facendogli assistere al tanto sospirato lancio del missile da parte del K-3 Leninsky Komsomol, un sottomarino appena tornato da una prima e gloriosa attraversata del Polo Nord. Il leader sovietico ne fu talmente contento da assegnare una ricompensa per l’equipaggio, ignorando di essere stato in qualche modo ingannato con un trucco da illusionisti: la Marina sovietica non era ancora in grado di compiere un lancio simile con i sottomarini nucleari, ma pur di non deludere il leader i comandanti militari posizionarono un sottomarino diesel, classe “Golf”, accanto al K-3. Occultato alla vista di Chruščëv e nel pieno anonimato il sottomarino diesel effettuò un lancio impeccabile.
Il nemico ti ascolta
Nell’estate del 1971 il sottomarino USN Halibut (SSGN-587), riadattato per le missioni speciali grazie al particolare scafo con cui era stato progettato, ricevette una missione che sembrava folle: avrebbe navigato fino alle acque del Mare di Ohotsk, alla ricerca di un cavo telefonico sottomarino utilizzato dall’esercito sovietico. La missione fu un successo clamoroso e l’equipaggio dell’Halibut posò degli apparecchi atti ad intercettare le comunicazioni: era l’operazione “Ivy Bell”. I dispositivi, detti taps[ref]Da wire tapping, termine che indica l’intercettazione di comunicazioni via cavo.[/ref] però avevano bisogno di essere periodicamente sostituiti, per cui ci furono diverse missioni statunitensi con altri sottomarini per recuperare gli apparecchi. L’idea era così geniale che gli americani ripeterono con successo la missione nel Mare di Barents, al fine di spiare le comunicazioni della potente Flotta del Nord sovietica[ref]La rinomata “Flotta del Nord Bandiera Rossa” (Red Banner Northern Fleet), così ribattezzata in seguito al conferimento della prestigiosa onoreficenza militare dell’Ordine della Bandiera Rossa.[/ref]. Nel Mediterraneo invece gli americani, sempre negli anni Settanta, trovarono un cavo telefonico ma non era quello che si aspettavano. Temendo infatti che i sovietici stessero posizionando una rete simile al SOSUS[ref]Sound Surveillance System, ovvero un sistema di sorveglianza per l’intercettazione di sottomarini.[/ref] inviarono diversi sottomarini, in diverse missioni, al fine di distruggerla, senza però riuscirci. Quando alla fine riuscirono ad avvicinarsi al cavo, scoprirono che non era altro che un cavo telefonico italiano abbandonato dai tempi della seconda guerra mondiale. Nel 1981 i sovietici, informati dal loro spionaggio, si recarono nelle acque del Mare di Ohotsk e recuperarono gli apparecchi di registrazione. Una volta aperti non ebbero dubbi su a chi appartenessero: all’interno vi era infatti la scritta «proprietà del governo degli Stati Uniti». A fornire l’informazione ai sovietici era stato un ex-sommergibilista americano, John A. Walker Jr che nel 1985 fu arrestato dall’FBI. L’inchiesta sconvolse gli americani: Walker aveva infatti fornito ai sovietici, in cambio di denaro, una marea di informazioni preziose tanto da aver azzerato il vantaggio statunitense. Gli americani per anni avevano impiegato non poche risorse umane e finanziarie in ricerca e sviluppo, rischiando anche la vita degli uomini a bordo dei sottomarini per ottenere tutte quelle informazioni sul nemico; ai sovietici invece era bastato un milione di dollari per avere un’efficientissima e insospettabile rete spionistica al proprio servizio.
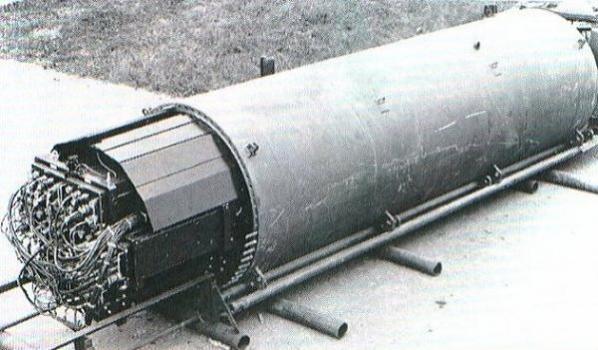
4 – Uno dei dispositivi di intercettazione (“wire taps”) dell’operazione “Ivy Bell”.
E adesso qualcosa di estremamente difficile e completamente inutile

5 – Il sottomarino sovietico K-129.
Il K-129, un sottomarino sovietico classe “Golf II” (629A per i sovietici), alimentato da motori diesel ed armato di missili balistici con testata nucleare, salpò dalla Kamčatka nel febbraio del 1968 per una missione di pattugliamento nel Pacifico. Ad aprile però le comunicazioni dal sottomarino cessarono di colpo, senza che al Comando avessero idea di cosa fosse successo e di dove cercarlo. I sovietici avviarono senza successo una missione di ricerca in lungo e in largo. Gli americani, venuti a conoscenza della notizia, inviarono in missione il sottomarino Halibut che riuscì nell’impresa di individuare i resti del sottomarino sovietico, adagiati a cinquemila metri di profondità circa 2770 chilometri a nord-ovest delle Hawaii. L’intelligence americana una volta venuta in possesso delle foto del relitto decise per una missione impossibile: tentare di recuperare per intero il sottomarino. A quanto pare la U.S. Navy avanzò non pochi dubbi sulla fattibilità e utilità del progetto, i sottomarini Golf II erano di fatto obsoleti, ma la CIA insistette per il recupero, dando così vita al progetto AZORIAN (Azzorre).
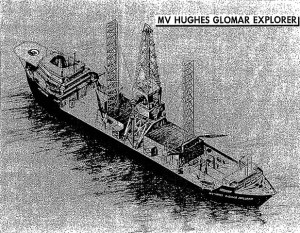
6 – La Glomar Explorer di Hughes in un’illustrazione tratta dal fascicolo segreto della NSA sul “Project Azorian”.
All’eccentrico miliardario Howard Hughes, la cui figura ha ispirato a Martin Scorsese il film The Aviator (2004), fu commissionata una nave per il recupero: la USNS Glomar Explorer. Per camuffare il vero scopo della nave fu inventata la storia che Hughes intendeva entrare nel mercato dei noduli di manganese e che il tutto era ricoperto dalla massima segretezza per via delle note tendenze paranoidi di Hughes. Quando nel 1974 la nave fu pronta per la missione il primo tentativo si rilevò un completo fallimento. Il K-129, pesante cinquemila tonnellate, era ancora a 3600 metri di profondità quando tre delle grandi pinze della Glomar Explorer cedettero: il relitto si schiantò nuovamente sul fondale sgretolandosi. Fu quindi recuperato solo un pezzo dello scafo, privo di interesse per l’intelligence, in cui furono ritrovati i corpi di sei marinai sovietici. Nel mentre erano in corso i preparativi per un secondo tentativo di recupero, la stampa americana aveva pubblicato in prima pagina alcune rivelazioni sul progetto anche se col nome di “Progetto Jennifer”. I vertici statunitensi tentarono di calmare le acque e nascondere il secondo tentativo in atto. Curiosamente, le autorità sovietiche stavano freneticamente inviando messaggi agli americani pregandoli di tenere nascosta la notizia: per loro infatti era fonte di non poco imbarazzo aver perso il sottomarino, con le famiglie delle vittime che erano ancora in attesa di sapere il destino occorso ai lori parenti. Se poi aggiungiamo che gli americani erano riusciti non solo a trovarlo prima dei russi, ma lo stavano anche recuperando e che, a maggior onta, l’intelligence sovietica avrebbe appreso il tutto dai giornali americani,[ref]In realtà alcuni agenti sovietici avevano avvertito i propri superiori del progetto in atto senza però essere creduti.[/ref] si può comprendere quanto la questione fosse scottante per Mosca. L’amministrazione americana si trincerò dietro un “no comment” e annullò qualsiasi nuovo tentativo di recupero. La Glomar Explorer rimase inutilizzata per anni fino a quando, nel 1990, fu acquistata da una compagnia petrolifera e riadattata all’esplorazione di idrocarburi e alla trivellazione. Si stima che il progetto AZORIAN sia costato tra i 350 e i 500 milioni di dollari dell’epoca[ref]Più o meno tra i 700 milioni e il miliardo di dollari attuali (2014).[/ref] Ai sei marinai sovietici fu data sepoltura in mare con cerimonia ufficiale a bordo della Glomar Explorer; il video della cerimonia fu poi consegnato al presidente russo Boris Eltsin nel 1992. La televisione russa trasmise quelle immagini,[ref]Il filmato è visionabile su Youtbe.[/ref] e non fu poca la commozione tra i parenti delle vittime nel vedere come il “grande nemico” avesse trattato con tanto rispetto i loro caduti.

7 – La gigantesca Glomar Explorer al porto di Long Beach nel 1976, due anni dopo il tentativo di recupero del K-129.
Storie di fantasmi

8 – La spia russa Anna Chapman, vero nome Anna Vasil’yevna Kushchyenko, al momento dell’arresto (giugno 2010).
Per cinquant’anni Stati Uniti e Unione Sovietica si erano fronteggiati nel timore che “l’altro” avesse in mente di sferrare il primo attacco. Questo sforzo “bellico” però ad un certo punto divenne insostenibile per l’Unione Sovietica e a nulla valse il programma di riforme avanzato da Gorbačëv: il 26 Dicembre del 1991 l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche cessava di esistere. Certi vizi però sono duri a morire. Nel 2010 l’FBI portò a termine l’operazione “Ghost Stories” arrestando 10 spie russe sotto copertura sul territorio americano. Obiettivo degli agenti russi era tentare di identificare amici e conoscenti vulnerabili e cooptare persone che avrebbero potuto ricoprire ruoli di potere o influenza. Questa tattica, nota come “Cambridge Five”, era stata usata con successo negli anni Trenta in Gran Bretagna, per la precisione all’Università di Cambridge, e permise di reclutare la famosa spia Kim Philby. L’operazione “Ghost Stories” ha anche ispirato la concezione della serie televisiva The Americans, che è stata però ambientata durante la guerra fredda[ref]La serie è ambientata negli anni Ottanta subito dopo l’elezione di Reagan alla presidenza.[/ref]. L’Unione Sovietica non esiste più, la guerra fredda sarà anche acqua passata ma la sfida tra i servizi segreti statunitensi e quelli russi va avanti: il punteggio della partita ci resta però ignoto. [endmark]
New York, 6 maggio 2010: la (ora ex) spia russa Anna Chapman viene incontrata in uno Starbucks di Manhattan da un agente dell’FBI sotto copertura che si finge un “collega”. Lei accetta un passaporto falso da inoltrare ad un’altra spia, ed in questo modo viene “incastrata” dall’FBI. Arrestata insieme ad altri nove agenti russi, viene espulsa dagli Stati Uniti. Ora è una celebre modella in Russia. (FBI/Youtube)
2011: la ex-spia in un servizio fotografico a Mosca (© Andrey Rudakov/Bloomberg).
The Fletcher Memorial Home, Pink Floyd (dall’album The Final Cut
, 1983).
Note
[references class=”compact” /]Bibliografia e fonti
- Sontag, Sherry, Christopher Drew. Immersione rapida. La storia segreta dello spionaggio sottomarino
. Milano: Il Saggiatore, 2010.
- CIA/NSA. “Project Azorian Released Files 01-04-2010.” The National Security Archive. George Washington University, 10 Apr. 2010. Web. 8-6-2014.
- “Project AZORIAN.” Central Intelligence Agency. 21 Nov. 2012. Web. 8-7-2014.
- “Ghost Stories. Inside the Russian Spy Case.” Federal Bureau of Investigation, 31 Ott. 2011. Web. 8-7-2014.
- “When Putin met Reagan.” Iconic Photos. Web. 8-7-2014.
Immagini
- Pete Souza, 31-5-1988 [PD] Commons/Iconic Photos;
- US Navy Ric Hedman TN(SS) [PD] Commons;
- data e autore sconosciuti [PD] Commons;
- (probabilmente) foto della Marina militare sovietica, data e autore sconosciuti;
- CIA, c.a 1968 [PD] CIA Museum Collection;
- da Project Azorian Released Files 01-04-2010, pag. 21. (cit.);
- Tequask, 13-6-1976, Long Beach [CC-BY-SA 3.0] Commons;
- U.S. Marshal Service, giugno 2010 [PD] Commons.
1
All’imbocco del Golfo di Riga, al confine tra Estonia e Lettonia, si trova una grande isola che divide le acque della baia del Mar Baltico: è l’isola di Saaremaa, la più grande dell’arcipelago estone. Un paradiso naturale che vanta località termali e suggestivi edifici come mulini a vento, fortezze teutoniche e fari. Uno di questi ultimi è davvero particolare: è pendente, come la celeberrima torre di Pisa, ma —a differenza di quest’ultima— si è in parte raddrizzato. Da solo.
[mapsmarker marker=”112″ basemapDefault=”googleRoadmap” width=”100″ widthUnit=”%” height=”320″ panel=”false”]
La penisola di Tagamõisa, oggi parte del parco nazionale di Vilsandi,[ref]”Tagamõisa Peninsula.” Lonely Planet. n.d. 5-5-2014[/ref] si protende dalla costa nordoccidentale di Sareemaa verso il cuore del Baltico, alla confluenza tra le due principali diramazioni: il Golfo di Botnia e quello di Finlandia. Qui, all’estremità della penisola, durante la prima guerra mondiale fu costruito il faro di Undva: una torre in legno di forma piramidale, la cui luce avrebbe costituito un punto di riferimento[ref]In navigazione i riferimenti sono detti “punti cospicui”[/ref] per le navi di passaggio o dirette da–e–per il Golfo di Riga. Dopo circa quindici anni si decise di sostituire il faro ligneo con un nuovo segnale costruito però questa volta sulla punta detta Harilaid,[ref]Ha lo stesso nome di un’altra isola estone, con la quale non ha però nulla a che vedere.[/ref] una lingua sabbiosa che si stacca a sua volta dal lato occidentale della penisola di Tagamõisa, dove avrebbe segnalato anche la pericolosa secca.
[mapsmarker marker=”111″ basemapDefault=”googleTerrain” width=”100″ widthUnit=”%” height=”320″ panel=”false”]
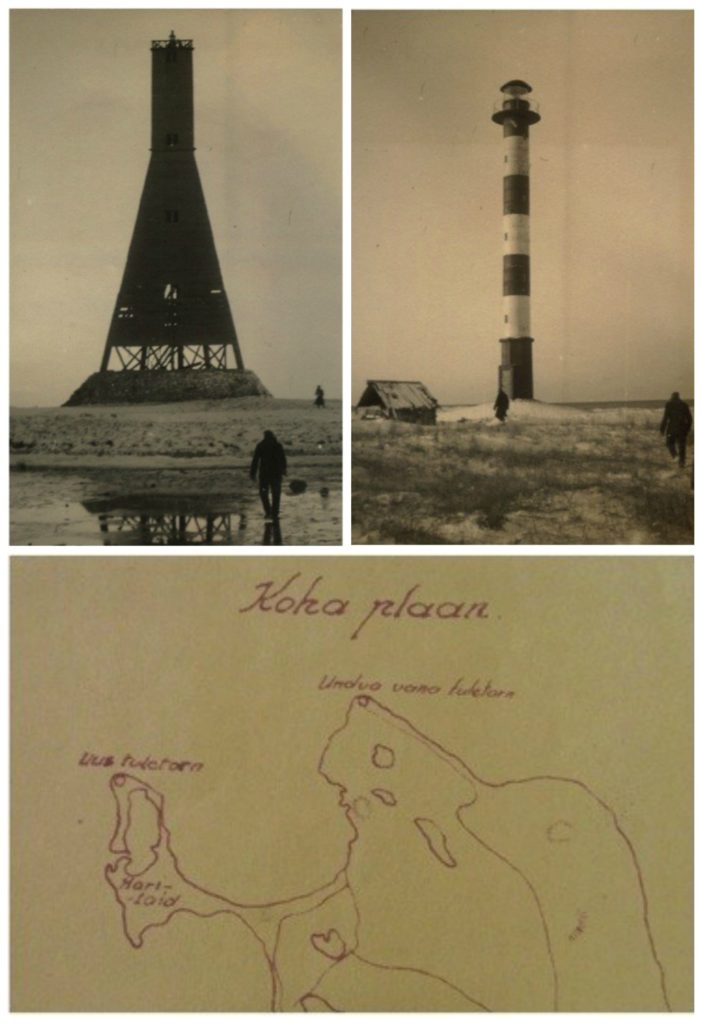
2 – In alto a sinistra: faro di Undva (Estonian Maritime Museum). 3 – In alto a destra: il nuovo faro di Kiipsaare nel 1935 c.a (Estonian Maritime Museum). 4 – Il faro di Undva (a destra) ed il nuovo faro di Kiipesare (sinistra) sulla mappa del progetto originale del 1933 (Estonian State Archive).
Nel 1933 fu quindi eretto dall’impresa “Maximilian Arronet & Otto de Fries” un nuovo faro, gemello di quello costruito un paio di anni prima sulla penisola di Juminda (a est di Tallin): una snella torre cilindrica in calcestruzzo armato alta 25 metri, originariamente dipinta a fasce bianche e nere e sormontata da una lanterna metallica dipinta di nero. La luce, prodotta da una lampada ad acetilene, aveva un piano focale di 27 metri ed era visibile sino a 12 miglia nautiche. Al momento della costruzione, il faro si trovava circa 150 metri all’interno della costa. Nel 1938 viene costruita nelle vicinanze la casa per i guardiani e l’anno successivo anche una sauna. Non si trattava però di un lusso per i faristi: nell’area del Baltico[ref]Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, dove la sauna è tutt’ora una tradizione molto diffusa e radicata.[/ref] la sauna era tradizionalmente l’ambiente dove -oltre a praticare il bagno di fumo[ref]La sauna a fumo (in finlandese savusauna), detta anche “sauna estiva”, è probabilmente la forma più antica di sauna ed ancora il tipo più diffuso sino alla fine del XIX secolo. Molto probabilmente anche quella di Kiipsaare era una sauna a fumo.[/ref]- si affumicava la carne, si essiccava la paglia e le reti da pesca, si rompeva il lino, si faceva il malto per la birra.[ref]Roy, Robert L. The Sauna: A Complete Guide to the Construction, Use, and Benefits of the Finnish Bath. 2009 ed. White River Junction, Vt.: Chelsea Green, 2004. Pp. 8-9.[/ref] Un elemento caratteristico della vita di tutti i giorni, quindi.

5 – La casa dei guardiani nel 2004 (Jaan Vali/E.L.S.)
Ad ogni modo, qualunque cosa ci facessero i faristi di Kiipeesare con la sauna, non sarebbe durata a lungo: nel 1939 infatti iniziò la seconda guerra mondiale e con essa i guai. Con il patto Molotov-Ribbentrop[ref]Fu un trattato di non aggressione tra l’Unione Sovietica e la Germania nazista, così detto dai nomi dei rispettivi ministri degli esteri: Vjačeslav Michajlovič Skrjabin detto “Molotov”, cui la leggenda attribuisce l’invenzione dell’ordigno incendiario che porta il suo nome (inventato in realtà dai nazionalisti di Francisco Franco durante la guerra civile spagnola), e Joachim von Ribbentrop.[/ref] siglato poco prima dell’inizio del conflitto, il Terzo Reich e l’Unione Sovietica si impegnavano alla reciproca non aggressione, spartendosi però segretamente le “aree di influenza”, un eufemismo per indicare i paesi che le due potenze si riservavano di invadere. Così, senza essere interpellati in merito, gli stati baltici si videro imposto di lì a breve un «patto di assistenza e mutua difesa»,[ref]28 settembre 1939.[/ref] un altro eufemismo per dire un’occupazione militare sovietica. Per nulla turbato dagli anatemi lanciati dalla Società delle Nazioni, Stalin instaurò un regime talmente duro[ref]Terre, attività produttive ed istituti di credito furono nazionalizzati senza alcun rimborso, i rapporti con l’estero bruscamente interrotti, la libertà di stampa soppressa e la popolazione fu soggetta ad una violenta campagna repressiva. Cfr. Beevor, (op. cit.)[/ref] che -quando nel giugno del 1941 Hitler disattese il patto Molotov-Ribbentrop invadendo la Russia- in Estonia[ref]Durante l’occupazione nazista gli stati baltici divennero il territorio occupato dell’Ostland, amministrato da un unico Reichskommissariat.[/ref] i soldati della Wermacht furono accolti con sollievo persino dagli ebrei, che li vedevano non proprio come liberatori ma perlomeno come il “male minore”. Ovviamente non fu così: l’occupazione nazista portò tre anni di violenza, repressione e persecuzioni antisemite.[ref]Cui parteciparono anche cittadini estoni che speravano così di ingraziarsi i nazisti e vedersi assegnati i terreni espropriati agli ebrei.[/ref] Poi, nel 1944, l’Armata Rossa sferra la massiccia “offensiva del Baltico”: le soverchianti forze sovietiche costringono i nazisti alla fuga via mare e la regione del baltico viene riconquistata.

6 – Offensiva del Baltico, 1944: carri sovietici entrano in Estonia.
Questa volta però, memori delle esperienze passate, gli estoni sapevano di doversi aspettare una nuova colonizzazione: circa ottantamila di loro fuggirono in Europa occidentale (questo esodo fa da sfondo al film Somnambuul, 2003 – vedi in fondo) piuttosto che restare sotto il regime sovietico. Per i rimasti, nonostante la guerra fosse finita, le ondate di repressione non si fecero attendere[ref]Oltre 20 mila “banditi nazionalisti”, in realtà per lo più contadini, furono deportati in massa nei gulag dalla polizia sovietica in occasione rastrellamento denominato “Operazione Primavera” del marzo 1948. Cfr. Dundovich, pp. 113-115 (op. cit.)[/ref] e proseguirono fino all’inizio degli anni’50, quando ormai non c’era quasi più nessuno da deportare.
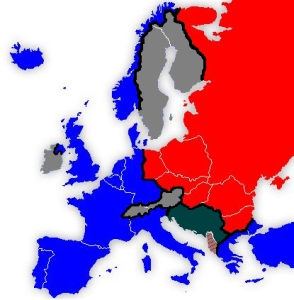
7 – La “cortina di ferro”: in rosso il blocco sovietico, in blu i paesi NATO.
Nei conflitti, i fari godono in genere di una certa neutralità: salvo casi particolari[ref]Nel 1944 alcuni fari lungo le coste francesi furono bersagliati tanto dagli alleati quanto dai nazisti, a seconda delle necessità tattiche — luce o buio — del momento. Cfr. Paolini, Charles. I guardiani dei fari. Sentinelle del mare. Storie e leggende. Milano: Magenes, 2012.[/ref] fanno comodo un po’ a tutti e spesso ne escono indenni. Così, alla fine della seconda guerra mondiale, anche il faro di Kiipsaare era ancora in piedi e praticamente intatto. Ma una nuova guerra stava per iniziare, quella cosiddetta “fredda“. La cortina di ferro calava sull’Europa orientale e le coste baltiche divennero parte della lunga ed invalicabile linea di confine tra occidente e blocco sovietico. Stalin era assolutamente convinto che una eventuale invasione sarebbe avvenuta proprio dal Baltico,[ref]Leibovitz, Clement, Alvin Finkel e S. Calzavarini (traduttore) Il nemico comune. La collusione antisovietica fra Gran Bretagna e Germania nazista
.[/ref] in conseguenza di ciò le isole e le aree costiere, già spopolate dalla guerra e dalle deportazioni di massa, furono fortemente militarizzate: la popolazione rimasta fu in larga parte evacuata soprattutto dalle isole minori, edifici ed infrastrutture furono requisiti dalla Guardia di Frontiera. Pesanti restrizioni furono imposte sugli spostamenti via terra e sulla navigazione; ogni attività costiera fu vietata, compresa la manutenzione.

8 – Isola di Saaremaa: mulini a vento ad Angla. (Yksikuitaja/Commons)
In questo stato di alienazione, che nonostante la “destalinizzazione” di Khruščёv si sarebbe protratto sino alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, le coste furono abbandonate ai processi naturali; in assenza di opere di protezione costiera l’erosione[ref]La penisola sabbiosa si sposta naturalmente verso nord-est. Una imbarcazione in legno naufragata nel 1850 circa sulla costa nord-est, è stata sepolta dalla sabbia ed è riemersa tra il 1999 ed il 2000 dal lato sud-ovest.[/ref] faceva sì che il faro si trovasse sempre più vicino alla battigia. Ormai solo undici metri di spiaggia separavano il basamento della torre dal mare nel 1988, quando i pragmatici sovietici pensarono bene – per ridurre al minimo la manutenzione – di sostituire la lampada ad acetilene con una luce elettrica alimentata da un piccolo generatore nucleare a radioisotopi. Pochi anni dopo, una serie di eventi politici portarono l’Unione Sovietica al collasso ed il 20 agosto del 1991 l’Estonia fu di nuovo libera, dopo mezzo secolo di occupazione. Nei mesi successivi la Guardia di Confine russa abbandonò l’isola e la “cortina di ferro” si dissolse.

9 – La penisola di Tagmõisa fa parte del parco nazionale di Vilsandi (foto: Ilme Parik).

10 – Il faro nel 2006: l’acqua stava per oltrepassare il basamento.
Lentamente, Tagamõisa fu riscoperta dal punto di vista naturalistico e turistico e con essa il faro di Kiipsaare, suo malgrado testimone in disparte di eventi tra più tragici e storicamente significativi del ventesimo secolo. Nel 1992 fu rimosso il dispositivo a radioisotopi, retaggio di un’epoca ormai conclusa, e la luce definitivamente disattivata. Il faro aveva però iniziato ad inclinarsi vistosamente verso il mare, mano a mano che questo si avvicinava alla torre, a causa della pendenza della battigia, guadagnandosi una certa popolarità come “la torre di Pisa dell’Estonia”. Nel 2004 le onde lambivano il basamento e nel 2011 il faro, ormai pericolosamente inclinato, era totalmente circondato dall’acqua (vedi foto 1). Ci si sarebbe aspettati un crollo imminente, quando avvenne invece qualcosa di inaspettato: il faro si stava lentamente raddrizzando; le onde avevano infatti iniziato a scavare sotto il basamento dalla parte opposta, invertendo il processo. In mancanza di manutenzione e di progetti di consolidamento il pericolo di un crollo non è del tutto scongiurato: entro qualche anno il faro pendente di Kiipsaare potrebbe non essere più pendente, o non essere più un faro. Ma in ogni caso si sarà guadagnato il proprio posto nella storia. [endmark]

11 – il faro nel 2013 (Ego Riener/Estonian Lighthouse Society)

12 – Una scena del film Somnambuul.
Il faro di Kiipsaare ha un ruolo importante nel film Somnambuul (2003, regia di Sulev Keedus) nel settembre del 1944: la giovane Eetla (Katariina Unt) rinuncia a fuggire dall’isola, che sta per essere nuovamente occupata dai sovietici, per restare con suo padre Gottfrid (Evald Aavik), il guardiano del faro, ed affrontare insieme l’inverno.
Nel 2013 le poste estoni hanno emesso un francobollo commemorativo in occasione dell’80º anniversario della costruzione del faro di Kiipesaare, del valore facciale di € 0,45. La vignetta raffigura il faro, sovrapposto ad una mappa della lingua sabbiosa di Harilaid.
Note
[references class=”compact” /]Bibliografia e fonti
- Dundovich, Elena. “I Paesi Baltici e l’Unione Sovietica (1919-1989)” in Motta, Giovanna (a cura di -) Il Baltico: un mare interno nella storia di lungo periodo
. Roma: Edizioni Nuova Cultura, 2012. Pp. 107-121.
- Rowlett, Russ. “Lighthouses of Southwestern Estonia” The Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill. 20 Feb. 2014. Web.
- Finlandia e paesi baltici
, 2003 ed. Touring Club Italiano. P. 97
- Beevor, Antony. La seconda guerra mondiale. I sei anni che hanno cambiato la storia
. Milano: Rizzoli, 2013. cfr.
- Tõnnison, Hannes, et al. “The Baltic States: Estonia, Latvia and Lituania.” in Pranzini, E. A. Williams (a cura di-) Coastal Erosion and Protection in Europe
. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2013. P. 55.
- Bird, E. C. F. Encyclopedia of the World’s Coastal Landforms
. Dordrecht: Springer, 2010. Pp. 609-610.
- “Kiipsaare.” Estonian Lighthouse Society, n.d. 9-5-2014.
- de Voogd, Otto. “Evolution of Kiipsaar Lighthouse.” 7is7. 2011. Web. 17-5-2014.
- “Kiipsaare Lighthouse stamp by Estonia” Stampnews.com. 1 Feb 2013. Web. 17-5-2014.
Immagini
- 2013, Abrget47j [CC-BY-SA 3.0] Commons;
- 1918-1933 circa, © Estonian Maritime Museum (courtesy of) Estonian Lighthouse Society;
- 1935 circa, © Estonian Maritime Museum (courtesy of) Estonian Lighthouse Society;
- 1933, © Estonian State Archive (courtesy of) Estonian Lighthouse Society;
- 2004, © Jaan Vali (courtesy of) Estonian Lighthouse Society;
- 1944, [PD] da Zaloga, Steve. Soviet tanks in combat, 1941-1945: the T-28, T-34, T-34-85 and T-44 medium tanks. New Territories, Hong Kong: Concord, 1997;
- 2006, Kseferovic [CC-BY-SA 3.0] Commons;
- 2013, Yksikuitaja [CC-BY-SA 3.0] Commons;
- 2012, Ilme Parik. Lumanda, Estonia [CC-BY-SA 3.0] Commons;
- 22-7-2006, Abracadabra [PD] Commons;
- 2014, © Eco Riener, (courtesy of) Estonian Lighthouse Society;
- 2003, © dal film Somnambuul, fair use;
- 2013, © Eesti Post, fair use via stampnews.com.