spregiativo, sostantivo e aggettivo invariabile, sec. XIV. Da cacare, “defecare, espellere”, nel senso figurato di pagare (es. nell’espressione figurata cacare soldi, “tirare fuori soldi”, “sborsare”) oppure produrre (nel linguaggio popolare la parola stitico, “che ha difficoltà a defecare”, ha anche il significato di “avaro” o di persona che produce poco, lentamente, es: “scrittore stitico”); e di stecchi (plurale di stecco), qualcosa cioè che di piccolo, sottile, ma che si espellerebbe con grande fatica. Cacastecchi può infatti significare:
- persona spilorcia, avara (cacare=pagare, sborsare) colui cioè che quando deve pagare lo fa con parsimonia, con sforzo, con sofferenza, come se “cacasse stecchi”: quindi un taccagno, arpagone, stitico.
Un uomo spilorcio, sordido, stitico si nominò cacastecchi, e questo vocabolo pure trovasi nel Pataffio, e in alcune antiche Commedie.
Dizionario delle origini, 1828 (op. cit.)
…mugnai cacastecchi attraversano la città con un tiro a quattro: mercanzia stomacosa per una fiera di larve.
A. M. Ripellino, Praga Magica, 1973. Cap. 76.
- persona indecisa, incapace (De Mauro), ignorante, dappoco (Cardinali — Costa, 1820 op. cit.), qui nel senso cioè di “persona da cui ci si cava solo stecchi”, quindi poco (cacare=produrre). Dice Nicia ne La Mandragola del Macchiavelli:
In questa terra non ci è se non cacastecchi, non ci si apprezza virtù alcuna.
Niccolò Macchiavelli, La Mandragola (commedia in prosa), 1518, atto II scena III.
- Dato già per desueto nel 1820, sempre da Cardinali e Costa, è il significato di dissenteria.
- Ne La Trinuzia di Agnolo Firenzuola (1549) si ritrova come imprecazione: «Cacastecchi li venga!», un augurio «che colui possa patire quel dolore che patirebbe se cacasse stecchi» (Cardinali — Costa, 1820 op. cit.), analogo quindi all’odierno «gli pigliasse un accidente!»
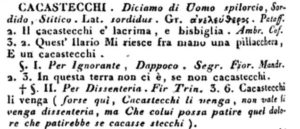
“cacastecchi” nel Dizionario della lingua italiana di Costa eCardinali, 1820.
- “cacastecchi” in Il nuovo De Mauro. Internazionale. Web.
- “cacare” in Garzanti Lingusitica. Web.
- “stitico” in il Sabatini Coletti. Corriere della Sera. Web.
- Cardinali, Francesco e Paolo Costa “Dizionario della Lingua Italiana” Bologna: De Masi, 1820. tomo II, pag. 162.
- AA.VV. Dizionario delle Origini — Invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell’agricoltura, ecc. ecc. Milano: Bonfanti, 1828. Tomo I, pag. 515.
Immagine: Hans/Pixabay
o cacazibetti (spregiativo, att. XVI secolo) bellimbusto, damerino, vanesio, schizzinoso; chi esagera con il profumo o ostenta raffinatezza. Da cacare, “defecare”, nel senso figurato di “produrre”, e “zibetto”, costoso e ricercato secreto di origine animale utilizzato nella produzione di profumi (oggi sostituito da molecole sintetiche): il cacazibetto è quindi una persona talmente piena di profumo, da cacarlo.
Anselmo: Sì, signora, questo è il vero amore, e non quello di certi cacazibetti: gioja…
Carlo Goldoni, Il cavaliere e la dama (1749), Atto III, scena IX
…imparasse ad attendere a gli studij più gravi, e lasciasse gettar il tempo nella lettione de’ Madrigali, de’ Sonetti, e delle Canzoni a quei giovanetti cacazibetto, ne’ quali per l’età loro quelle cose si tolleravano, che severamente erano punite ne’ vecchi.
Traiano Boccalini, Ragguagli di Parnaso (Venezia, Pietro Farri, 1612) Centuria I, Ragguaglio VII.
…pruffumatelli per non dir cacazibetti
Giulio Cesare Croce, L’eccellenza et trionfo del porco (1594)[1].
Le più antiche attestazioni scritte della parola cacazibetto risalgono al XVI secolo e si devono al lucano Luigi Tansillo (1510 – 1568), all’emiliano Giulio Cesare Croce (1550 – 1609) e al napoletano Giovan Battista Marino (1569 – 1625).[1]
Sinonimi, e analoghi per composizione, sono cacamuschio, dove il “muschio” è anch’esso ingrediente di profumeria, e cacaspezie, nel quale lo zibetto è sostituito dalle spezie, altro bene di lusso, profumato e simbolo di ricchezza.
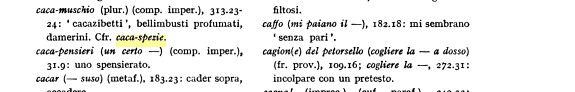
Nelle note alle Sei Giornate di Aretino dell’edizione Laterza del 1969, cacazibetti è definito come «bellimbusti profumati, damerini […] caca-spezie».
- “cacazibetto” in Garzanti Linguistica. Web.
- “cacazibetto” in Vocabolario Online. Treccani. Web.
- Marri, Fabio in Lingua Nostra Vol. XXXVIII fasc. 1-2, marzo-giugno 1977. Pag. 59.
- Aretino, Pietro Sei giornate: Ragionamento della Nanna e della Antonia. Roma: Laterza, 1969. 1ª ed. 1534. Pag. 537.
Immagine: Luigi Ponelato, Il cicisbeo, acquaforte da Carlo Goldoni, Opere teatrali, vol. 13 (Venezia, 1790). [PD] Commons
nell’antica Grecia, canto corale in onore del dio Dioniso, a carattere tumultuoso e orgiastico; nella letteratura moderna, componimento lirico concitato e gioioso, dal metro vario.
Nell’uso figurato, il ditirambo è una lode o esaltazione particolarmente enfatica, smaccata, sperticata, ampollosa; panegirico; discorso o scritto elogiativo; utilizzato anche nel senso di inno:
Dal «rafforzamento dell’unità con l’Urss», Honecker ha tratto spunto per un ditirambo senza precedenti sull’Unione Sovietica, il pcus, e sullo stesso Leonid Breznev (citato cinque volte), definiti esempio e guida per la Rdt e gli altri Paesi socialisti.
da La Stampa, mercoledì 19 Maggio 1976
L’universo pittorico di Bellini è un inno, un ditirambo alla gioia di vivere.
da Repubblica 13 dicembre 2018
Il termine ditirambo è attestato in italiano dal 1551 e deriva dal latino dithyrambu(m) a sua volta dal greco antico διθύραμβος (dithýrambos) di etimo incerto e di origine probabilmente preellenica (pelasgica). Quest’ultimo compare per la prima volta in Archiloco[1] che lo descrive come un canto a Dioniso ispirato dal vino. Inizialmente si trattava di una composizione che includeva musica, poesia e danza; eseguita da un coro diretto da un corifeo che rappresentava Dioniso.
- “ditirambo” in Vocabolario Online, Treccani. Web.
- “ditirambo” in Il Sabatini Coletti, in Corriere della Sera. Web.
- “ditirambo” in Dizionario Hoepli, in Repubblica. Web.
- “ditirambo” in Il nuovo De Mauro, in L’Internazionale. Web.
- “il ditirambo” (fr. 120 West) in Lurikoi, 26 aprile 2016. Web.
Immagine: La giovinezza di Bacco (1884), dipinto di William-Alphonse Bouguereau (1825 – 1905), Nationalmuseum (Stockholm) / Commons.
