(neologismo) la fortuna, la sensazione, la capacità di fare felici scoperte per puro caso e, anche, il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando un’altra. Deriva dalla italianizzazione del termine inglese serendipity, “parola d’autore” coniata nel XVIII secolo dallo scrittore inglese Horace Walpole, 4º Conte di Orford (1717 – 1797) e usata la prima volta in una lettera scritta il 28 gennaio 1754 a Horace Mann, un amico inglese che viveva a Firenze. La parola fu ispirata a Walpole dalla lettura della fiaba The Three Princes of Serendip nella quale i tre protagonisti, figli del re Giaffar di Serendip, trovano una serie di indizi che sono loro d’aiuto durante il cammino: scoperte descritte come intuizioni dovute sì al caso, ma anche all’acume e alla capacità di osservazione dei tre Prìncipi.
La fiaba citata da Walpole era la traduzione in inglese (attraverso una edizione francese) di un racconto italiano: Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, scritto da Cristoforo Armeno e pubblicato a Venezia nel 1537 dall’editore Michele Tramezzino. Il libro di Cristoforo Armeno era a sua volta la traduzione dal persiano del primo capitolo, il “padiglione nero”, del Hasht-Bihisht (Gli Otto Paradisi), poema di Amir Khusrow (vero nome: Ab’ul Hasan Yamīn ud-Dīn Khusrau, 1253–1325 CE) scritto intorno al 1302. La parola serendipità deriva quindi dal paese di “Serendip” (Serendippo, in arabo Sarandīb) che è l’antico nome persiano dell’attuale Sri Lanka, a sua volta (attraverso il latino Serendivis) dall’antico nome tamil Cerentivu, isola dei Cheras (una tribù locale).[1]
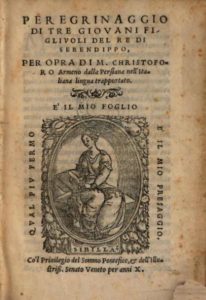
Cristoforo Armeno, Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, Venezia 1575
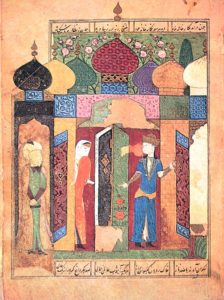
I “sette padiglioni”, illustrazione del XV secolo per il Hasht-Bihisht di Amir Khusrow.
Nella scienza si intende per serendipità il misto di casualità ed intuizione che porta il ricercatore a fare scoperte importanti mentre stava cercando altro. In economia la serendipità è una qualità riconosciuta, definita da Ikujiro Nonaka (professore emerito della Hitotsubashi University) come la capacità di «intercettare le riflessioni, intuizioni, impressioni personali dei singoli lavoratori e metterle al servizio dell’intera società, provandone l’efficacia nel contesto d’impresa» (“The Knowlege–Creating Company“, Harvard Businness Review (HBR), Nov.–Dic. 1991, p. 94).
- [1]Parameswaran, M. Early Tamils of Lanka — Ilankai Kuala Lumpur, 2000. P. 16. (Scribd)↩
Foto in alto: Jeonsango/Pixabay.
(verbo) spalmare, soprattutto in senso figurato, anche diffondere, disseminare, impiastricciare, palpare, spiaccicare, sporcare e simili, o anche fare in fretta, sorvolare sulla qualità; nella forma riflessiva (smarmellarsi): accasciarsi, ammosciarsi (Beccaria). Da marmellata, formato sul modello dei verbi parasintetici denominali con il prefisso s– (come in sbiancare), con richiamo metaforico all’atto di spalmare (come si farebbe con) la marmellata, e/o alla consistenza semiliquida, eterogena ed appiccicosa della stessa.
Il termine è stato usato dal 2007 al 2010 nella serie televisiva Boris come tecnicismo fittizio nel gergo professionale del set di una fiction, in particolare tra regista René Ferretti (interpretato da Francesco Pannofino) e il direttore della fotografia Duccio Patanè (Ninni Bruschetta). Nella finzione della serie il regista Ferretti era solito infatti chiedere al direttore della fotografia di “smarmellare”, ossia “aprire” al massimo i proiettori in modo che la luce si diffonda ovunque, soluzione luministica “facile” spesso adottata nelle produzioni televisive di largo consumo e qualità mediocre:
Renè: «Alfredo? Allora senti, è molto semplice: basito lui, basita lei. Macchina da presa fissa, luce un po’ smarmellata e daje tutti che abbiamo fatto.»
Da qui, è in seguito entrato davvero nel gergo cine-televisivo con riferimento alle luci ed anche nel linguaggio comune, con diversi significati a seconda del contesto.
Il lessico attinge a vari registri, e sono presenti anche forestierismi e tecnicismi legati prevalentemente all’ambito televisivo e cinematografico come “steady-cam”, “combo”, “fegatelli”, ma soprattutto il neologismo, già visto precedentemente e usato come pseudo tecnicismo, “smarmellare” che è diventato subito un tormentone linguistico…
Raffaella Tonin, Francesca La Forgia: “Il parlato delle serie televisive: il caso di Cuéntame e di Boris“ (2016)
La diffusione del neologismo smarmellare è sicuramente dovuta alla serie Boris (non ci sono occorrenze in rete prima del 2007), ma sicuramente era già usato anche in precedenza sebbene non comune. È utilizzato infatti già nel 1994 da Tommaso Labranca con il significato di palpeggiare:
E mentre suggevo il finnico banano di Hans, il compare mi smarmellava il rigoglioso tettame.
Tommaso Labranca Andy Warhol era un coatto. Vivere e capire il trash (1994)
- Grossman, Maria, Franz Rainer et al. La formazione delle parole in italiano. De Gruyter, 2004. Pag. 173.
- Tonin, Raffaella e Francesca La Forgia: “Il parlato delle serie televisive: il caso di Cuéntame e di Boris” Università di Bologna, 2016.
- Beccaria, Gianluigi L’italiano in 100 parole. BUR, 2015.
- Moz, Lorenzo “Luminìstica” in Moz, 2016. Web.
Foto in alto: Jonathan Pielmayer / Unsplash
(dall’inglese, lett. “copia di neve”) catch structure, particolare tipo di cliché consistente nel riuso della struttura di una frase ben nota (es. una citazione o uno slogan), modificata per essere adattata ironicamente ad un nuovo contesto o per creare un nuovo messaggio differente da quello originale. La frase originale, pur modificata nei termini, resta riconoscibile nel pattern (es: «50 sfumature di grigio» → «50 sfumature di vino») sfruttando così la popolarità dell’enunciato originale. La facilità con cui è possibile creare infinite varianti scherzose, porta però all’abuso di questo modello e di conseguenza alla mancanza di originalità.
L’espressione snowclone fu coniata nel 2004 dal professore di economia e sceneggiatore televisivo Glen Withman in risposta al linguista Geoffrey K. Pullum relazione ad un caso specifico, ossia una frase apparsa su The Economist dell’11 ottobre 2003:[1]
Con questa affermazione, basata su una leggenda metropolitana secondo la quale il vocabolario degli eschimesi avrebbe 40, 50 o addirittura 100 parole (a seconda delle versioni) per descrivere la neve, l’autore intendeva scherzare sulla presunta attitudine tedesca allo zelo, suggerendo che se per gli eschimesi la neve è tanto importante da avere numerosi vocaboli per descriverla, allora per lo stesso motivo i tedeschi dovrebbero avere molte parole per la Bürokratie (sottinteso: essendo questa la loro principale preoccupazione). A parte il fatto che non è vero che gli eschimesi abbiano così tante parole per descrivere la neve, è vero però che sostituendo i “tedeschi” con qualunque altro popolo, gruppo o categoria di persone, e la “burocrazia” con qualunque concetto cui questo gruppo si ritiene debba essere particolarmente interessato, è possibile replicare il modello all’infinito. Si legge infatti, ad esempio, su Edmonton Sun nel 2007:
Si tratta quindi di un phrasal template[3] o catch structure,[4] cioè una struttura dalla quale si possono generare nuove frasi ad effetto semplicemente sostituendo alcune parole al suo interno.
Pullum rilevava che, se il modello «se gli eschimesi hanno N parole per la neve, allora…» era un espediente molto frequente tra gli «scrittori privi di immaginazione»,[5] non era l’unico esempio: identificò ad esempio una infinità di varianti del celebre slogan «Nello spazio nessuno può sentirti urlare» del film Alien del 1979 mentre Glen Withman registrò nel 2004 un uso smodato della formula «X is the new Y», derivata probabilmente dall’errata citazione di una frase della celebre giornalista di moda Diana Vreeland («I adore that pink! Is the navy blue of India» New York Times, marzo 1962[6]); che nel 2013 avrebbe generato anche il titolo di una popolare serie TV, Orange is the new black. In questo caso si vuole suggerire che la nuova tendenza (“X”) abbia sostituito un classico (“Y”): ad esempio, «rock is the new jazz» (The Guardian, 31/03/2017).
Il problema di queste frasi-clone è che sono spesso talmente ritrite da non essere più né originali, né divertenti, tanto che Pullum le definì «frasi in kit per scrittori pigri»[6] o ancora «cliché adattabili da montare».[7] Queste locuzioni erano però troppo lunghe e Pullum rilevava la mancanza di un termine preciso (e conciso) per definire «un’espressione o frase multi-uso, personalizzabile, immediatamente riconoscibile e ben rodata che, citata a proposito o a sproposito, può essere utilizzata in una gamma illimitata di varianti scherzose da giornalisti e autori dotati di scarsa inventiva».[6] La parola cliché è infatti troppo generica (è cioè un “iperonimo”), perché si tratta di un particolare tipo di cliché, ma non è nemmeno una “allusione letteraria”, perché «queste cose non hanno alcun modo di essere [considerate] letterarie».[6]
Fu quindi Glen Withman sul blog Agoraphilia a proporre il termine snowclone[8][9] letteralmente “clone di neve”, evidente allusione alla frase «se gli eschimesi hanno N parole per la neve…» da cui aveva avuto inizio la discussione. Con la “benedizione” di Pullum, snowclone divenne il nome comune di questo tipo di cliché: «Hearing no other nominations, I now hereby propose that they be so dubbed. The clerk shall enter the new definition into the records».[9] La voce snowclone è stata in seguito registrata da Wikipedia (in inglese) il 4 novembre 2005.
Esempi
Anche la lingua italiana corrente, soprattutto nell’uso giornalistico, presenta svariati snowclone. Ad esempio:
- se gli eschimesi hanno [N/molte] parole per la neve, allora … – lo snowclone per antonomasia è ampiamente utilizzato anche in italiano: «gli eschimesi hanno molte parole per la neve come gli irlandesi per la pioggia» (da una guida turistica).
- 50 sfumature di… qualunque cosa: dal titoli dei romanzi della trilogia 50 sfumature (Fifty Shades) di E.L. James, da cui furono tratti tre film omonimi.
- ed è subito… es. «ed è subito teatro»: dalla citazione della poesia Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo (1930).
- è…, bellezza! es. «È la cultura, bellezza!» (Repubblica, 27-12-2008 ), da una battuta del film L’ultima minaccia (Deadline – U.S.A. 1952, regia di Richard Brooks): «È la stampa, bellezza! La stampa! E tu non ci puoi far niente! Niente!»
- …, chi era costui? Dalla citazione di una battuta di Don Abbondio ne I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: «Carneade! Chi era costui?»
- …? No grazie! Dal motto del Movimento Anti-Nucleare: «Energia nucleare? No grazie» (1975).
- …, questo sconosciuto. Dal titolo del saggio di Alexis Carrel: L’uomo, questo sconosciuto (1935).
Note
- [1]Language Log, 21/10/2003 (op. cit.)↩
- [2]cit. in McFedries (op.cit)↩
- [3]Liberman in Language Log, 15/01/2004 (op. cit.)↩
- [4]Crystal, David, The Encyclopedia of the English Language Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 178.↩
- [6]Pullum in Language Log, 27/10/2003 (op. cit.) Pullum in Language Log, 27/10/2003 (op. cit.)↩
- [6]cit. in Zimmer, Benjamin“On the trail of ‘the new black’ (and ‘the navy blue’)” in Language Log, 28/12/2006↩
- [7]«some-assembly-required adaptable cliché frame», che riprende la dicitura some assembly required (necessita di assemblaggio) spesso riportata sulle confezione dei kit di montaggio. Cfr. Pullum in Language Log, 16/01/2004 (op. cit.)↩
- [8]Whitman in Agoraphilia (op. cit.)↩
- [9]Pullum in Language Log, 16/01/2004 (op. cit.)↩
Bibliografia e fonti
- E. C. Traugott in AA.VV. Grammaticalization – Theory and Data. John Benjamins Publishing, 2014. Pag. 98.
- “Pilling cliché upon cliché – the snowclone” in New Scientist, vol. 192, 2006. Pag. 80.
- McFedries, Paul The complete idiot guide to weird word origins: over 500 strange stories of the world’s oddest word and phrases. Penguin, 2008. Pag. 167-168. ISBN 978-1592577811
- Pullum, Geoffrey K. “Bleached conditionals.” in Language Log. University of Pennsylvania. 21/10/2003. Web.
- Pullum, Geoffrey K. “Phrases for lazy writers in kit form” in Language Log. University of Pennsylvania. 27/10/2009. Web.
- Liberman, Mark. “Phrases for lazy writer in kit form are the new clichés” in Language Log. University of Pennsylvania. 15/01/2004. Web.
- Whitman, Glen “Snowclones” in Agoraphilia. 16/01/2004. Web.
- Pullum, Geoffrey K. “Snowclones: lexicographical dating to the second.” in Language Log. University of Pennsylvania. 16/01/2004. Web.
Foto in alto: Pxhere [PD].
